Pubbl. Mar, 4 Feb 2025
Lo sviluppo del diritto ecclesiastico comparato
Modifica pagina
Giovanni Margherita
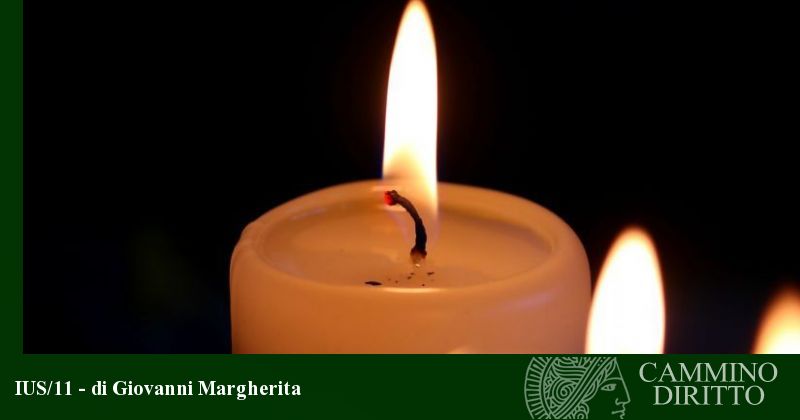
La regolamentazione del diritto ecclesiastico ha subìto notevoli sviluppi rispetto alle epoche storiche che andavano ad avvicendarsi. La maggiore difficoltà che si è riscontrata è stata quella di ricercare all’interno di un ordinamento già compiuto, come quello italiano, un posto di favore nel notevole sviluppo normativo preesistente. Se i diritti interni all’ordinamento, si pensi al diritto penale, civile, amministrativo, possiedono codici sviluppati e ammodernati rispetto all’esigenze dei tempi, il diritto ecclesiastico non possiede tali strumenti ma ha bisogno di vitalità acquisendola dalle norme già costituite dell’ordinamento, specie in ambito costituzionale.
 ENG
ENG
The develompent of comparative ecclesiastical law
The regulation of ecclesiastical law has undergone significant developments in relation to the historical periods that have succeeded one another. The greatest difficulty encountered has been finding a favorable position within an already established legal system, such as the Italian one, amidst the considerable pre-existing regulatory framework. While internal branches of the legal system—such as criminal, civil, and administrative law—have developed and modernized codes in response to the needs of the times, ecclesiastical law lacks such instruments and requires vitality by drawing from the already established norms of the legal system, particularly in the constitutional sphere.Sommario: 1. Cenni sul diritto ecclesiastico comparato; 1.2 L’evoluzione del diritto ecclesiastico comparato in Italia; 1.3 I princìpi fondamentali dell’ordinamento italiano e il diritto ecclesiastico; 1.3.1 Le fonti del diritto ecclesiastico; 2. I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche; 2.1 Il quadro costituzionale e normativo; 2.2 L’evoluzione storica del rapporto tra Stato e confessioni non cattoliche; 2.2.1 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948; 2.2.2 La fase delle intese (dal 1984 a oggi); 2.2.3 Le confessioni senza intesa e le criticità del sistema; 3. L’influenza della riserva di legge rinforzata sulla “circolazione dei modelli” giuridici nel diritto ecclesiastico italiano; 3.1 La riserva di legge rinforzata: definizione e implicazioni; 3.2. Il confronto con altri modelli giuridici; 3.3 Tra tutela della libertà religiosa e rigidità normativa; 4. Conclusione.
1. Cenni sul diritto ecclesiastico comparato
Negli ordinamenti statali è possibile riconoscere un insieme di norme dedicato alla regolamentazione giuridica del fenomeno religioso. In alcuni sistemi giuridici, questo insieme di norme viene a costituire oggetto di studio di una disciplina scientifica autonoma che prende il nome di diritto ecclesiastico o diritto statale delle religioni.
Il diritto ecclesiastico è una scienza che si preoccupa di comparare i diversi ordinamenti giuridici; nasce come disciplina moderna, rispetto a molte altre, grazie al manuale di Emilio Friedberg “Trattato di Diritto Ecclesiastico cattolico ed evangelico” poi riveduto e aggiornato con il diritto italiano da Francesco Ruffini. Dalla sua pubblicazione sino all’attuale modernità, i maggiori esponenti ecclesiastici hanno formulato molteplici riflessioni circa la comparazione con il diritto canonico e con altri diritti religiosi affacciandosi nei riguardi della comparazione inter ordinamentale tra i diversi diritti statali.
È importante notare quanto il rapporto tra diritti statali e religioni vivono nell’attualità un momento di riviviscenza soprattutto per interessi comuni, anche in paesi in cui fino a qualche anno fa si sottolineava solo una sorta di convivenza “forzata” e mai pacifica. Grazie a ciò si è incanalato il diritto ecclesiastico comparato[1], ramo scientifico degli studi di diritto ecclesiastico che si occupa anch’esso della scienza del diritto comparato nell’ambito dello studio del diritto.
Il diritto comparato, in dottrina, ha rivestivo differenze sostanziali circa il suo approccio nell’universo giuridico: alcuni teorizzano che il diritto comparato costituisce una scienza autonoma, altri credono che in questo diritto sia possibile ricercare soltanto un metodo, appunto comparativo. Sia negli uni che negli altri è sottintesa una verità, quantomeno funzionale di questo diritto: è impossibile immaginare il diritto comparato come ad un insieme di norme a sé stanti che formino un intero ordinamento. Il diritto ecclesiastico comparato[2], come qualsiasi altro diritto in comparazione con altri, sottoscriverà il proprio oggetto e metodo di studio nel più vasto diritto che è quello ecclesiastico, servendosi di esso e facendo in modo di rappresentare, nell’incontro con altri diritti, l’intero sistema ordinamentale di cui fa parte.
La comparazione tra diritti ecclesiastici implica «il raffronto del settore normativo concernente la regolamentazione giuridica del fenomeno religioso di due o più ordinamenti statali al fine di ricercarne le differenze e le concordanze»[3].
Si è detto che il diritto ecclesiastico costituisce una parte dell’intero ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso. Per fenomeno religioso si intende quell’insieme di credenze dell’uomo che sono fondate sull’idea del sacro e del divino. Nonostante sia una realtà umana, o meglio individuale, il fenomeno religioso coinvolge anche le formazioni sociali in cui si sviluppa il dato religioso, cioè le comunità dei credenti. È interessante notare come in altri Paesi, diversi dall’Italia, i temi riguardanti il fenomeno religioso sono inseriti in altri ambiti di ricerca quali il diritto pubblico, amministrativo o privato; in Italia, e nei vari paesi di civil law, queste tematiche sono trattate in maniera autonoma in quanto portatrici di propri metodi e oggetti di studio.
Il diritto ecclesiastico in Italia si presenta come una parte del diritto interno in quanto sono presenti in esso norme vigenti nell’ordinamento statale; si presenta come un ramo del diritto pubblico contemplando i diritti soggettivi pubblici che spettano a persone fisiche o giuridiche che vivono nel complesso statale. Proprio per questo motivo, il diritto ecclesiastico viene ad instaurare all’interno dell’ordinamento statale un vero rapporto di interessi comuni con altre branche del diritto: per citare alcuni esempi, si pensi al diritto internazionale per quanto concerne le norme sulle convenzioni sui diritti dell’uomo, il diritto costituzionale, il diritto civile che disciplina gli enti ecclesiastici, il diritto penale, il diritto del lavoro, il diritto amministrativo.
Concludendo questo primo approccio al diritto ecclesiastico è bene sottolineare le fondamentali differenze che intercorrono tra esso e il diritto canonico. Il diritto canonico studia gli elementi che formano la struttura del diritto della Chiesa cattolica come ordinamento giuridico; il diritto ecclesiastico, invece, studia nel complesso i diversi ordinamenti giuridici in rapporto con la religione cattolica e i principi con cui tali ordinamenti si ispirano in rapporto alla religione stessa.
1.2 L’evoluzione del diritto ecclesiastico comparato in Italia
La dottrina giuridica, guardando all’evoluzione in Italia del diritto ecclesiastico comparato[4], ha da sempre suddiviso l’intera argomentazione in diverse fasi di sviluppo che hanno interessato diversi momenti nel panorama italiano.
La prima fase coincide con la nascita e l’origine del diritto ecclesiastico che, solo dopo la fine dell’800, assunse corpo a sé, staccandosi dal diritto canonico con cui era sostanzialmente legato. L’origine di questa simbiosi tra i due diritti è ripercorribile sotto il duplice profilo politico-legislativo dello Stato liberale: la soppressione delle facoltà statali di teologia e l’istituzione di cattedre di diritto ecclesiastico nelle facoltà giuridiche. A queste facoltà fu affidato il compito di studiare l’intero sistema di norme giuridiche, relative alla Chiesa, emanate dall’autorità ecclesiastica. Le norme dello Stato e del diritto della Chiesa iniziarono pian piano a mescolarsi formando idealmente un ponte comunicativo tra i due ordinamenti e creando, in questo modo, un groviglio di metodi e di contenuti portato a maturazione soltanto dopo il Concordato Lateranense e il suo declino dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II. La netta distinzione dopo il Concilio causò il distanziamento tra canonisti ed ecclesiasticisti che arrivò fino all’illustre lavoro di metodo, per entrambe le discipline, di alcuni grandi maestri del secolo scorso, Francesco Ruffini, Arturo Carlo Jemolo, Pietro Agostino d’Avack, che riuscirono ad influenzare, sul piano interdisciplinare, l’orientamento legislativo in Italia e le scuole giuridiche occidentali. Un’illustre canonista, Pio Fedele, già nel suo “Archivio di Diritto Ecclesiastico” del 1942, sottolineando le divergenze di idee tra canonisti ed ecclesiasticisti, espresse la possibilità di un “fruttuoso commercio” tra gli stessi e ciò
non derivava tanto dalla volontà di manifestare la “superiorità” della scienza canonistica laica rispetto a quella ecclesiasticista, ma dalla necessità che anche i cultori del diritto canonico ecclesiastici si rendessero protagonisti del fermento scientifico provocato dalla canonistica laica e trasmettitori dell’importanza dello “spirito critico”, [...], nell’affrontare lo studio dello ius Ecclesiae.[5
La seconda fase del percorso italiano è caratterizzata da «primi indizi di maturazione scientifica, in opere destinate solo in parte ad illustrare il diritto straniero»[6], dedicate al diritto interno italiano. Tale esperienza segna la netta distinzione con il precedente modo di intendere il diritto ecclesiastico e inizia a intravedere nei caratteristici scopi della comparazione giuridica un motivo valido per uscire dall’hortus conclusus in cui il diritto si era annidato. Motore di tale innovazione fu essenzialmente quello di progredire verso l’analisi delle diverse esperienze[7] e di alcuni importanti temi affrontati dal diritto ecclesiastico, nonché dalla riscoperta del rapporto tra Chiesa e Stato fino ad allora adombrato da vecchi ideologismi.
Nella terza fase di evoluzione, la comparazione iniziò ad essere influenzata da fattori diversificati tra di loro, dall’interesse delle diverse branche del diritto rispetto alla natura dello Stato della Città del Vaticano, sino alla disputa del metodo da seguire per il diritto canonico insegnato nelle università statali. Fondamentale fu la portata dell’art. 7 Cost. così come richiamato dai Patti Lateranensi
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Attorno al nucleo di questa norma si svilupparono nuovi metodi di indagine circa i principi generali comuni e alla costruzione di principi di teoria generale che raffinarono la ricerca comparatistica in materia ecclesiastica.
La quarta fase di comprensione del fenomeno comparativo in Italia vede l’avvio di vere riflessioni metodologiche circa l’interesse della comparazione nell’ambito del diritto ecclesiastico. Si incontra la necessità di attribuire al metodo comparativo la fonte in cui innestare i vari rapporti nati tra ordinamenti con l’unico diritto ecclesiastico. La peculiarità di tale ricerca evidenzia che tale settore è «per sua natura comparativo […] avendo ad oggetto necessariamente i rapporti […] tra l’ordinamento dello Stato e quelli delle confessioni religiose»[8]. Con ciò viene ad inquadrarsi la vera natura del diritto ecclesiastico e del suo metodo comparativo che non solo dispiega le diverse modalità di approccio tra confessioni religiose e ordinamenti ma mantiene viva la necessità di un approccio che tiene conto delle peculiarità e similitudini di ciascuno.
La quinta ed ultima fase rappresenta l’odierno panorama del diritto ecclesiastico che, dopo aver definito la metodologia e le tecniche di indagine, è caratterizzata dal richiamo della comparazione legata alla tutela sovranazionale della libertà religiosa. Concludendo, «il diritto comparato costituisce indubbiamente una fonte di ispirazione essenziale e primaria per la Corte»[9] soprattutto riguardo i rapporti che si celano tra diritto e religione.
1.3 I principi fondamentali dell’ordinamento italiano e il diritto ecclesiastico
All’interno dell’ordinamento italiano vengono ad assumere particolare rilievo alcuni principi fondamentali che esprimono le finalità e le basi ideali della forma di Stato democratico desunta dalla Costituzione che sono a tutela della libertà della persona.
Il diritto ecclesiastico, quale branca interna dell’intero ordinamento statale, si serve di alcuni principi ordinamentali per fondare il proprio oggetto di studio e il proprio campo di indagine e ricerca. I principi[10] che interessano il diritto ecclesiastico sono sostanzialmente tre: la libertà religiosa, il principio di laicità dello Stato[11], il principio pattizio.
Il primo fondamentale principio novellato all’art. 19 della Costituzione sancisce la libertà religiosa.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
L’articolo in oggetto intende tutelare non soltanto la libertà individuale rispetto ai quesiti fondamentali sul senso dell’esistenza come sentimento religioso, ma garantisce legittima tutela anche nei riguardi di convinzioni circa l’inesistenza di una realtà trascendente o di chi essenzialmente dubita di tutto ciò. La libertà religiosa, essendo un concetto vasto, ricopre gli interessi non soltanto individuali ma anche collettivi come il proselitismo e l’esercizio del culto sia privato che pubblico. L’unico limite attribuibile a tale principio riguarda le manifestazioni pubbliche del culto, i cosiddetti riti, che non possono essere contrari al buon costume, rispetto ai valori della morale pubblica.
La libertà religiosa è tutelata dalla Costituzione italiana all’art. 20 di cui
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
L’articolo in oggetto vieta l’obbligo di limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali agli enti, per il solo fatto di essere a carattere ecclesiastico o per il loro fine religioso; tale limitazione viene assicurata a tutti gli enti religiosi a tutela dell’uguaglianza della libertà di fede.
Il secondo principio da prendere in esame è il concetto di laicità dello Stato, un principio dell’ordinamento che caratterizza la forma di Stato repubblicana. Il contenuto del suddetto principio, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., non implica indifferenza da parte dello Stato rispetto al fenomeno religioso ma tutela e salvaguarda la libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale.[12] La laicità dello Stato italiano non corrisponde ad un mero scetticismo delle realtà religiose ma si pone a servizio del bene comune e del favore pubblico riguardo una coscienza civile diversa rispetto agli individui che in essi si trovano. La libertà religiosa viene a coniugarsi necessariamente con alcuni corollari fondamentali per l’esercizio di essa: la distinzione degli ordini, sancita dall’art. 7 comma uno e dall’art. 8 comma due Cost., in cui «lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» e «le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi, […] in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano»; all’art. 8 comma uno Cost. si afferma l’equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose, per cui «tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge», da questo principio deriva il divieto di discriminazione contenuto all’art. 3 Cost. nei riguardi di tutti i culti presenti all’interno della penisola italiana; non da ultimo il corollario della libertà di coscienza che ha ricevuto riconoscimento anche a libello sovranazionale, sia all’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo[13], sia all’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.[14]
L’ultimo principio è quello pattizio sviluppato in due articoli della Costituzione, rispettivamente l’art. 7 comma due[15] e l’art. 8 comma tre[16]. Queste norme regolano le materie in cui non si trova una esclusiva competenza dello Stato o delle confessioni religiose e per convergere debbono essere regolate in modo bilaterale. I rapporti con la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi, mentre quelli con le diverse confessioni religiose vengono regolati per mezzo di intese che non sono altro che convenzioni di diritto pubblico interno.
1.3.1 Le fonti del diritto ecclesiastico
L’insieme delle norme che scandiscono il fenomeno religioso nelle sue diverse stratificazioni si presenta articolato e complesso. Ciò non deve in alcun modo risultare estraneo in quanto attorno alle espressioni della religione si sono aggregate molteplici forme di resistenza verso l’innovazione e il mantenimento che hanno caratterizzato il fenomeno nel corso della storia. Tale resistenza nasce dall’estraneità dell’ordinamento dello Stato rispetto al fenomeno religioso e quindi dalla difficoltà di trovare soluzioni idonee rispetto ad una proficua relazione tra ordinamenti.
In dottrina si sono proposti diversi criteri di classificazione delle fonti del diritto ecclesiastico.
Il primo tra i criteri è quello storico, nel quale, in base al momento in cui furono prodotte le norme, possono essere collocate all’interno di due grandi momenti storici: fascista e repubblicano, periodi fondamentali per il fenomeno religioso e per il suo attecchimento sul terreno fertile dell’ordinamento statale. Il legislatore fascista ha dato avvio ad un’ampia produzione normativa soprattutto racchiusa in due grandi codici, civile e penale, con riferimenti espliciti al diritto ecclesiastico. Un momento decisivo per l’avvio del diritto ecclesiastico all’interno della legislazione statale fu quello dell’11 febbraio 1929 con l’esecuzione del Trattato e Concordato lateranense e alla normativa sui culti ammessi dalle confessioni religiose diverse dalla cattolica. All’art. 1 del Concordato lateranense si esplicita che
L’Italia, ai sensi dell’art. 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato; ove occorra, accorda agli ecclesiastici per gli atti del loro ministero spirituale la difesa da parte delle sue autorità.[17
Riguardo il secondo momento in cui il diritto ecclesiastico prese vigore, fu quello repubblicano con la sua Costituzione; all’interno di essa vi sono numerose disposizioni in materia religiosa in cui si menziona tale libertà già richiamati nel paragrafo precedente. Un articolo in particolare racchiude il termine “libertà” in tutte le sue articolazioni.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. art. 29, 31, 37 co. 1, 48 co. 1, 51], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. art. 8, 19, 20], di opinioni politiche [cfr. Art. 21, 49], di condizioni personali e sociali.[18]
Il secondo criterio di classificazione, secondo la dottrina più accreditata, è affiancabile al primo criterio in quanto riferibile al rapporto politico-culturale delle norme. Stando a tale rapporto, è stato suddiviso in due filoni: confessionista e regalista. Il filone confessionista è di gran lunga evidente nella legislazione del periodo fascista soprattutto in riferimento alla normativa presente nel codice penale a tutela della religione di Stato. Riguardo, invece, il filone regalista, esso traspare nella legislazione del 1929/30 rispetto i culti ammessi in cui sussiste un forte atteggiamento di controllo dello Stato sulla vita interna delle confessioni religiose.
Il terzo criterio, stando all’impulso derivato dalla dottrina, suddivide le norme secondo la loro origine sostanziale: fonti di origine unilaterale statale, come ad esempio la legge sull’obiezione di coscienza al servizio militare sancita con l. 230/98[19]; fonti di origine unilaterale confessionale che per volontà dello Stato possono produrre effetti direttamente nell’ordinamento statale; fonti di derivazione pattizia che derivano dall’attività convenzionale dello Stato con le confessioni religiose, secondo l’art. 7 comma due e l’art. 8 comma tre Cost.
Il quarto criterio corrisponde al consueto metodo di classificazione secondo il riferimento alle fonti di cognizione e fonti di produzione. Le fonti di cognizione del diritto ecclesiastico civile si ritrovano all’interno di disposizioni legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente, sia bilateralmente tramite accordi con le confessioni religiose. Le fonti di produzione, invece, si pongono su livelli differenti e il più delle volte risultano problematiche. Bisogna tener presente che, nel quadro generale normativo, la fonte può essere sia legge ordinaria che legge costituzionale; si tratta di norme che, essendo emanate dalla legge di esecuzione dei Patti lateranensi o da leggi che danno esecuzione ad intese con le confessioni religiose minoritarie, sono protette dagli artt. 7-8 Cost. Queste norme possono essere modificate solo con legge ordinaria se queste daranno esecuzione ad un nuovo accordo, altrimenti bisognerà ricorrere all’emanazione di una legge costituzionale. Per il settore non garantito dagli articoli costituzionali 7 e 8, la legge ordinaria è la fonte principale della produzione di norme di diritto ecclesiastico.
Il livello inferiore è composto dalle norme regolatrici dettate con decreto del Presidente della Repubblica, prima con Regio decreto. Questi provvedimenti disciplinano le modalità di applicazione delle norme di legge e devono necessariamente essere conformi ad esse. Scendendo di livello, vi si trovano le norme interne della pubblica amministrazione, le cosiddette circolari, che impongono agli uffici inferiori delle norme di azione in base al principio gerarchico sempre rimanendo conformi alla legge e ai regolamenti.
Quanto sin qui detto vale anche per l’ordinamento canonico nonostante nel Concordato manchi l’espressa menzione che riconosce la vigenza in Italia del diritto canonico. Di fatto, il riconoscimento di sovranità sancito all’art. 7 della Costituzione non sta a significare che lo Stato riconosce automaticamente vigenti nel proprio ordinamento tutte le norme canoniche ma soltanto che lo Stato non è legittimato a sindacare gli interna corporis dell’istituzione ecclesiastica.
2. I rapporti tra lo stato italiano e le confessioni religiose non cattoliche
I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica rappresentano un aspetto fondamentale del diritto ecclesiastico italiano. La Costituzione del 1948 ha sancito il principio di uguaglianza tra tutte le confessioni religiose, superando il precedente sistema che riconosceva un primato alla Chiesa cattolica. Tuttavia, la regolamentazione di tali rapporti si basa su un sistema pattizio, caratterizzato dalla necessità di stipulare intese bilaterali tra lo Stato e le singole confessioni religiose. Questo meccanismo, se da un lato garantisce un dialogo diretto tra le parti, dall’altro ha creato una differenziazione tra confessioni con intesa e senza intesa, con conseguenze significative in termini di riconoscimento giuridico e di diritti.
2.1 Il quadro costituzionale e normativo
L’articolo 8[20] della Costituzione italiana rappresenta la norma di riferimento per la regolamentazione delle confessioni religiose non cattoliche. Esso sancisce tre princìpi fondamentali:
- Uguaglianza tra tutte le confessioni religiose (comma 1), affermando che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.
- Autonomia organizzativa (comma 2), stabilendo che “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”.
- Regolazione dei rapporti con lo Stato attraverso intese bilaterali (comma 3), specificando che “I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
A questi principi si aggiungono altre norme costituzionali fondamentali, come l’articolo 19[21], che garantisce la libertà di culto, e l’articolo 20[22], che vieta discriminazioni legislative o fiscali nei confronti degli enti religiosi.
2.2 L’evoluzione storica del rapporto tra Stato e confessioni non cattoliche
2.2.1 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione del 1948
Prima dell’entrata in vigore della Costituzione del 1948, il rapporto tra Stato e confessioni religiose era fortemente sbilanciato a favore della Chiesa cattolica. Lo Statuto Albertino del 1848 dichiarava il cattolicesimo come “unica religione di Stato” (religione licita), mentre le altre confessioni erano semplicemente “tollerate”. Questa impostazione rimase invariata anche durante il periodo fascista, con la legge sui culti ammessi del 1929-30, che subordinava le confessioni non cattoliche a un regime di autorizzazione statale.
La Costituzione del 1948 rappresentò una svolta epocale, affermando il principio di uguaglianza tra le confessioni religiose e introducendo il sistema delle intese per regolare i rapporti con lo Stato. Tuttavia, per diversi decenni, le confessioni diverse dalla cattolica continuarono a essere soggette alla legge sui culti ammessi del 1929, poiché il sistema delle intese fu attuato solo a partire dagli anni ‘80.
2.2.2 La fase delle intese (dal 1984 a oggi)
Il sistema delle intese iniziò a prendere forma con la revisione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica nel 1984. Questo accordo eliminò il principio della “religione di Stato”, comunemente definita religio licita aprendo la strada alla regolamentazione delle confessioni non cattoliche su basi paritarie. La prima intesa fu stipulata nel 1984 con la Tavola Valdese, seguita negli anni successivi da altre confessioni.
Questo processo ha comportato un’evoluzione significativa nel panorama giuridico italiano, rendendo più strutturato il rapporto tra Stato e confessioni religiose.
A tal proposito si ricorda che le intese, infatti, regolano aspetti fondamentali della vita religiosa, tra cui il riconoscimento giuridico, le attività di culto, il trattamento fiscale, l’insegnamento religioso nelle scuole e l’accesso ai finanziamenti pubblici, come l’8x1000. Grazie a questo sistema, le confessioni religiose con intesa godono di un riconoscimento più ampio e di una maggiore tutela giuridica.
Tuttavia, la procedura per la stipula di un’intesa è spesso lunga e complessa. Le confessioni devono presentare una richiesta formale al Governo, che avvia le trattative e, in caso di esito positivo, trasmette l’intesa al Parlamento per l’approvazione definitiva. Questo iter ha portato a una situazione denigratoria in cui alcune confessioni religiose sono riuscite a ottenere un’intesa rapidamente, mentre altre attendono da anni senza esito positivo. Tra le confessioni che hanno ottenuto un’intesa, si ricordano:
- Chiesa Evangelica Valdese (1984)
- Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno (1986)
- Assemblee di Dio in Italia (ADI) (1986)
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (1987)
- Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (1993)
- Luterani (1995)
- Comunità Buddista Italiana (2000)
- Unione Induista Italiana (2000)
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (mormoni) (2007)
- Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (Patriarcato di Costantinopoli) (2012)
Nonostante i progressi compiuti, il sistema delle intese presenta ancora criticità, in particolare per quanto riguarda la difficoltà di accesso per nuove confessioni religiose e la mancata previsione di un meccanismo automatico di aggiornamento. Inoltre, la lentezza burocratica ha portato a situazioni di disparità tra comunità religiose consolidate e nuove realtà emergenti, che spesso operano senza un riconoscimento ufficiale.
2.2.3 Le confessioni senza intesa e le criticità del sistema
Nonostante il sistema delle intese sia stato concepito per garantire la parità tra le confessioni religiose, molte comunità religiose operano ancora senza un'intesa con lo Stato. Tra queste vi sono: la maggior parte delle comunità musulmane; alcune comunità evangeliche e pentecostali; alcune confessioni cristiane orientali e gruppi religiosi minori.
L’assenza di un’intesa comporta per queste confessioni una serie di limitazioni, tra cui:
- L’impossibilità di accedere ai fondi dell’8x1000, che rappresentano una fonte di finanziamento cruciale per molte confessioni religiose. Senza un’intesa, queste comunità non possono beneficiare di tali risorse, limitando la loro capacità di sostenere attività di culto e iniziative sociali.
- La mancata regolamentazione del matrimonio religioso con effetti civili, il che significa che i matrimoni celebrati da ministri di culto di queste confessioni non hanno automaticamente valore legale e devono essere seguiti da una cerimonia civile per essere riconosciuti dallo Stato.
- Difficoltà nell’ottenere il riconoscimento giuridico per le proprie strutture di culto, con conseguenti problemi burocratici legati alla proprietà e all’uso degli edifici destinati al culto. Questo può comportare la necessità di ricorrere a espedienti legali, come l’iscrizione delle strutture come associazioni culturali anziché luoghi di culto.
- Un trattamento fiscale meno favorevole rispetto alle confessioni con intesa, che si traduce in una maggiore pressione economica per le comunità religiose senza intesa, costrette a sostenere oneri fiscali più elevati per l’acquisto o la gestione di immobili e attività connesse alla pratica religiosa.
Questa situazione crea una disparità di trattamento tra confessioni religiose che potrebbe essere vista come una violazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Inoltre, la mancanza di un’intesa rende più difficile per queste confessioni operare sul territorio italiano, soprattutto in termini di gestione amministrativa e di accesso a benefici pubblici.
Una delle principali criticità riguarda le comunità musulmane, che rappresentano una delle realtà religiose più numerose in Italia ma che, a differenza di altre confessioni, non hanno ancora ottenuto un’intesa con lo Stato. Questo ha generato problemi di riconoscimento per i luoghi di culto e per il ruolo degli imam, oltre a ostacoli nella gestione delle pratiche religiose, come la celebrazione di matrimoni con valore civile.
Inoltre, come si è anzidetto, il processo per ottenere un’intesa è lungo e burocraticamente complesso, il che ha portato molte confessioni a rinunciare o a operare in forme associative di diritto privato, senza una regolamentazione specifica. Questo approccio, sebbene garantisca un certo grado di libertà, non fornisce alle comunità religiose senza intesa le stesse tutele e opportunità offerte alle confessioni che hanno completato il processo pattizio.
La necessità di una riforma del sistema delle intese è un tema sempre più discusso, con diverse proposte volte a semplificare il processo di riconoscimento e a garantire maggiore equità tra tutte le confessioni presenti sul territorio italiano. Tra le soluzioni proposte vi è stata l’adozione di una legge generale sulla libertà religiosa che superi il sistema delle intese e garantisca diritti uniformi a tutte le confessioni, indipendentemente dalla loro storicità o diffusione sul territorio nazionale.
3. L’influenza della riserva di legge rinforzata sulla “circolazione dei modelli” giuridici nel diritto ecclesiastico italiano
Come si è accennato nel paragrafo precedente, l’articolo 8 della Costituzione italiana introduce un meccanismo di tutela per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, sancendo il principio di uguaglianza, il diritto all’autonomia organizzativa e il sistema delle intese. Tuttavia, la scelta del legislatore costituente di vincolare i rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche a leggi approvate sulla base di intese bilaterali ha creato un sistema peculiare, caratterizzato da una riserva di legge rinforzata. Questo sistema influisce sulla “circolazione dei modelli” giuridici provenienti da altri ordinamenti, limitando la possibilità di adottare soluzioni normative già sperimentate all’estero senza un previo accordo con le confessioni interessate.
3.1 La riserva di legge rinforzata: definizione e implicazioni
L’articolo 8, comma 3, della Costituzione prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questo significa che non è possibile adottare norme unilaterali da parte dello Stato per disciplinare materie relative alle confessioni religiose, a meno che non si tratti di norme generali sulla libertà religiosa applicabili indistintamente a tutte le fedi e che le leggi di recepimento delle intese non possono essere modificate, abrogate o derogate senza un nuovo processo bilaterale.
Questa rigidità normativa ha due conseguenze principali:
- Difficoltà nell’adattamento dinamico del sistema normativo – Qualsiasi aggiornamento o riforma in materia di rapporti con le confessioni religiose richiede un lungo iter negoziale, rallentando l’adeguamento dell’ordinamento italiano ai cambiamenti sociali e giuridici.
- Minore permeabilità ai modelli giuridici stranieri – La necessità di negoziare singolarmente ogni intesa impedisce l’adozione rapida di soluzioni innovative adottate in altri Paesi, a differenza di ordinamenti in cui lo Stato può intervenire con atti normativi generali.
3.2. Il confronto con altri modelli giuridici
Nel diritto comparato esistono modelli alternativi di regolazione dei rapporti tra Stato e religioni, alcuni dei quali più flessibili rispetto a quello italiano.
Nel modello francese (laïcité rigida) vige una separazione netta tra Stato e religioni, basata sulla legge del 1905, che esclude il riconoscimento giuridico delle confessioni e non prevede intese. Questo sistema permette allo Stato di intervenire in maniera uniforme senza dover negoziare con ciascuna confessione, garantendo una laicità assoluta dello Stato ma limitando il riconoscimento ufficiale delle pratiche religiose.
Nel modello tedesco (sistema concordatario misto) la Germania prevede un modello intermedio, basato su concordati per la Chiesa cattolica e su contratti di diritto pubblico per le altre confessioni. Questo sistema consente un maggiore grado di adattabilità nel tempo rispetto al sistema italiano, permettendo alle confessioni di ottenere uno status giuridico riconosciuto senza dover attendere lunghi iter legislativi.
Nel modello anglosassone (sistema di common law), come il Regno Unito e gli Stati Uniti, non esiste un sistema di intese; la regolamentazione della libertà religiosa avviene prevalentemente tramite norme generali e giurisprudenza, garantendo maggiore flessibilità e adattabilità alle evoluzioni della società. Le istituzioni religiose sono generalmente considerate enti privati, con una netta separazione tra sfera pubblica e confessionale.
Il modello italiano si distingue da questi sistemi per la sua impostazione rigida e pattizia, che condiziona la capacità di recepire esperienze normative esterne. La necessità di intese specifiche per ogni confessione comporta un processo più lungo e meno flessibile, limitando l’adeguamento alle nuove realtà religiose emergenti nel contesto italiano. Una possibile riforma potrebbe ispirarsi ai modelli esteri, introducendo meccanismi più flessibili per il riconoscimento delle confessioni e la regolazione dei loro rapporti con lo Stato.
3.3 Tra tutela della libertà religiosa e rigidità normativa
Il sistema italiano, basato sulla riserva di legge rinforzata e sulle intese, rappresenta un modello unico che assicura una tutela formale della libertà religiosa ma che, al contempo, rallenta l’adattamento del diritto ecclesiastico ai cambiamenti della società. La difficoltà di recepire modelli giuridici stranieri senza una negoziazione bilaterale per ogni confessione religiosa può comportare un ritardo nell’adeguamento dell’ordinamento italiano alle nuove esigenze del pluralismo confessionale.
Una possibile soluzione potrebbe essere una maggiore flessibilità nel sistema delle intese, ad esempio prevedendo una regolamentazione generale per le confessioni non ancora riconosciute o meccanismi di aggiornamento più rapidi per le leggi derivanti dalle intese già stipulate. Questo permetterebbe di coniugare il rispetto del principio pattizio con una maggiore apertura ai modelli normativi sviluppati in altri ordinamenti.
In particolare, si potrebbe valutare l’introduzione di una disciplina generale della libertà religiosa che garantisca diritti fondamentali a tutte le confessioni senza necessità di un’intesa formale. Un altro possibile intervento riguarda la semplificazione delle procedure di stipula delle intese, riducendo i tempi burocratici e prevedendo strumenti di revisione periodica automatizzata. Inoltre, l’adozione di un modello più flessibile potrebbe agevolare il riconoscimento delle nuove comunità religiose emergenti, garantendo una maggiore equità tra le diverse confessioni presenti in Italia.
Queste riforme potrebbero contribuire a rendere il sistema italiano più dinamico e inclusivo, favorendo un equilibrio tra la tutela della libertà religiosa e la necessità di una regolamentazione chiara e uniforme nel rispetto della Costituzione.
4. Conclusioni
Il diritto ecclesiastico comparato rappresenta oggi una disciplina di straordinaria rilevanza, non solo per il panorama giuridico italiano ma anche per quello internazionale. Attraverso il suo sviluppo storico e metodologico, questa branca del diritto ha dimostrato come il fenomeno religioso non possa essere confinato a una dimensione puramente privata, ma debba essere riconosciuto come un elemento centrale delle dinamiche sociali e culturali. La disciplina, nata dalla necessità di comprendere e regolare i rapporti tra ordinamenti statali e confessioni religiose, ha assunto un ruolo di crescente importanza nell’affrontare le complesse sfide del pluralismo confessionale e della tutela dei diritti fondamentali.
Le fasi di evoluzione del diritto ecclesiastico comparato in Italia, analizzate nel documento, testimoniano un percorso di maturazione che ha permesso a questa materia di affermarsi come una scienza giuridica autonoma. Dalla sua origine, fortemente influenzata dalla separazione con il diritto canonico e dalle trasformazioni politiche dello Stato italiano, fino all’attuale centralità della comparazione a livello sovranazionale, il diritto ecclesiastico ha saputo adattarsi ai mutamenti sociali, giuridici e culturali.
Un aspetto cruciale è rappresentato dal ruolo della Costituzione italiana, che con i princìpi di libertà religiosa, laicità dello Stato e pattizio ha fornito le basi normative per uno sviluppo equilibrato e rispettoso delle peculiarità delle diverse confessioni religiose. Tali princìpi, approfonditi e applicati nel contesto del diritto ecclesiastico, hanno contribuito a definire un modello giuridico che promuove il dialogo tra Stato e religioni, garantendo allo stesso tempo l’autonomia e l’indipendenza reciproche.
La comparazione giuridica si rivela quindi uno strumento essenziale non solo per identificare le similitudini e le differenze tra gli ordinamenti, ma anche per promuovere una comprensione più profonda delle dinamiche che regolano i rapporti tra le diverse confessioni religiose e gli Stati. In un mondo sempre più globalizzato, il diritto ecclesiastico comparato svolge una funzione insostituibile nell’assicurare che i diritti fondamentali, come la libertà religiosa, siano adeguatamente tutelati sia a livello nazionale sia internazionale.
In questa prospettiva, il diritto ecclesiastico comparato non si limita a osservare e descrivere i fenomeni giuridici legati alla religione, ma si configura come un mezzo per favorire il dialogo tra le diverse tradizioni normative. La sua capacità di attingere dalle esperienze giuridiche di altri ordinamenti consente di arricchire il patrimonio giuridico nazionale e di fornire soluzioni innovative a problemi complessi, soprattutto in un’epoca caratterizzata da una crescente interdipendenza tra gli Stati e una maggiore sensibilità verso le questioni legate ai diritti umani.
Note e riferimenti bibliografici
[1] Cfr. L. MUSSELLI, Diritto ecclesiastico comparato, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, 232-236.
[2] Cfr. G. D’ANGELO, Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello, Vol. I, Il diritto ecclesiastico nel sistema CEDU, Giappichelli, Torino 2017, 22
[3] A. LICASTRO, Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell’Unione Europea. Lineamenti di comparazione, Giuffrè, Milano 2017, 2.
[4] Cfr. A. ALBISETTI, Diritto ecclesiastico italiano, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, 236-244.
[5] M. NACCI, Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma, 289-290.
[6] Cfr. M. NACCI, Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma, 233.
[7] Cfr. C. MIRABELLI, Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica, in F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Il Mulino, Bologna 1997, 17-23.
[8] F. ONIDA, L’interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico, in P.A. D'AVACK (cur.), La legislazione ecclesiastica, Neri Pozza, Milano 1967, 608.
[9] F. TULKENS, Questioni teoriche e metodologiche sulla natura e l’oggetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in R. MAZZOLA (cur.), Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa, Il Mulino, Bologna 2012, 100.
[10] Cfr. G. D'ANGELO, Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello, Vol. I, Il diritto ecclesiastico nel sistema CEDU, Giappichelli, Torino 2017, 80-81.
[11] Cfr. Ivi, 82.
[12] Cfr. REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 11-12 aprile 1989, n. 203, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CXXX (1989), 16, del 19 aprile 1989.
[13] «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».
[14] «Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti».
[15] «I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale».
[16] «I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
[17] INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM CONVENTIONES, Concordato fra la Santa Sede e l’Italia, 11 febbraio 1929, in AAS, XXI (1929), 276.
[18] Art. 3 co. 1 Cost.
[19] Art. 1: «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione
internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in
sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei
“Principi fondamentali” della Costituzione».
[20] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
[21] Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
[22] Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Bibliografia
ALBISETTI A., Diritto ecclesiastico italiano, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, 236-244.
D'ANGELO G., Argomenti di diritto ecclesiastico comparato e multilivello, Vol. I, Il diritto ecclesiastico nel sistema CEDU, Giappichelli, Torino 2017, 22
LEGA M., BARTOCCETTI V. (curr.), Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici, II, A.L.C.I., Roma 1950, 940.
LICASTRO A., Il diritto statale delle religioni nei Paesi dell’Unione Europea. Lineamenti di comparazione, Giuffrè, Milano 2017, 2.
MIRABELLI C., Diritto ecclesiastico e comparazione giuridica, in MARGIOTTA BROGLIO F., MIRABELLI C., ONIDA F., Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato, Il Mulino, Bologna 1997, 17-23.
MUSSELLI L., Diritto ecclesiastico comparato, in Digesto delle discipline pubblicistiche, V, 232-236.
NACCI M., Storia del diritto e cultura giuridica. La scienza canonistica del Novecento, Aracne, Roma, 289-290.
ONIDA F., L’interesse della comparazione negli studi di diritto ecclesiastico, in D'AVACK P.A. (cur.), La legislazione ecclesiastica, Neri Pozza, Milano 1967, 608.
TULKENS F., Questioni teoriche e metodologiche sulla natura e l’oggetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, in MAZZOLA R. (cur.), Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa, Il Mulino, Bologna 2012, 100.
INTER SANCTAM SEDEM ET ITALIAE REGNUM CONVENTIONES, Concordato fra la Santa Sede e l’Italia, 11 febbraio 1929, in AAS, XXI (1929), 276.
REPUBBLICA ITALIANA, Legge 24 marzo 2001, n. 89, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CXLII (2001), 78, del 03 aprile 2001.

