La formazione del giudizio del giudice civile e canonico
Modifica pagina
Giovanni Margherita
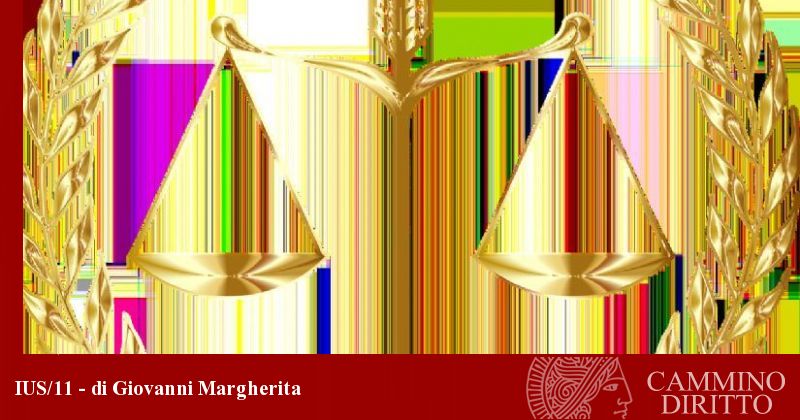
Il presente studio esamina la formazione del giudizio nel sistema civile e canonico, esplorando il principio del libero convincimento del giudice e la ricerca della verità nel processo. Si analizzano la certezza morale come criterio ermeneutico per acquisire la verità reale e la sua evoluzione storica, sottolineandone l’unicità nell’ordinamento canonico. La trattazione evidenzia le differenze tra verità processuale e sostanziale, illustrando come il giudice, attraverso il prudente apprezzamento delle prove, persegua un giusto processo conforme all’articolo 111 della Costituzione italiana. Infine, l’approfondimento si concentra sul ruolo cruciale della motivazione delle sentenze nel garantire una decisione giuridicamente fondata e moralmente certa.
 ENG
ENG
The formation of the judgment of the civil and canonical judge.
This study examines the formation of judgment within the civil and canonical systems, exploring the principle of the judge’s free evaluation and the pursuit of truth in judicial proceedings. It analyzes moral certainty as a hermeneutic criterion for attaining real truth and traces its historical evolution, emphasizing its uniqueness within the canonical legal system. The discussion highlights the differences between procedural and substantive truth, illustrating how the judge, through the prudent assessment of evidence, strives for a fair trial in accordance with Article 111 of the Italian Constitution. Finally, the study focuses on the crucial role of reasoning in judicial decisions, ensuring outcomes that are both legally sound and morally certain.Sommario: 1. Il principio del libero convincimento del giudice; 1.2 Definizione; 1.3 La ricerca della verità all’interno del processo; 1.4 Il giusto processo alla luce dell’art. 111 della Costituzione; 2. La certezza morale come criterio ermeneutico per acquisire la verità reale; 2.1 L’evoluzione storica del termine “certezza morale”; 2.2 Il concetto della certezza morale; 2.3 L’unicità della certezza morale nell’ordinamento canonico; 2.4 La certezza morale quale verità reale; 3. Conclusione.
1. Il principio del libero convincimento del giudice
Il principio del libero convincimento[1] deve accostarsi necessariamente al limite dell’obbligo di motivazione della decisione finale del giudice; per soddisfare ciò, il giudice, è tenuto a ricostruire ex ante il percorso logico-conoscitivo dell’impianto probatorio e a determinare, infine, la decisione. Tale principio viene enucleato con riferimento alla sola valutazione delle prove e non già al momento anteriore del procedimento; tale valutazione avrà come oggetto solo quelle prove che sono legittimamente ammesse ed acquisite.
Come spesso si sottolineerà, il principio del libero convincimento mantiene in equilibrio due posizioni essenziali del processo: da una parte la libertà dell’accertamento giudiziale volta ad esprimere la volontà della legge; d’altra parte, l’obbligo imposto di motivare la decisione, che mantiene fermo quel controllo di legalità del sistema processuale, togliendo le molteplici forme di arbitrarietà nell’applicazione della legge.
1.2 Definizione
All’art. 116 del Codice di procedura civile si sottolinea che: «il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti». Questa norma fissa un principio cardine per l’intera giurisprudenza sia civile che penale, quello del libero convincimento del giudice rispetto alla valutazione delle prove. Le prove sono quegli elementi che vengono raccolti durante l’iter processuale con lo scopo di dimostrare l’esistenza o meno di un fatto dichiarato o smentito dalle parti. Il principio del libero convincimento non trova spazio all’interno di quelle che sono le prove cosiddette legali, cioè quelle prove il cui valore è attribuito ex lege. Tali prove possono essere: la confessione o il giuramento.
Dovendo definire tale principio, il libero convincimento è un criterio di valutazione proprio del sistema giurisprudenziale che mantiene l’intera attività del giudice ogni qualvolta la sua decisione richieda l’apprezzamento dei dati probatori acquisiti. Andando a studiarne l’etimologia del termine stesso, ci si sofferma sul sostantivo e aggettivo che compongono il principio in esame. Con l’espressione “convincimento” dal latino cumvinco ci si riferisce all’idea di vincere un avversario, cioè di superare qualcosa di contrastante rispetto alla propria opinione.[2] La convinzione «è il risultato del superamento di un dubbio che a sua volta viene da duo, come duellum, ed implica la compresenza di due ordini di ragioni contrapposte, tra le quali egli è chiamato a scegliere»[3]. Tale immagine suggerisce una contesa tra le parti, risolta dal giudice terzo ed imparziale, quando abbia assunto la convinzione della fondatezza di una delle due tesi riferite dalle parti.
Il significato del principio andrà ricercato nell’aggettivo “libero” e soprattutto dal suo passaggio dall’”intimo” al “libero convincimento” che ha trasformato la struttura dello stesso principio. Con l’avvento del Code Napoleon del 1804 il convincimento del giudice ha perso la connotazione intimistica ed è stato definito “libero” proprio per adeguare il termine alle varie necessità processuali caratterizzati da un giudizio di natura tecnica affidato, appunto, all’esperienza dei magistrati.
Questa nuova formulazione appariva problematica riguardo l’individuazione dei limiti in cui il giudice poteva effettivamente muoversi liberamente, soprattutto nei confronti dell’impianto normativo, circa la valutazione delle prove e in quelle prove in cui la liberà del giudice era vincolata da norme ben definite.
In conclusione, se il termine “libero” esprime il rifiuto del sistema delle prove legali, non vale però ad escludere la regolamentazione di norme che orientano il giudice nella formazione del personale convincimento; certamente sarà vincolato dal processo e dalla ragione.
1.3 La ricerca della verità all’interno del processo
La complessità dell’impianto probatorio deriva dal fatto che, lo stesso, non si esaurisce nell’ambito soltanto giuridico ma confluisce in altri campi di indagine, quali quello delle scienze umane, dell’epistemologia, della psicologia. «Da sempre, può dirsi, il tema delle prove esorbita infatti dai confini della ricerca strettamente giuridica, per collocarsi sul piano della conoscenza tout court»[4]. Altra difficoltà rinvenibile nel campo probatorio è il necessario esame del concetto di verità all’interno del processo. Si è soliti pensare alla prova come allo strumento capace di stabilire quali fatti rilevanti, ai fini della decisione, possono qualificarsi come veri.
Tale concetto diventa problematico per una ragione sostanziale. Bisogna soffermarsi sul rapporto che sussiste o che potrebbe sussistere tra la verità processuale e la verità assoluta che potrebbe esistere anche al di fuori del processo. È ricorrente, in dottrina, la distinzione tra verità formale, cioè processuale, e la verità materiale che trova ragione di esistere soltanto in quegli strumenti capaci di far conoscere qualcosa. Tale distinzione a volte viene caratterizzata con i termini verità formale tipica del processo e verità assoluta extragiudiziale. Questa distinzione ha creato vari dissidi in dottrina circa la verità cosiddetta giudiziaria, completamente differente soltanto perché appunto, rinvenibile all’interno di un processo grazie alle prove.
Ricordiamo che nel processo canonico
la nota dicotomia tra verità formale (detta anche “giudiziale”) e verità materiale (detta anche “sostanziale” o empirica) non gode di alcuna ragionevole consistenza: esiste un’unica verità che deve essere ricercata, in primo luogo nella fase istruttoria, essendo relativa alle prove disponibili che consentono di accertarla. [...] Se nei modelli di civil law, a tutela della certezza del diritto e nell’ottica del giusto processo, si è inclini a ritenere esaustivo il raggiungimento di una verità meramente “processuale” [...], nel modello canonico l’entità del favor veritatis è di gran lunga superiore al principio della certezza del diritto, essendo corollario inscindibile della stessa nozione di giustizia.[5
Opinione diffusa è quella di contrapporre alla ricerca della verità cosiddetta materiale, il libero convincimento del giudice. Questi due principi sono tra di loro connessi, in quanto attribuendo al giudice il compito di ricercare nei fatti realmente accaduti la verità materiale, egli dovrebbe essere «libero di formare la propria convinzione nel modo ritenuto più opportuno, quindi discrezionale, senza vincoli di sorta»[6]. Bisogna però precisare che tale libertà nel sistema di valutazione delle prove non è normato all’interno dell’ordinamento civile. L’art. 116 c.p.c. obbliga il giudice ad esercitare un «prudente apprezzamento» il quale sarà poi espresso nella motivazione della sentenza, e questo si discosta notevolmente dal principio del libero convincimento. In altre norme si specifica come per l’ammissibilità e l’efficacia di quasi tutti i mezzi di prova, il giudice, sia obbligato a prenderne atto senza ulteriori opzioni interpretative; il “prudente apprezzamento” sarà valutato solo ed esclusivamente per la testimonianza, gli indizi, e i mezzi atipici.
Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova.[7]
[...] il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo: in particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d’ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all’oggetto dell’indagine in funzione della quale è stata disposta [...].[8
Per poter meglio comprendere il vero significato del libero convincimento del giudice bisognerà ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato il processo lungo la storia, in particolare lungo gli anni della rivoluzione francese. Si è soliti pensare, in epoca moderna, ad un principio di libertà e di giustizia sotto l’autorità del giudice che non pregiudichi in nessun modo il suo ruolo giurisdizionale. Lo studioso del diritto processuale e probatorio dovrebbe essere molto più critico rispetto all’interpretazione del principio del libero convincimento, il quale, seppur con notevole progresso nell’età moderna, ha caratterizzato nel passato un momento buio per il processo stesso, in quanto esso ha permesso l’abuso del processo ai fini criminosi che nel tempo avrebbe trovato un ostacolo nel sistema delle prove legali.
Il processo, quale strumento di accertamento dei fatti posti in giudizio, dovrebbe essere impregnato da quei principi che lo rendano giusto, quei principi che gli diano valore e che non siano estranei al diritto e alla giustizia. I caratteri di un processo giusto sono chiari e riassumibili in tre punti: contraddittorio e diritto di difesa, imparzialità e terzietà del giudice, equilibro tra i poteri del giudice e delle parti. Quando l’intero iter processuale si fonda sugli anzidetti principi, il libero convincimento può convivere e funzionare perfettamente in quanto si forma gradatamente all’interno dello stesso processo.
1.4 Il giusto processo alla luce dell’art. 111 della Costituzione
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.[9
Dopo la riforma operata con L. Cost. 23 novembre 1999 n. 2[10], la ratio dell’art. 111 Cost. è quella di garantire il cosiddetto giusto processo, cioè un processo che tenga conto delle parti, garantendo la giusta equità processuale.
Andando ad analizzare la normativa vigente in materia di giusto processo, accanto ai vari principi fondamentali è sorta la necessità di limitare la durata dei processi che ha portato al riconoscimento del principio della ragionevole durata del processo, garantita dalla legge. Tale principio fu assunto dall’art. 6[11] della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e dall’art. 47 comma 2[12] della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea. Il principio della “ragionevole durata del processo” fu emanato con la cosiddetta Legge Pinto del 24 marzo 2001 n. 89[13], che disciplina il diritto alla riparazione per il pregiudizio derivante dalle lungaggini del giudizio civile.
La prima parte dell’art. 111 Cost. inerisce ad alcuni importanti principi, quale il principio del contraddittorio. Tale principio racchiude la necessità che le parti espongano ragionevolmente le proprie questioni; ciò deve avvenire in modo che siano garantite, sia le stesse possibilità alle parti, sia la terzietà del giudice, stando al rapporto processuale che intercorre tra essi. Al principio appena enunciato si deve aggiungere anche il generico diritto di difesa accanto a quello che riguarda le persone meno abbienti entrambi normati nell’art. 24 Cost.[14].
Per garantire il diritto di difesa e ancor meglio garantire un giusto processo, si rende necessaria la motivazione, quale ragionamento logico e giuridico che guida il giudice verso la decisione finale. Tale momento diviene decisivo per le parti, specie per il soccombente della stessa, che ha il diritto di sottoporre la decisione all’esame di un giudice superiore.
Enunciata la classica definizione di principio del giusto processo, si ravvisa la sua particolare pragmaticità all’interno dell’ordinamento italiano in tutta la sua chiarezza.
Il Legislatore, con tale principio, ha voluto introdurre una vera clausola generale che faccia d’apertura all’intero sistema di garanzie costituzionali, cioè una norma destinata al diritto processuale, come in altri sistemi, capace di portare una più completa tutela alle ragioni delle parti.[15] Tale clausola generale, quale norma di apertura, non potrà essere considerata come un catalogo chiuso, come un hortus conclusus, ma dovrà rappresentare lo strumento operativo della Corte Costituzionale proprio per arricchire le garanzie processuali spettanti alle parti in processo. È stato osservato che senza voler predire il futuro, oggi sarebbe comunque sbagliato non dare alcuna valenza all’espressione “giusto processo”, come se questa fosse solo un modo sintetico per richiamare le singole garanzie esplicitate nell’art. 111 Cost. In realtà la costruzione della norma impone all’interprete di dare a quell’espressione il valore di un’autonoma garanzia, ancorché indeterminata, solo in una certa misura sostanziata dalle restanti parti dell’art. 111 Cost.[16]
2. La certezza morale come criterio ermeneutico per acquisire la verità reale;
2.1 L’evoluzione storica del termine “certezza morale”
Il termine “certezza morale”, nell’attuale configurazione legislativa, è recente nel campo dell’ordinamento canonico. Di fatto, lo stato d’animo richiesto per sentenziare da parte del giudice, era considerato in modo indiretto, in quanto ci si soffermava alla discussione circa il valore da dare alle prove.[17] Il termine non è utilizzato all’interno del Corpus Iuris Canonici e nemmeno dagli antichi decretalisti, ma è possibile rinvenire idee, almeno sommarie, in alcuni canonisti del passato. Il termine stesso fu adoperato da Sanchez e da autori posteriori, anche se non era chiaro il grado di certezza per giungere a definire l’uomo “prudente”; solo nel XIX secolo lo si trova citato in alcuni documenti ufficiali[18] e nella giurisprudenza della Santa Sede. La definizione che viene a trovarsi all’interno di questi documenti è data da McCarthy: «status mentis firmiter et sine ulla formidine contradictorii adhaerentes uni parti contradictionis»[19], per cui, alcuni autori sottolineano che la nozione di certezza morale viene definita in senso soggettivo, quale mancanza di dubbio nel soggetto, sia in senso oggettivo, come dimensione ontologia del contenuto della conoscenza.[20]
Riguardo i testi legislativi, il termine “certezza morale” si ritrova, per la prima volta, nel Codice piano-benedettino al can. 1869[21]; il significato stesso del termine viene delineato da Papa Pio XII soprattutto nell’Allocuzione alla Rota Romana del 1942 nella quale afferma «l’importanza dell’argomento»[22], proponendo «di esaminare più accuratamente questo concetto»[23] con l’intenzione «di mettere in rilievo […] e di mostrare in qual modo la Chiesa, secondo la sua missione e il suo carattere»[24].
Nonostante il Magistero indicava la strada da seguire per affrontare l’argomento in questione, il concetto stesso fu subito oscurato nelle Norme processuali concesse nel 1970 alle Conferenze Episcopali degli Usa e dell’Australia tramite il Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa.[25] All’art. 21 si legge che: «il giudice emanerà la sua decisione in conformità alla certezza morale generata dal prevalente peso delle prove aventi un valore riconosciuto in diritto e in giurisprudenza»[26]. L’articolo prevedeva la conciliazione di due concetti, quello della certezza morale e quello anglosassone della prevalenza delle prove, che cambiò il concetto stesso della certezza morale aprendo la possibilità a diverse interpretazioni spesso fuorvianti rispetto al tema. Tale pensiero perse di importanza quando dette norme furono abrogate, nel 1974 per l’Australia e con l’entrata in vigore del Codice del 1983 riguardo gli Usa. Già nell’Allocuzione alla Rota Romana del 1980, ancor prima dell’entrata in vigore del Codice del 1983, Papa Giovanni Paolo II, dopo aver affermato che «Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell’allocuzione rivolta […] il 1° ottobre 1942», ha ribadito,
di conseguenza a nessun giudice è lecito pronunziare una sentenza a favore della nullità di un matrimonio, se non ha acquisito prima la certezza morale sull’esistenza della medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente delle altre leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, “cui, si mos generatur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur”.[27
2.2 Il concetto della certezza morale
Nell’Allocuzione alla Rota Romana, prima di presentare il concetto di certezza morale, Pio XII definisce altri due concetti: quello della certezza assoluta e della probabilità. La certezza assoluta è quella nella quale «ogni possibile dubbio circa la verità del fatto e la insufficienza del contrario è totalmente escluso […] non è necessaria per proferire la sentenza»[28].
La probabilità, che sia essa maggiore o minore, definita dalla giurisprudenza come quasi-certezza, è in opposizione alla certezza assoluta, «non esclude ogni ragionevole dubbio e lascia sussistere un fondato timore di errare»[29].
Tra questi due concetti, certezza assoluta e quasi-certezza, si trova la certezza morale; essa, afferma Pio XII e lo sottolinea Giovanni Paolo II
nel lato positivo, è caratterizzata da ciò, che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall’assoluta certezza.[30
Nella medesima Allocuzione, Pio XII, afferma che la certezza morale non si ha «se non vi sono per la realtà del contrario […], almeno in qualche modo, degni di attenzione»[31].
Tutte queste espressioni si traducono nel concetto di certezza morale: certezza che esclude la probabilità del contrario, anche se non esclude la possibilità assoluta del contrario.[32] McCarty sostiene che la certezza morale è «adhaesio mentis alicui propositioni sine prudenti formidine errandi»[33].
Pio XII sottolinea che la certezza morale, intesa come certezza obbiettiva, è basata su motivi oggettivi; l’oggettività costituisce caratteristica essenziale della certezza. Non si tratta di
una certezza puramente soggettiva che si fonda sul sentimento o sulla opinione meramente soggettiva di questo o di quello, forse anche sulla personale credulità, sconsideratezza, inesperienza.[34
Il Codice prescrive, al can. 1608 §2, che il giudice deve attingere la certezza ex actis et probatis, cioè da asserzioni e negazioni dedotti in giudizio e riferiti agli atti nonché dalle prove prodotte. A ciò risponde il brocardo quod non est in actis, non est in mundo. Al can. 1604 §1 si sottolinea la proibizione per le parti e ai loro avvocati di non dare ai giudici informazioni che rimangono fuori dagli atti di causa. Il Codice esclude tale eventualità, non potendo con ciò arrivare a definire la certezza morale.
Tale oggettività è stata affermata da San Tommaso d’Aquino, nel quale
Iudicare pertinet ad iudicem secundum quod fungitur publica potestate. Et ideo informari debet in iudicando non secundum id quod ipse novit tanquam privata persona, sed secundum id quod sibi innotescit tanquam personae publicae. […] Homo in his quae ad propriam personam pertinet, debet informare conscientiam suam ex propria scientia. Sed in his quae pertinent ad publicam potestatem, debet informare conscientiam suam secundum ea quae in publico iudicio sciri possunt.[35
Ad assicurare l’oggettività della certezza morale sono orientate tutte le norme del diritto processuale canonico; da questo si deduce la sua importanza nella loro retta osservanza.[36]
2.3 L’unicità della certezza morale nell’ordinamento canonico
È doveroso riflettere sull’unicità della certezza morale, quale caratteristica nell’ordinamento canonico rispetto ad altri ordinamenti statali. Il diritto canonico, nella materia processualistica, impone al giudice, con norme ben definite, di usare secundum conscientiam tutti i mezzi di prova prodotti in giudizio per giungere alla certezza morale. Molti altri ordinamenti, quasi nella loro totalità, omettono questo principio dando importanza al prevalere delle prove, piuttosto si ritrova l’idea di certezza proprio in riferimento alle prove prodotte. Si ricorda che nel common law, il diritto anglosassone, nelle cause contenziose viene adoperato, appunto, il criterio della prevalenza delle prove, “preponderance of evidence”, che si discosta notevolmente dal concetto canonico di certezza morale; tale principio impone al giudice
l’obbligo di pronunziarsi in favore della parte per la quale militano le prove prevalenti anche qualora queste determinino soltanto una probabilità e non siano in grado di far sorgere nell’animo del giudice la certezza nel senso canonico.[37]
Negli ordinamenti statali la legge, con le peculiarità di ciascuno, stabilisce che il giudice debba pronunziarsi ex actis et probatis ma, non è consueto trovare un’ulteriore requisito riguardo la coscienza con cui il giudice stesso emette sentenza. Nel diritto canonico, si ritrova lo stesso principio al can. 1608 §2 però è stato individuato un altro criterio capace di indicare lo stato d’animo del giudice, la certezza morale, basata super acta et probata ponderati in coscienza, necessario appunto per pronunciare la sentenza.
Oltre il riferimento agli ordinamenti statali, quanto all’unicità del concetto di certezza morale, vi si trovano notevoli differenze rispetto al concetto adoperato dai filosofi. Gli stessi filosofi distinguono fra certezza metafisica, fisica e morale che va a discostarsi completamente dal concetto adoperato nel diritto canonico, anche se entrambi si basano sui mores, sul modo di comportarsi.
Nel mondo filosofico la certezza morale esclude la possibilità del contrario, mentre per pronunciare una sentenza in favore dell’attore, il giudice, non la esclude. I filosofi percepiscono tale certezza in senso stretto, cioè come una certezza assoluta, mentre la processualistica canonica si discosta notevolmente dal concetto assoluto di certezza.[38]
L’accezione “morale” della certezza che viene usata nel diritto canonico vigente, anche se presa in prestito dai moralisti, si discosta dalla certezza che viene richiesta secondo i principi di teologia morale. La netta separazione dei due ambiti applicativi non si ritrova soltanto nel fatto che la teologia si riferisce alla moralità degli atti umani mentre la canonistica riguarda l’applicazione della naturale facoltà conoscitiva, ma soprattutto nel fatto che in molti casi, avendo gradi differenti di obblighi morali, basti una minore certezza, cioè una probabilità.[39]
2.4 La certezza morale quale verità reale
Il principio fin qui delineato richiede che il giudice si adegui alla giustizia sostanziale, accogliendo o respingendo le pretese dell’attore; tale esigenza si plasma con la verità reale che deve essere anche realistica[40], cioè fare i conti con la povertà delle capacità umane di conoscere in toto la realtà. Il giudice, per questo motivo, deve valutare in coscienza le prove prodotte dalle parti o richieste ex officio a sostegno dei fatti contrastanti.[41] Lo stesso, sottoscrive la sua decisione valutando l’insieme delle prove, sia che siano state abbondanti, sia che disponga della dichiarazione di una parte.
Tale certezza, accolta dal Magistero della Chiesa, è formata
da una quantità di indizi e di prove, che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio.[42]
In questo caso non si arriva alla certezza morale soltanto da un cumulo di probabilità ma
si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell’esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà.[43]
Stando a quanto detto, la decisione del giudice non sarà soltanto una blanda opinione ma un assenso fermo. Se non raggiunge tale certezza, il giudice avrà il dovere etico di non pronunziare nessuna sentenza convertendo lo stato di opinione/probabilità in uno stato di certezza che manca del sufficiente fondamento. La certezza morale, che deve costantemente essere richiesta nell’animus del giudice, non è una costruzione arbitraria del fondamento dei fatti esposti in giudizio ma fondarsi, appunto, sugli atti del processo, i quali devono essere esposti nella decisione ultima ed essere trasmessi sia alle parti che all’eventuale tribunale superiore.
La sentenza, motivata, con i presupposti elencati, costituirà la garanzia dell’obiettività della certezza richiamata da Pio XII, del fatto che la prova è risultata piena. Nella motivazione si andrà percorrendo tutto l’intero iter procedurale che lo ha condotto a pronunciarsi acquisendo la certezza sufficiente.[44] Per mezzo della motivazione si avrà «l’esposizione di un ragionamento giustificativo della sentenza, che la decisione emanata è ragionevole, giusta e fondata sulla certezza morale oggettiva»[45].
McCarthy racchiude il concetto sottolineando che la certezza è «punto centrale e sintesi di tutto il diritto processuale»[46] canonico.
Costituendo un unicum nell’ordinamento canonico, la certezza morale ha tracciato un notevole progresso nel diritto processuale canonico garantendo una giustizia stabile, certa, sistematica; dando al giudice un criterio chiaro rispetto l’indirizzo da perseguire, la certezza si propone come criterio realistico ed esigente incline a soddisfare la verità sostanziale, reale.
3. Conclusioni
La formazione del giudizio, sia nel contesto civile che in quello canonico, da parte del giudice, costituisce una pietra angolare nella realizzazione della giustizia, in quanto riflette la tensione tra libertà di valutazione e rigore normativo. Nel sistema civile, il principio del libero convincimento consente al giudice di formare la propria opinione basandosi sul prudente apprezzamento delle prove, nel rispetto dei limiti normativi e del diritto delle parti a un giusto processo. Questo equilibrio è essenziale per garantire decisioni giuridicamente corrette, evitando derive arbitrarie e promuovendo il rispetto della certezza del diritto.
Invece, nel diritto canonico, emerge con forza il concetto di certezza morale, che si distingue per la sua unicità rispetto agli ordinamenti secolari. Questo principio richiede al giudice di andare oltre la mera prevalenza delle prove per raggiungere una verità reale e sostanziale, pur consapevole dei limiti epistemologici imposti dalla condizione umana. La certezza morale non è solo una costruzione giuridica, ma anche una dimensione etica che guida il giudice nella sua funzione pubblica, imponendo una rigorosa ponderazione delle prove e una profonda responsabilità nella pronuncia della sentenza.
L’analisi comparata tra i due ordinamenti evidenzia come il principio del libero convincimento e quello della certezza morale non siano in opposizione, ma complementari. Se nel diritto civile si enfatizza la necessità di una verità processuale atta a garantire la stabilità delle decisioni e la ragionevole durata del processo, nel diritto canonico prevale l’orientamento verso la verità sostanziale, quale fondamento di una giustizia autentica e universale.
In entrambi i contesti, tuttavia, emerge l’importanza della motivazione della sentenza, che non è solo uno strumento tecnico, ma una garanzia di trasparenza e di legittimità. Attraverso la motivazione, il giudice non solo esplicita il percorso logico e probatorio seguìto, ma rende il proprio operato accessibile alle parti.
Pertanto, lo studio della formazione del giudizio offre una profonda riflessione sulla funzione giurisdizionale come strumento di giustizia e di tutela dei diritti. In un’epoca in cui i sistemi giuridici sono chiamati a rispondere a esigenze di maggiore efficienza e trasparenza, il bilanciamento tra regole procedurali, responsabilità etica e autonomia del giudice si rivela decisivo. La strada verso una giustizia equa, infatti, non si esaurisce nell’applicazione delle norme, ma si completa nella capacità di interpretarle con umanità, ragionevolezza e integrità.
Note e Bibliografia
[1] Cfr. L. DITTRICH, Diritto processuale civile, Tomo secondo, Processi di cognizione, UTET, Milano 2019, 1717-1721.
[2] Cfr. M. NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffrè, Milano 1974, 262.
[3] G. DE LUCA, Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, IV (1992), 1261.
[4] M. FORNACIARI, La ricostruzione del fatto nel processo. Soliloqui sulla prova, Giuffrè, Milano 2005, 2.
[5] E. DI BERNARDO, Modelli processuali e diritto probatorio civile. Elementi di common law, civil law e di diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016, 66-68.
[6] G. MONTELEONE, Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, in Rivista di diritto processuale civile, LXIV (2008), 1, 123-124.
[7] REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione I, 10 ottobre 2018, n. 25067, in www.italgiure.giustizia.it.
[8] REPUBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione III, 10 novembre 2020, n. 25162, in www.italgiure.giustizia.it.
[9] Art. 111 Cost.
[10] «Il d. l. 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in Legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».
[11] «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa […]».
[12] «Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare».
[13] REPUBBLICA ITALIANA, Legge 24 marzo 2001, n. 89, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CXLII (2001), 78, del 03 aprile 2001.
[14] «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».
[15] V. VIGNERA, Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del “nuovo” art. 111 Cost., in Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, LVII (2003), 4, 1193.
[16] M. BOVE, Articolo 111 Cost. e “giusto processo civile”, in Rivista di diritto processuale, LVII (2002), 2, 495.
[17] Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali, in Ius Ecclesiae, IX (1997), 423.
[18] «Ad retinendam in specie culpabilitatem accusati opus est probatione legali, quae talia continere debet elementa, ut veritatem evincat aut saltem inducat moralem certitudinem, remoto in contrarium quovis rationabili dubio» EX S. CONGREGATIONE EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Instructio: Pro Ecclesiasticis Curiis quoad modum procedendi oeconomice in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum, 11 iunii 1880, in AAS, XIII (1880), 329.
[19] E. A. MCCARTHY, De certitudine morali in quae judicis animo ad sententiae pronunciationem requiritur, Romae, 1948, 56.
[20] P. ERDO, La certezza morale nella pronuncia del giudice: problemi attuali, in Periodica de re canonica, LXXXVII (1998), 85.
[21] Can. 1869 - §1 Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo cirqa rem sententia definiendam. §2 Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis. §3 Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, nisi lex aliquid expresse statuat de efficacia alicuius probationis. §4 Iudex qui eam certitudinem efformare sibi non potuit, pronuntiet non constare de iure actoris et reum dimittat, nisi agatur de causa favorabili, quo in casu pro ipsa pronuntiandum est, et salvo praescripto can. 1697, §2».
[22] PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 1° octobris 1942, in AAS, XXXIV (1942), 339.
[23] Ibidem.
[24] PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 2 octobris 1944, in AAS, XXXVI (1944), 281.
[25] Z. GROCHOLEWSKI, Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem, 1, Romae 1977, 243-252.
[26] «The judge will render his decision according to moral certitude generated by the prevailing weight of that evidence hawing a recognized value in law and jurisprudence».
[27] IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Prelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno: de veritate iustitiae matre, 4 februarius 1980, in AAS, LXXII (1980), 176.
[28] PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 1° octobris 1942, in AAS, XXXIV (1942), 339.
[29] Ibidem.
[30] Ibidem; IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Prelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno: de veritate iustitiae matre, 4 februarius 1980, in AAS, LXXII (1980), 176.
[31] PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 1° octobris 1942, in AAS, XXXIV (1942), 340.
[32] Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali, in Ius Ecclesiae, IX (1997), 430.
[33] E. A. MCCARTHY, De certitudine morali in quae judicis animo ad sententiae pronunciationem requiritur, Romae, 1948, 66-68.
[34] PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 1° octobris 1942, in AAS, XXXIV (1942), 340.
[35] S. THOMAS AQUINATIS, Summa Theologiae, II-II, q. 67, a. 2. (Egli, perciò, nel giudicare deve procedere nel suo compito non come persona privata, ma in base a quanto egli conosce come persona publica. […] Nelle cose relative alla propria persona l’uomo è tenuto a uniformare la coscienza alla propria scienza. Ma nelle cose relative ai pubblici poteri deve uniformare la sua coscienza a quello che in un pubblico processo si può conoscere).
[36] Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali, in Ius Ecclesiae, IX (1997), 432.
[37] Ivi, 421; cfr. F. HERMAN, Certitudo moralis praesupposita in normis processualibus Tribunalium Statuum Foederatorum Americae necnon Australiae concessis, in Periodica de re canonica, LXI (1972), 379-393.
[38] Cfr. PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 1° octobris 1942, in AAS, XXXIV (1942), 339; cfr. IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Prelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno: de veritate iustitiae matre, 4 februarius 1980, in AAS, LXXII (1980), 172-178; cfr. Z. GROCHOLEWSKI, La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali, in Ius Ecclesiae, IX (1997), 422; cfr. J. LLOBELL, La certezza morale nel processo canonico matrimoniale, in Il Diritto ecclesiastico, CIX (1998), 4, 759.
[39] M. LEGA, V. BARTOCCETTI (curr.), Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici, II, A.L.C.I., Roma 1950, 940.
[40] Cfr. M. A. ORTIZ, Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale, in Ius Ecclesiae, XVIII (2006), 406.
[41] Cfr. G. MARAGNOLI, La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio, in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M. A. ORTIZ (curr.), La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», Edusc, Roma 2005, 131-143.
[42] PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 1° octobris 1942, in AAS, XXXIV (1942), 340.
[43] Ibidem.
[44] Cfr. A. STANKIEWICZ, La certezza morale e la motivazione della sentenza, in H. FRANCESCHI, J. LLOBELL, M. A. ORTIZ (curr.), La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», Edusc, Roma 2005, 242.
[45] Ivi, 243.
[46] E. A. MCCARTHY, De certitudine morali in quae judicis animo ad sententiae pronunciationem requiritur, Romae, 1948, 3.
Bibliografia
DE LUCA G., Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, IV (1992), 1261.
DI BERNARDO E., Modelli processuali e diritto probatorio civile. Elementi di common law, civil law e di diritto canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2016, 66-68.
DITTRICH L., Diritto processuale civile, Tomo secondo, Processi di cognizione, UTET, Milano 2019, 1717-1721.
ERDO P., La certezza morale nella pronuncia del giudice: problemi attuali, in Periodica de re canonica, LXXXVII (1998), 85.
FORNACIARI M., La ricostruzione del fatto nel processo. Soliloqui sulla prova, Giuffrè, Milano 2005, 2.
GROCHOLEWSKI Z., Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem, 1, Romae 1977, 243-252.
GROCHOLEWSKI Z., La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali, in Ius Ecclesiae, IX (1997), 423.
HERMAN F., Certitudo moralis praesupposita in normis processualibus Tribunalium Statuum Foederatorum Americae necnon Australiae concessis, in Periodica de re canonica, LXI (1972), 379-393.
LEGA M., BARTOCCETTI V. (curr.), Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta codicem iuris canonici, II, A.L.C.I., Roma 1950, 940.
LLOBELL J., La certezza morale nel processo canonico matrimoniale, in Il Diritto ecclesiastico, CIX (1998), 4, 759.
MCCARTHY E. A., De certitudine morali in quae judicis animo ad sententiae pronunciationem requiritur, Romae, 1948, 56.
MARAGNOLI G., La funzione e i poteri del giudice istruttore nel processo canonico di nullità del matrimonio, in FRANCESCHI H., LLOBELL J., ORTIZ M. A. (curr.), La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», Edusc, Roma 2005, 131-143.
MONTELEONE G., Alle origini del principio del libero convincimento del giudice, in Rivista di diritto processuale civile, LXIV (2008), 1, 123-124.
NOBILI M., Il principio del libero convincimento del giudice, Giuffrè, Milano 1974, 262.
ORTIZ M. A., Le dichiarazioni delle parti e la certezza morale, in Ius Ecclesiae, XVIII (2006), 406.
S. THOMAS AQUINATIS, Summa Theologiae, II-II, q. 67, a. 2.
STANKIEWICZ A., La certezza morale e la motivazione della sentenza, in FRANCESCHI H., LLOBELL J., ORTIZ M. A. (curr.), La nullità del matrimonio: temi processuali e sostantivi in occasione della «Dignitas Connubii», Edusc, Roma 2005, 242.
VIGNERA V., Le garanzie costituzionali del processo civile alla luce del “nuovo” art. 111 Cost., in Rivista Trimestrale di diritto e procedura civile, LVII (2003), 4, 1193.
Fonti pontificie
EX S. CONCGREGATIONE EPISCOPORUM ET REGULARIUM, Instructio: Pro Ecclesiasticis Curiis quoad modum procedendi oeconomice in causis disciplinaribus et criminalibus clericorum, 11 iunii 1880, in AAS, XIII (1880), 329.
IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: Ad Tribunalis Sacrae Romanae Rotae Decanum, Prelatos Auditores, Officiales et Advocatos, novo Litibus iudicandis ineunte anno: de veritate iustitiae matre, 4 februarius 1980, in AAS, LXXII (1980), 176.
PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 1° octobris 1942, in AAS, XXXIV (1942), 339.
PIUS PP. XII, Allocutio: Ad Prelatos auditores ceterosque officiales et administros tribunalis S. Romanae Rotae necnon eiusdem tribunalis advocatos et procuratores, 2 octobris 1944, in AAS, XXXVI (1944), 281.
Fonti civili
REPUBBBLICA ITALIANA, Legge 24 marzo 2001, n. 89, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CXLII (2001), 78, del 03 aprile 2001.
REPUBBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione I, 10 ottobre 2018, n. 25067, in www.italgiure.giustizia.it.
REPUBBBLICA ITALIANA. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Sezione III, 10 novembre 2020, n. 25162, in www.italgiure.giustizia.it.

