Pubbl. Mer, 28 Set 2022
Energia nucleare e stato attuale dei rifiuti radioattivi in italia
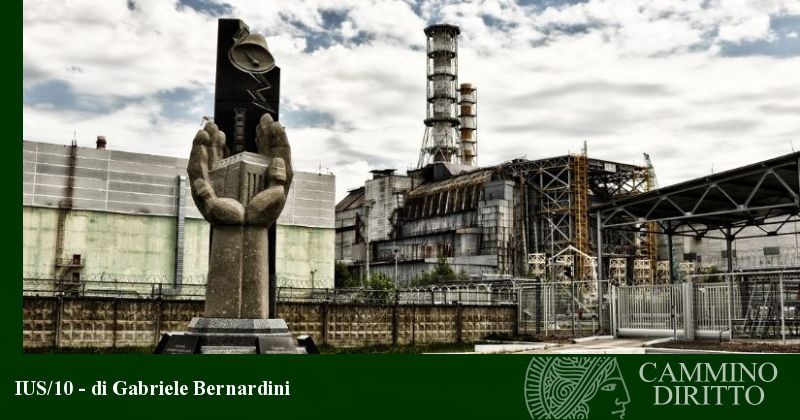
In Italia la prima disciplina delle attività connesse al nucleare è costituita dalla L.3 dicembre 1922, n. 1636 sulle ricerche e sulla utilizzazione delle sostanze radioattive. Successivamente per le implicazioni di tipo sanitario che comportava, questa utilizzazione viene normata anche dal Testo Unico delle leggi sanitarie n.1265 del 1934, il quale costituisce ancora oggi fonte normativa del settore, essendo classificati gli impianti e i laboratori nucleari tra le industrie insalubri di prima classe.
Sommario: 1 Premessa; 2. La crisi del nucleare in Italia; 3. La Commissione Bicamerale Scalia; 4. La programmazione energetica del 2008; 5. il referendum del 2011; 6. Conclusioni.
1. Premessa
La storia dell'energia nucleare ha conosciuto, in Italia, diverse fasi che possiamo racchiudere in un lasso temporale iniziato con il processo di espansione industriale dei primi anni Quaranta e finito con la fine degli anni novanta.[1]
In Italia la prima disciplina delle attività connesse al nucleare è costituita dalla L. 3 dicembre 1922, n. 1636 sulle ricerche e sulla utilizzazione delle sostanze radioattive. Successivamente per le implicazioni di tipo sanitario che comportava, questa utilizzazione viene normata anche dal Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934, il quale costituisce ancora oggi fonte normativa del settore, essendo classificati gli impianti e i laboratori nucleari tra le industrie insalubri di prima classe[2].
La storia del Diritto nucleare italiano è articolata e complessa; essa è caratterizzata da diversi fatti salienti avvenuti in un notevole lasso di tempo, suddiviso in quattro tappe fondamentali. La prima, conosciuta come fase “eroica”, la seconda riguardante il “decennio di stasi”, la terza, iniziata con lo “choc petrolifero” del 1973 e conclusasi con l’incidente di Chernobyl (1986), l’ultima ricompresa tra il 1986 e il 1990, in cui si è dichiarato ufficialmente nel nostro Paese “l’abbandono del nucleare”[3].
Questa periodizzazione rappresenta l’espansione e poi il declino della politica elettronucleare nazionale e ci racconta il fatto che, almeno nella fase espansiva di queste politiche, l’Italia era un Paese leader nel settore dell’atomo.
2. La crisi del nucleare in Italia
Le ragioni che hanno giustificato, alla fine degli anni Novanta, le reazioni degli ambientalisti italiani e dell’opinione pubblica nei confronti del nucleare vanno ricercate, secondo alcuni autori, nel fatto che l’attuazione dei programmi nucleari ha spesso comportato una forte compressione del potere decisionale e delle competenze territoriali, specie in quei settori da sempre baluardo delle autonomie locali.
La diffidenza rispetto alle politiche energetiche “a sostegno dell’atomo” e primi sintomi di dissenso rispetto alla strategia nucleare nazionale si sono moltiplicati agli inizi degli anni Ottanta, in concomitanza con l’ascesa sempre più pressante di un interesse riguardo la tutela dell’ambiente[4]. Si ricordi come in questo periodo un gruppo di cittadini richiese un primo referendum[5], dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale[6], al fine di abrogare alcune disposizioni in materia di energia nucleare ed in particolare la legge 2 agosto 1975, n.393[7].
Tuttavia, di fronte alla preoccupazione per la salute pubblica, sono servite a molto poco le nuove strategie ideate dall’ENEL[8] in quegli stessi anni a sostegno e difesa del rilancio del nucleare. La situazione di declino non era mutata dopo la legge[9] con cui si istituiva l’ENEA; la situazione italiana non cambiò nemmeno con l’ulteriore politica incentivante introdotta con la legge 10 gennaio 1983, n. 8, recante “Norme per l’erogazione di contributi a favore dei Comuni e delle Regioni sedi di centrali elettriche alimentate con combustibile diverso dagli idrocarburi”.
La storia del nucleare italiano giunge definitivamente alla fine con la catastrofe ambientale di Chernobyl[10] e con il successivo referendum nucleare del 1987. L’abbandono definitivo della produzione di energia prodotta attraverso la fonte nucleare nel nostro Paese fu decisa mediante una scelta popolare che interessò l’intero territorio nazionale, tuttavia l’epilogo ufficiale della storia nucleare italiana giunse nel 1990, quando la Camera chiese al Governo Andreotti di “chiudere definitivamente le centrali elettronucleari di Caorso e Trino Vercellese”[11].
3. La Commissione Bicamerale Scalia
Un momento essenziale per la ricostruzione dell'articolata e frammentaria situazione italiana in tema di energia nucleare e di scorie radioattive ereditate dai tempi del programma nucleare nazionale, è stato senza dubbio quello della nomina della Commissione Bicamerale Scalia[12], ovvero la commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. La commissione il 29 aprile del 1999 approvava all'unanimità un documento sulla strategia di intervento per la disattivazione degli impianti nucleari e per la sistemazione dei rifiuti radioattivi.
La commissione Scalia per la prima volta tracciava un quadro completo e dettagliato delle scorie radioattive presenti nel nostro Paese, le censiva, spiegava le pericolosità, dava conto dell'attività di studio e ricerca compiuta dai commissari e proponeva come risolvere il problema.
La commissione ritenne necessario individuare e costruire un apposito sito avente lo scopo di raccogliere e rendere inoffensivi i materiali radioattivi, materiali che provenivano dalle centrali nucleari chiuse dopo il referendum del 1987, ma anche da attività di studio e ricerca. L'idea di realizzare un sito unico per il deposito dei materiali e dei rifiuti radioattivi esistenti in Italia nasceva fondamentalmente dal bisogno di conservare in sicurezza i rifiuti radioattivi che si trovavano da decenni in uno stato di provvisorietà e molte volte di precarietà ed insicurezza.
Alla fine del 1997, presso l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica dell'ONU, veniva approvata o per meglio dire varata la Joint Convention, che impegnava i paesi firmatari, tra cui l'Italia, a garantire un'efficace messa in sicurezza del combustibile e dei rifiuti radioattivi, garantendo una completa e corretta gestione. In seguito, l'allora Ministro dell'industria emanò, in data 14 dicembre 1999, un documento recante indirizzi strategici per la gestione degli esiti del nucleare. Gli stessi indirizzi strategici furono confermati nel D.M. dell’Industria del 7 maggio 2001 (Decreto Letta), il quale stabiliva indirizzi operativi alla SOGIN, la società pubblica istituita ai sensi del d.lgs. n.79 /1999, con il mandato di provvedere alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e allo smantellamento degli impianti nucleari dismessi.
4. La “nuova” programmazione energetica del 2008
Parte della dottrina ritiene che la nuova programmazione energetica del 2008 abbia permesso all’Italia di avviare una nuova fase del processo di sviluppo della normativa dell’energia nucleare, ossia quella che è stata individuata come il periodo del rilancio o della “rinascita nucleare”. Tale fase ha avuto inizio formalmente con l’approvazione da parte del Parlamento italiano della L. n. 99 del 23 luglio 2009[13]. Con l’approvazione di questa legge - si può senza dubbio affermare - è stato prodotto il cuore del Diritto del nucleare italiano, integrato poi negli anni da diversi testi e disposizioni normative composti da principi e regole che, a partire da questa legge, hanno istruito le attività correlate e disciplinato l’impiego pacifico dell’atomo in Italia[14].
5. Il referendum del 2011 e l’addio definitivo all’atomo
Il definitivo abbandono del nucleare venne deciso con lo strumento del referendum nel 2011, quest’ultimo in particolare nel testo del terzo quesito[15], in materia di nucleare, si intitolava ''Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare'' e chiedeva agli elettori se volevano che venissero abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 31/03/2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011, n. 75.
Nel dettaglio il comma 1 della citata normativa recitava “Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare”[16].
Conseguentemente il comma 8, del quale si richiedeva l’abrogazione, prevedeva di avviare una “Strategia energetica nazionale” da parte del Consiglio dei ministri dalla data di entra in vigore della legge di conversione del decreto decreto-legge 31/03/2011, n. 34, in un termine massimo di dodici mesi.[17] La vittoria del “Si” vincolò il governo ad escludere dalla “Strategia energetica nazionale” la costruzione di centrali nucleari sul territorio italiano sancendo di conseguenza la l’addio definitivo all’atomo nel nostro Paese.
6. Conclusioni
Adesso, appare ovvio come la rinuncia al nucleare abbia portato il nostro Paese ad affrontare e gestire - negli anni - enormi e dispendiose difficoltà nel reperimento dell’energia necessaria alla nostra sussistenza; ciò ha messo in evidenza l’importanza del tema e la necessità di risolvere al più presto quelle annose questioni.
Si apre dunque una nuova fase dell’evoluzione del processo storico e della normativa (nazionale e sovranazionale) in materia di nucleare civile; questa fase possiamo definirla del Waste Management & Decomissioning e vedrà l’agenda politica ed istituzionale nazionale ed internazionale dedicare attenzione alla gestione dei rifiuti radioattivi e alle attività di smantellamento degli impianti dismessi[18].
Quest’ultima fase dovrà necessariamente tenere conto di tre momenti fondamentali riguardo la nuova strategia della politica nucleare: lo smantellamento delle centrali nucleari fermate nel 1987, la questione del “Deposito Nazionale” in cui conservare il materiale radioattivo e infine la sicurezza e i controlli sulla gestione dei rifiuti radioattivi. Come è noto in ambito dottrinale, il Decomissioning[19] finalizzato alla realizzazione del cd. “prato verde” (smantellamento delle centrali nucleari presenti in Italia) costituisce nel nostro paese il primo punto fondamentale in materia di nucleare.
Il Decomissioning e la bonifica ambientale dei siti nucleari dismessi costituisce oggi la “più grande operazione di bonifica mai effettuata nella storia del nostro Paese”[20].
Questo obiettivo richiederà l’installazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale che raffigura una condizione fondamentale per perseguire il traguardo del green field; senza il deposito non sarà immaginabile completare la bonifica ambientale dei siti nucleari, che non potranno essere emancipati dai rifiuti radioattivi prodotti. In attesa della localizzazione e realizzazione del sito si pone il problema di smantellare e disattivare tutti gli impianti noti sul nostro territorio nazionale.
La disattivazione (o Decomissioning) di un impianto nucleare è l’ultima fase del suo ciclo di vita; questa fase racchiude le operazioni di mantenimento in sicurezza degli impianti, di allontanamento del combustibile nucleare esaurito, di decontaminazione e smantellamento delle installazioni nucleari e di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi in attesa del loro trasferimento presso il Deposito Nazionale; il Deposito nazionale potrà custodire anche rifiuti radioattivi provenienti da altri settori, con l’obiettivo di rendere i siti privi di vincoli radiogeologici.
Per l’attività di decomissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi compresi quelli prodotti da attività di medicina nucleare, di ricerca e attività industriali, il soggetto responsabile è la SOGIN Spa[21].
[1] Si veda per approfondimenti, Scardina F., Breve excursus sulla recente normativa in materia di energia nucleare, Giureta, vol. VII, 2009.
[2] D.M. 2 marzo del 1987.
[3] Sileo A., Breve storia nucleare d’Italia, 2008, reperibile su www.ecoage.it/energia-nucleare-storia.htm.
[4] Ferrari G.F., Stato di diritto, stato delle autonomie ed energie rinnovabili in Italia, Editoriale scientifica, 2014, pp. 380.
[5] Per approfondimento si segnala, Gaja G., Centrali nucleari: il referendum era davvero inammissibile? in riv. Dir. Intern. 1981, 511.
[6] Sentenza n.31 del 1981: “La responsabilità che lo Stato italiano assumerebbe verso la Comunità e verso gli altri Stati membri a cagione della < disapplicazione > del Trattato conseguente all'abrogazione della normativa oggetto del quesito, è una responsabilità - come la Corte ha affermato nella sentenza n. 30 di pari data - che è stata riservata alla valutazione politica del Parlamento, con il risultato di sottrarre le leggi di esecuzione dei trattati internazionali e quelle produttive di effetti strettamente collegati all'ambito di operatività dei trattati medesimi (come, nella specie, la Corte ritiene siano le norme in parola) alla consultazione popolare, alla quale si rivolge il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione. Per tali ragioni, la richiesta referendaria in esame va dichiarata inammissibile.”.
[7] Legge 2 agosto 1975, n. 393, Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica. (GU Serie Generale n.224 del 23-08-1975).
[8] Istituita come Ente pubblico nel 1962, si è trasformata nel 1992 in società per azioni e nel 1999, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, viene quotata in Borsa.
[9] Legge n. 84 del 1982
[10] Causata dall’esplosione di un reattore.
[11] Sileo A., op. cit., (PEA-Politiche Energetiche e Ambiente, CESE e I-COM9).
[12] per lo studio dei lavori della Commissione si veda www.zonanucleare.it
[13]LEGGE 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. (09G0111). Entrata in vigore del provvedimento: 15/8/2009.
[14] Baino v., Ferrazzano V., Codice dell’energia nucleare, Il Sole 24 Ore, 2010.
[15] “Il testo dell'attuale quesito e' stato modificato dalla Corte di Cassazione e poi giudicato ammissibile dalla Corte Costituzionale, dopo che il governo col Decreto-Legge Omnibus aveva previsto una ''moratoria'' di dodici mesi sul programma di rilancio del nucleare. La Consulta ritiene dunque che le innovazioni avvenute non precludano lo svolgimento del referendum e che il quesito riformulato dalla Cassazione sia ''connotato da una matrice razionalmente unitaria - si legge nelle motivazioni - e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneita' ed univocita'. Mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica''; Fonte: Referendum: il quesito sul nucleare (scheda grigia) News 10/06/2011.
[16] TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34, comma 1 art. 5; fonte: Gazzetta della ufficiale della Repubblica Italiana.
[17] Comma 8 articolo 5 Decreto-legge 31 MARZO 2011 N.34 : “Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali.” Fonte: Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
[18] Al riguardo direttiva 2011/70/ EURATOM del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
[19] Si veda Putti P.M., il Decomissioning degli impianti nucleari, in G. Napolitano, A. Zoppini, Annuario di diritto dell’energia. Il diritto dell’energia nucleare, Il Mulino, 2011, p.187 e ss. .
[20] Colella L., Il diritto dell’energia nucleare in Italia e in Francia, Aracne, 2017, pag. 204 e ss. .
[21] Fonte SOGIN Spa.

