Pubbl. Mer, 23 Lug 2025
Le Sezioni Unite sulla natura del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche
Modifica pagina
Francesco Gasbarra
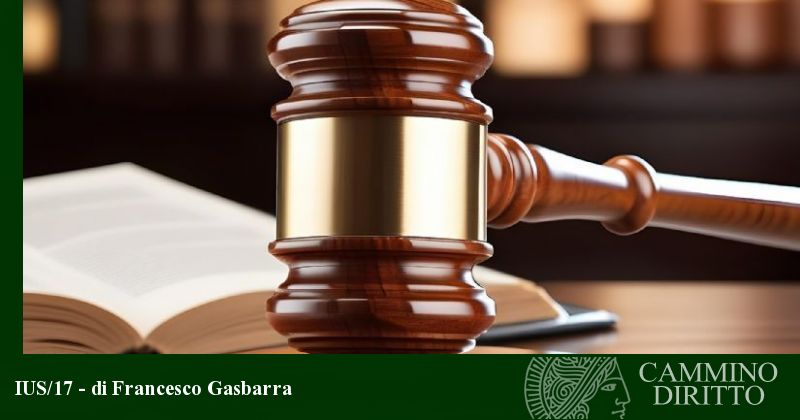
Il contributo si concentra sull’analisi del secondo quesito giuridico affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 11969 del 2025, relativo alla struttura del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) nei casi in cui i benefici siano erogati in forma periodica. La Corte ha affermato la natura unitaria e a consumazione prolungata del reato, qualora le utilità economiche derivino da un’unica condotta mendace o omissiva posta all’origine del rapporto. Si esamina il fondamento teorico e le ricadute pratiche di tale qualificazione, specie in tema di decorrenza della prescrizione e calcolo della soglia di punibilità, alla luce della funzione di tutela delle risorse pubbliche perseguita dalla norma.
 ENG
This article focuses on the second legal question addressed by the Italian Supreme Court’s Joint Chambers in Judgment No. 11969 of 2025, concerning the structure of the offense of unlawful receipt of public funds (Art. 316-ter of the Criminal Code) when the benefits are granted periodically. The Court held that the offense is unitary and consummated over time when the economic advantages stem from a single initial deceptive or omitted act. The article analyzes the theoretical foundation and practical implications of this classification, particularly regarding the statute of limitations and the calculation of the criminal liability threshold, in light of the public resource protection function underlying the provision.
ENG
This article focuses on the second legal question addressed by the Italian Supreme Court’s Joint Chambers in Judgment No. 11969 of 2025, concerning the structure of the offense of unlawful receipt of public funds (Art. 316-ter of the Criminal Code) when the benefits are granted periodically. The Court held that the offense is unitary and consummated over time when the economic advantages stem from a single initial deceptive or omitted act. The article analyzes the theoretical foundation and practical implications of this classification, particularly regarding the statute of limitations and the calculation of the criminal liability threshold, in light of the public resource protection function underlying the provision.
Sommario: 1. Premessa; 2. Il fatto oggetto del giudizio; 3. La nozione di “erogazione pubblica”; 4. Il cuore del problema: la struttura del reato; 5. L’orientamento prevalente: reato unitario a consumazione prolungata; 6. Il principio di continuità causale e la soglia di punibilità; 7. L’orientamento minoritario: pluralità di reati; 8. Il principio affermato: unitarietà sostanziale; 9. Il principio di diritto; 10. Considerazioni conclusive.
1. Premessa
Nel presente contributo si procederà all’analisi della sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, n. 11969, depositata il 26 marzo 2025 (udienza del 28 novembre 2024), con cui la Suprema Corte è intervenuta con un significativo arresto giurisprudenziale in ordine alla corretta qualificazione giuridica del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, previsto e punito dall’art. 316-ter c.p. L'intervento si è sviluppato sia sotto il profilo oggettivo, con particolare riguardo all’estensione del concetto di “erogazione pubblica”, sia sotto quello strutturale, con riferimento alla natura del reato e al momento della sua consumazione.
Al fine di comprendere appieno la portata nomofilattica delle affermazioni contenute nella decisione in commento, appare opportuno procedere preliminarmente a una sintetica ricostruzione del fatto concreto da cui ha avuto origine il procedimento e dei quesiti preliminari che hanno condotta alla decisione in esame.
2. Il fatto oggetto del giudizio
La vicenda giudiziaria traeva origine dalla posizione di una società, riferibile a T.R., che aveva ottenuto l’accesso a un regime agevolativo pubblico sulla base di dichiarazioni mendaci. Le utilità economiche percepite dalla società non consistevano nell’erogazione diretta di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, bensì nella fruizione di benefici di natura fiscale e contributiva, concessi con cadenza periodica. La società, dunque, non aveva ricevuto un contributo in senso stretto, ma aveva beneficiato di un risparmio economico indebito, derivante dall’applicazione di un regime agevolato, per un periodo di tempo prolungato.
Tale fattispecie ha sollevato due distinte questioni giuridiche di rilievo sistematico.
3. La nozione di “erogazione pubblica”
La prima questione riguardava l’individuazione dell’oggetto materiale del reato di cui all’art. 316-ter c.p., e segnatamente se possano rientrare nel concetto di “erogazioni pubbliche” anche i benefici consistenti in esenzioni o sgravi di natura fiscale e contributiva, ossia vantaggi economici non corrisposti in via diretta ma incidenti sul carico finanziario del soggetto privato.
Le Sezioni Unite hanno fornito sul punto una risposta affermativa, valorizzando una lettura sostanzialistica della norma. Già nelle sentenze "Carchivi"[1] e "Pizzuto"[2] — richiamate nella pronuncia in esame per delineare il perimetro applicativo dell’art. 316-ter rispetto alla truffa aggravata e per precisare la nozione di “erogazione” — si era affermato che rientra nell’ambito di applicazione della norma anche «la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma dovuta a un ente pubblico».
Il fondamento risiede nella considerazione che anche in tal caso il soggetto ottiene un vantaggio economico che grava sulla collettività. Di conseguenza, l’interesse tutelato dall’art. 316-ter c.p. va individuato nella corretta destinazione delle risorse pubbliche e, più in generale, nella salvaguardia dell’integrità del sistema pubblico di sostegno economico. Ne deriva una nozione ampia di “erogazione pubblica”, che comprende non soltanto la materiale attribuzione di somme di denaro, ma anche qualsiasi beneficio economico, ivi compresso il risparmio corrispondente al mancato pagamento, all’Erario, di somme altrimenti dovute, idoneo a generare un indebito vantaggio patrimoniale.
4. Il cuore del problema: la struttura del reato
Una volta chiarito il significato da attribuire al concetto di “erogazione pubblica”, il fulcro dell’indagine giurisprudenziale si sposta sulla natura del reato in questione e, in particolare, sulla sua qualificazione come reato istantaneo ovvero come reato a consumazione prolungata, nei casi in cui i benefici siano erogati in forma periodica.
Il secondo quesito di diritto rimesso alle Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria riguardava, infatti, l’interpretazione dell’art. 316-ter c.p. alla luce del principio di legalità, con specifico riferimento alle ricadute pratiche in tema di prescrizione, qualificazione del fatto e applicazione della soglia di punibilità. Si trattava, in particolare, di stabilire se, in presenza di una pluralità di percezioni periodiche, il reato debba essere considerato unitariamente (reato a consumazione prolungata) o se, invece, ciascuna percezione configuri un’autonoma fattispecie.
5. L’orientamento prevalente: reato unitario a consumazione prolungata
Le Sezioni Unite hanno confermato l’indirizzo maggioritario, già accolto dalla giurisprudenza prevalente e sostenuto dalla Procura generale, secondo cui il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche assume natura unitaria e a consumazione prolungata, laddove le diverse erogazioni siano riconducibili a un’unica condotta mendace o omissiva posta in essere all’origine del rapporto[3].
Tale impostazione si fonda sul concetto di reato a «consumazione frazionata e prolungata nel tempo», che si realizza mediante una sequenza di effetti successivi originati da una deliberazione unica dell’agente, e che si perfeziona con l’ultima indebita percezione[4]. La condotta, pur articolandosi nel tempo, conserva un’unità ontologica e giuridica. Il momento consumativo, con rilevanza anche ai fini del decorso della prescrizione, coincide con la riscossione dell’ultimo rateo[5].
Un analogo modello interpretativo era già stato adottato per la truffa ai danni dello Stato (artt. 640 e 640-bis c.p.) in ipotesi di erogazione rateale fondata su una sola iniziale attività fraudolenta.
6. Il principio di continuità causale e la soglia di punibilità
Ai fini della valutazione del superamento della soglia prevista dal secondo comma dell’art. 316-ter c.p., il parametro di riferimento è costituito dalla somma complessiva indebitamente percepita, a condizione che tutte le erogazioni discendano da un’unica condotta mendace od omissiva. Pertanto, rileva l’importo complessivo e non la singola percezione[6].
7. L’orientamento minoritario: pluralità di reati
L’ordinanza di rimessione aveva richiamato anche un orientamento minoritario, secondo cui ogni indebita percezione configurerebbe un’autonoma fattispecie di reato, per l’autonomia contabile e cronologica dei singoli atti. In tale prospettiva, ciascun rateo costituirebbe un illecito distinto, con autonoma offensività, e la soglia di punibilità andrebbe valutata per ogni singola percezione.
Le Sezioni Unite hanno tuttavia ritenuto che tale orientamento si fondi su fattispecie differenti, come nel caso della sentenza Cass. pen., Sez. VI, n. 31223 del 2021 (Ciccarini), relativa a plurime condotte fraudolente autonome (es. invio mensile di modelli falsi), ipotesi ben distinte dalla condotta unitaria oggetto del presente giudizio.
8. Il principio affermato: unitarietà sostanziale
Nella motivazione, la Corte sottolinea che il criterio decisivo per affermare la natura unitaria del reato risiede nella “valenza genetica” della condotta illecita rispetto all’atto amministrativo che dispone il beneficio. Quando le erogazioni periodiche costituiscono il frutto di un’unica decisione mendace o omissiva, l’unitarietà dell’offesa e del bene giuridico tutelato impone di escludere ogni artificiosa frammentazione.
Diversamente, la configurabilità di una pluralità di reati richiede condotte autonome, ciascuna espressione di una distinta deliberazione, con specifica offensività.
9. Il principio di diritto
Sulla base delle argomentazioni esposte, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell'ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 8, legge 23 luglio 1991, n. 223 (...) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo».
Tale principio, di chiara matrice sistematica, si fonda sulla riconduzione unitaria della fattispecie incriminatrice all’unica condotta originaria che ha generato l’intero ciclo di benefici economici indebitamente percepiti. L’approccio sostanzialistico valorizzato dalla Corte consente di superare una visione meramente atomistica delle singole erogazioni, spostando il focus sull’unitarietà del disegno criminoso e sulla continuità degli effetti che da esso derivano nel tempo.
La Corte ha chiarito che il momento consumativo del reato coincide con l’ultima percezione indebita, purché riconducibile causalmente alla condotta mendace iniziale. In tal modo, viene ribadita l’irrilevanza della periodicità dell’elargizione sotto il profilo strutturale del reato: l’articolazione temporale del beneficio non spezza l’unitarietà dell’offesa, che rimane radicata nella fraudolenta instaurazione del rapporto con l’amministrazione pubblica.
La rilevanza del principio è duplice. Sul piano processuale, esso incide direttamente sul computo della prescrizione, la cui decorrenza viene differita all’ultimo atto percettivo, garantendo così una maggiore effettività dell’azione penale nei confronti di reati che, per loro natura, si sviluppano su un arco temporale esteso. Sul piano sostanziale, permette di considerare l’intero importo indebitamente percepito ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità prevista dal comma secondo dell’art. 316-ter c.p., assicurando coerenza tra disvalore del fatto e risposta sanzionatoria.
Infine, l'enunciazione del principio consente di tracciare con maggiore nettezza la linea di confine tra l’art. 316-ter c.p. e l’art. 640-bis c.p., evitando duplicazioni sanzionatorie in presenza di un’unica condotta causativa. Il discrimine non va cercato, quindi, nella forma dell’erogazione (rateale o unitaria), bensì nella natura dell’azione fraudolenta: unitaria e generativa di effetti prolungati nel tempo nel primo caso, reiterata e plurima nel secondo.
Nel caso concreto, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva individuato nel dicembre 2008 il momento della consumazione del reato, coincidente con l’ultima erogazione frutto dell’omessa comunicazione di un collegamento societario rilevante ai fini dell’accesso alle agevolazioni. Ne discende che l’intero arco temporale delle indebite fruizioni resta attratto nell’unitaria contestazione del reato, con implicazioni significative anche in punto di prescrizione e quantificazione dell’indebito.
10. Considerazioni conclusive
La sentenza in esame riveste una portata sistematica di indubbia rilevanza nel panorama applicativo dell’art. 316-ter c.p., poiché consolida e chiarisce in termini nomofilattici due profili fondamentali della fattispecie incriminatrice: da un lato, l’estensione oggettiva del concetto di “erogazione pubblica”; dall’altro, la qualificazione giuridica unitaria del reato nel caso di fruizione periodica del beneficio.
Sotto il primo profilo, le Sezioni Unite adottano una lettura funzionale e sostanzialistica della nozione di “erogazione pubblica”, includendovi non solo l’attribuzione diretta di risorse economiche, ma anche i benefici fiscali o contributivi, ossia tutte le utilità patrimoniali che, pur non comportando trasferimenti monetari, determinano un indebito risparmio a carico della collettività. Tale impostazione, in linea con l’orientamento già espresso in precedenti arresti giurisprudenziali (Carchivi, Pizzuto), consente di preservare l’effettività della tutela penale rispetto a forme sofisticate di frode che si avvalgono di strumenti normativi agevolativi, talora privi di immediata riconducibilità alla nozione classica di contributo.
Sotto il secondo profilo, la Corte valorizza l’unicità della condotta illecita posta in essere nella fase genetica del rapporto con l’amministrazione pubblica, ritenendola idonea a fondare un reato a consumazione prolungata ogniqualvolta le percezioni successive rappresentino l’effetto automatico e predeterminato della dichiarazione mendace o dell’omissione iniziale.
Ne discende una concezione del reato che privilegia l’unitarietà dell’offesa rispetto alla frammentazione temporale dei suoi effetti, con importanti ricadute in tema di: decorrenza della prescrizione, che si computa dall’ultima indebita percezione; applicazione della soglia di punibilità, valutata sull’importo complessivo dell’indebito; determinazione del tempus commissi delicti, rilevante anche per l’individuazione del regime sanzionatorio applicabile ratione temporis; qualificazione giuridica del fatto, ai fini della distinzione con l’ipotesi di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.).
La sentenza si segnala, inoltre, per la capacità di offrire una chiave interpretativa coerente con i principi di legalità e offensività, evitando forzature concettuali e garantendo un corretto equilibrio tra esigenze di tutela dell’interesse pubblico e garanzie del soggetto sottoposto a procedimento penale.
Da ultimo, il richiamo al criterio della “valenza genetica” della condotta rispetto all’atto amministrativo che dispone il beneficio consente di disinnescare derive frammentarie che potrebbero condurre, in contrasto con il principio di proporzionalità, a un’irragionevole moltiplicazione delle contestazioni penali per una medesima condotta fraudolenta.
In definitiva, l’arresto delle Sezioni Unite fornisce un quadro interpretativo solido, sistematico e coerente con i principi costituzionali e sovranazionali in materia penale, rafforzando l’efficacia applicativa dell’art. 316-ter c.p. nei confronti di condotte elusive complesse, spesso caratterizzate da un prolungato rapporto patologico tra privati e pubblica amministrazione.
[1] Cass. sent. n.16568 del 19 aprile 2007;
[2] Cass. pen., S.U., sent. n. 7537 del 16.12.2010 (dep. 25.2.2011)
[3] Cass. Sez. 6, n. 45917 del 23/09/2021, Prigitano, Rv. 282293; Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 281084; Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257431;
[4] Cass. Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014, dep. 2015;
[5] Cass. Sez. 2, n. 1302 del 25/11/1986, Di Lonardo, Rv. 174983; Cass. Sez. 2, n. 4856 del 27/02/1984, Messina, Rv. 164375;
[6] Sez. 6, n. 15120 del 15/04/2023, Nitti, non mass.; Sez. 6, n. 9060 del 30/11/2022, dep. 2023, GSE Spa, Rv. 284336;

