Pubbl. Gio, 23 Ott 2025
Modello 231: dalla rivoluzione industriale alle prospettive di riforma
Tullio Toriello
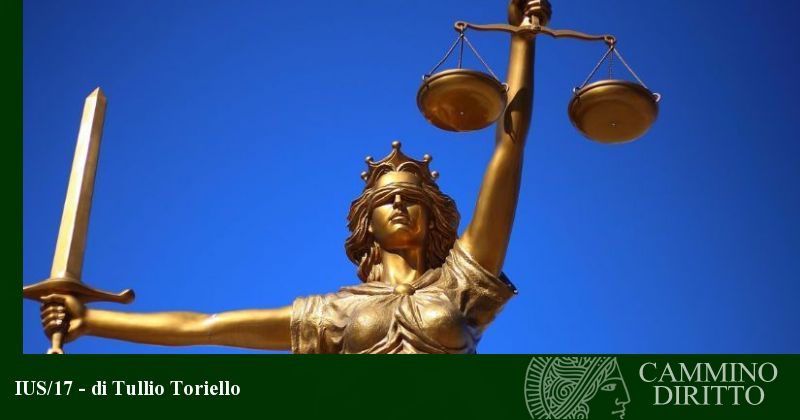
Il presente lavoro analizza l’evoluzione storica e giuridica del principio societas delinquere non potest e il suo definitivo superamento con l’introduzione del decreto legislativo n. 231/2001. A partire dalle radici filosofico-dottrinali del XIX secolo e dalle prime esperienze giurisprudenziali inglesi durante la rivoluzione industriale, viene ricostruito il percorso che ha portato al riconoscimento della responsabilità penale degli enti.
Sommario: 1. La rivoluzione industriale e il principio societas delinquere non potest; 2. Gli Stati Uniti tra 1865 e il 1914; 3. L' attuale normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche in Inghilterra; 4. La responsabilità penale delle persone giuridiche negli Stati Uniti di America; 5. Lo scenario Europeo e la normativa italiana; 6. I concetti di vantaggio ed interesse; 6.1 (Segue) nei reati colposi; 7. L’Organismo di vigilanza; 8. Il sistema sanzionatorio; 9. L'impresa individuale; 10. Profili transnazionali; 11. Conclusioni.
1. La rivoluzione industriale e il principio societas delinquere non potest
Il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica determinando il definito superamento dell'impostazione filosofico- dottrinale secondo cui “societas delinquet non potest”. Espressione coniata da Franz Von Liszt nel 18811 .
Nel XVIII secolo le Corti inglesi divennero la principale espressione di questa teoria giuridica. Tuttavia, durante il periodo della rivoluzione industriale iniziarono ad emergere le distorsioni, le criticità e le diseguaglianze sociali causate dalle politiche aziendali delle corporate2.
In Inghilterra, il primo settore che conobbe una profonda trasformazione fu quello tessile la cui produzione conobbe un importante sviluppo soprattutto in ragione sia dell’aumento della domanda interna che di quella derivante dalle colonie3. Oltre al settore tessile anche il settore siderurgico conobbe radicali cambiamenti.
Le trasformazioni in ambito tessile e siderurgico dettarono le premesse per la rivoluzione industriale definita da Eric J. Hobsbawn come “la più grande trasformazione che si sia avuta nella storia umana dall’epoca remota in cui l’uomo scoprì l’agricoltura e la metallurgia, la citta e lo stato4".
L’aumento della popolazione, lo spostamento dei contadini dalla campagna verso le città e la stratificazione della società in classi sociali sempre più definite e separate furono le condizioni per la creazione di un modello di società completamente nuovo.
I lavoratori spesso artigiani si spostarono nelle grandi città, come Edimburgo, Cardiff, Bristol, Liverpool, Blackpool alla ricerca di lavoro. Si crearono enormi quartieri intorno alle fabbriche e le scarse condizioni igienico sanitarie favorirono lo sviluppo di malattie epidemiche. I figli divennero una ricchezza per le famiglie, una ricchezza da impiegare nelle fabbriche, dando origine al c.d. proletariato, in contrapposizione alla borghesia.
Il nuovo sistema di lavoro soppiantò la vita tradizionale della campagna a cui i lavoratori erano abituati, mutando radicalmente la vita delle famiglie sempre piegate ad una vita funzionale solo al lavoro e alla produzione.
Agli inizi dell’Ottocento emersero le prime proteste con atti di sabotaggio ai macchinari: questi primi gruppi di sabotatori prenderanno il nome di Luddisti dal nome di Ned Ludd, il primo operaio ad attaccare le macchine nelle fabbriche5.
Per la prima volta si identificava la fabbrica, e quindi la corporate, come qualcosa in grado di generare sentimenti negativi.
Fu la Corte di giustizia americana nel 1909, con la sentenza tra Ney york central e Hudson River contro gli Stati Uniti di America, a dare, per la prima volta, rilevanza concreta ai malesseri sociali e legati al rapporto operaio-fabbrica. Contestualmente, fu riconisciuta alle persone giuridiche la capacità di commettere reati.
2. Gli Stati Uniti tra 1865 e il 1914
Nei decenni compresi tra la fine della guerra civile e lo scoppio della prima guerra mondiale gli Stati Uniti divennero la prima potenza economica del pianeta.
In quel periodo conobbero un grande sviluppo demografico dettato sia da un livello molto alto di natalità interna ma anche dal fenomeno migratorio che portò tantissimi lavoratori europei a cercare condizioni di vita migliori6.
Tuttavia l’incremento dello sviluppo economico e demografico ebbe anche conseguenze negative.
Il desiderio di aumentare la produzione e quindi i profitti delle aziende fu la causa principale del verificarsi di un'ampia gamma di reati in danno dei lavoratori, dei consumatori ed anche dell’ambiente.
La Suprema Corte Americana nel 1909 nella causa tra Ney york Central e Hudosn River contro gli Stati Uniti di America, in risposta ai grandi cambiamenti che la società stava vivendo, introdusse un principio assolutamente innovativo secondo cui l’operato dell’amministratore di una società doveva essere attribuito all’ente, a cui si dovevano riconoscere anche conseguenze penali7.
Per la prima volta le società divennero entità viventi a cui riconosce le conseguenze giuridiche.
Il mutamento di portata epocale si riesce ad apprezzare in un passo della sentenza, in cui si legge “dal momento che una persona giuridica agisce per mezzo dei suoi agenti e rappresentanti, gli obiettivi, gli scopi e la volontà di costoro devono essere considerati quelli dell’ente per conto del quale le operazioni vengono realizzate. Per esempio, quell’invisibile ed impalpabile entità che noi definiamo come persona giuridica può spianare montagne, colmare gli avvallamenti, costruire ferrovie e farvi correre sopra le locomotive, significa che ha una volontà di porre in essere queste azioni e che può perciò comportarsi sia malvagiamente che virtuosamente”.
Lo schema logico adottato dalla Corte americana per argomentare la sentenza si basava su tre elementi, ancora oggi ritenuti fondamentali per provare la responsabilità della persona giuridica:
- Un soggetto che opera all’interno della società commette reato;
- Il reato viene commesso nell’ambito delle mansioni che gli vengono conferite dalla società;
- La condotta ritenute penalmente rilevante è commessa per recare un vantaggio alla persona giuridica.
In sintesi, con la “criminalizzazione” della persona giuridiche si riuscì, anche solo in parte, a contrastarne il potenziale criminogeno e a contenere gli effetti devastanti di un capitalismo sfrenato successivo alla metà dell’800.
3. L' attuale normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche in Inghilterra
In Inghilterra, disposizioni di carattere generale in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si individuano già nel Criminal Law act del 1827 e successivamente nell’Interpretation Act del 19788.
Una sostanziale regolamentazione, invece, si è avuta nel 1995 a seguito delle raccomandazioni della Commissione Nolan nel Report on Standards in Public Life.
Dal 1995 in poi diverse sono state le iniziative e novità approntate dal governo Britannico tra cui si ricorda nel 2003 uno schema di disegno di legge (Draft Corruption Bill).
Il 25 marzo 2009 è stato pubblicato il Bribery Bill: proposta di legge avente ad oggetto il tentativo di ridurre al minimo, se non di eliminare del tutto, il rischio di commissione di illeciti di natura penale da parte degli enti, mediante l'adozione di adeguati programmi di conformità (Compilance program).
In data 8 aprile 2010, il citato Bribery Bill ottenne il c.d. Royal Assent (il c.d. "beneplacito reale"), quale atto finale del procedimento britannico di promulgazione delle leggi, divenendo a tutti gli effetti un Act del British Parliament (Bribery Act).
Con il Bribery Act si individuano essenzialmente quattro figure di reato: 1) corruzione attiva verso soggetti pubblici o privati (Offences of bribing another person - Section 1); 2) corruzione passiva verso soggetti pubblici o privati (Offences relating to being bribed - Section 2); 3) corruzione di un pubblico funzionario straniero (Bribery of foreign public officials - Section 6); 4) mancata prevenzione della corruzione da parte delle società (Failure of commercial organizations to prevent bribery – Section 7).
Il Bribery Act presenta diversi caratteri comuni ma anche sostanziali elementi di differenza rispetto alla disciplina codicistica italiana dei reati contro la pubblica amministrazione, contenuta nel codice penale, e della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, contenuta nel D.lgs. n. 231/2001.
4. La responsabilità penale delle persone giuridiche negli Stati Uniti di America
Rispetto ad altri Stati, l’analisi della normativa riguardante gli Stati Uniti pone non poche difficoltà di carattere giuridico ed interpretativo dal momento che trattasi di Repubblica federale.
Ciò nonostante, va riconosciuto grande merito all’ordinamento giuridico statunitense per aver riconosciuto il concetto di responsabilità penale degli enti da oltre cento anni.
Il concetto si affermò alla fine dell'ottocento, con l'introduzione di provvedimenti legislativi che disciplinavano i traffici commerciali e, soprattutto, grazie alla prima normativa antitrust promulgata nella storia, rivolta a sanzionare ciò che il Congresso americano chiamava "abusi economici". In tale contesto, l'Interstate Commercial Act del 1887, l' Elkins Act del 19039 e il Clayton Antitrust Act 191410, introdussero delle sanzioni finanziarie ai danni delle persone giuridiche che violavano le prescrizioni in esse contenute.
Si trattava, fondamentalmente, di norme che vietavano alle imprese che intrattenevano relazioni commerciali tra i vari stati federali di abusare della loro posizione economica o di praticare degli eccessivi ribassi sui prezzi per conquistare una posizione di monopolio.
Nel 1909 la Corte Suprema degli Stati Uniti confermò la legittimità costituzionale del principio della responsabilità penale delle persone giuridiche con la celebre sentenza New York Central & Hudson River R.R. v United States. Dal 1909 in poi, soprattutto durante il New Deal, la legislazione (in particolar modo federale) sviluppò un'enorme quantità di provvedimenti normativi sulla protezione dei consumatori, della pubblica sicurezza, della salute, contro la corruzione, la frode e i reati finanziari.
Quanto alla natura e all'estensione della responsabilità penale delle società nel diritto statunitense, occorre operare una fondamentale distinzione tra le soluzioni adottate dall'ordinamento statale statunitense (State Jurisdiction) e l'ordinamento federale (Federal Jurisdiction), i quali definiscono struttura e natura della responsabilità penale degli enti in termini sensibilmente differenti.
A livello federale nel 1991, con la Federal Sentencing Guidlines, si affronta per la prima volta la responsabilità delle persone giuridiche ponendone il fondamento giuridico - probatorio in un difetto di organizzazione.
Secondo le Guidlines, la responsabilità si configura qualora non vengano adottate le necessarie precauzioni da parte della persona giuridica prima della commissione del reato e diretta a prevenire o scoprire comportamenti criminosi.
Tali precauzioni si definiscono "Compilance program" e consistono in programmi per prevenire le potenzialità criminogene di una corporation, garantendo, allo stesso tempo, una reazione da parte dello Stato non solo in termini di retribuzione della pena ma anche e soprattutto in termini di prevenzione.
Peculiarità del sistema americano è, infatti, la funzione special preventiva, con connotazioni marcatamente premiali nei confronti delle persone giuridiche che adottano le cd. compilance program anche successivamente alla commissione del reato.
Ciò comporta che una azienda in America potrà vedere archiviato il procedimento penale a proprio carico laddove elimini le conseguenze dannose dal reato e dimostri di aver adottato strumenti idonei a prevenire la commissione di reati.
5. Lo scenario Europeo e la normativa italiana
In Europa un importante impulso per l'introduzione da parte degli stati membri di provvedimenti legislativi che prevedessero la punibilità delle persone giuridiche per la commissione di reati fu fornito dalla raccomandazione adottata dal Consiglio di Europa nel 1988.
A tale raccomandazione è poi seguita il protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della comunità Europea (Convenzione PIF) del 1997.
La convenzione in parola stabilì l’obbligo per tutti i paesi membri di adottare le misure necessarie per riconoscere la responsabilità delle persone giuridiche per gli illeciti commessi.
Ad ogni singolo Stato venne lasciata ampia discrezionalità sulle misure da adottare, tuttavia, in una ottica di economia globalizzata, sarebbe stato preferibile individuare una normativa comune, almeno per quanto attiene la parte generale specificandone l’ambito applicativo, lasciando comunque i singoli Stati liberi di adottare i correttivi necessari in ragione delle espressioni fenomenologiche differenti.
In Italia, la raccomandazione del Consiglio d’Europa è stata recepita con la legge delega n. 300 del 2000 e attuata con il decreto legislativo n. 231 del 2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
La normativa prevede la possibilità per le persone giuridiche di dotarsi di un modello di organizzazione gestione e controllo per prevenire la commissione di reati e per evitarne le conseguenze dannose.
Due sono gli aspetti che possono ritenersi fondamentali:
a) i soggetti: ossia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una unità organizzativa dotta di autonomia funzionale e finanziaria; le persone che esercitano anche di fatto funzioni di gestione e il controllo, nonchè le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali;
b) vantaggio o interesse: le condotte poste in essere dai soggetti destinatari della norma devono determinare in favore dell'Ente, un vataggio o un interesse.
6. I concetti di vantaggio ed interesse
La funzione principale dei modelli di organizzazione, gestione e controllo è legata alla predisposizione di procedure di controllo atte a monitorare le aree sensibili della società ed evitare o prevenire che vengano commessi reati che arrechino un vantaggio o un interesse per la società.
Assume quindi assoluto rilievo la corretta definizione dei concetti di vantaggio o interesse su cui molto si è discusso e molto di discute ancora. Sono infatti concetti utilizzati quasi come espressioni sinonimiche, ma che nella sostanza presentano profonde differenze.
Sul punto due sono state le teorie che si sono consolidate.
La teoria monistica, secondo cui l’interesse o il vantaggio avrebbero il medesimo significato.
La teoria dualistica, secondo cui dall'analisi letterale della normativa i concetti di interesse e vantaggio sono da ritenersi disgiunti ed alternativi; ciò implicherebbe che per ritenere fondata la responsabilità di un ente sarà sufficiente la ricorrenza anche si uno solo dei concetti.
Un importante contributo interpretativo in favore della teoria dualistica è stata apportato dalla giurisprudenza di legittimità che, in particolare, come "l’espressione normativa non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse ‘a monte’ per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l’interesse e il vantaggio sono in concorso reale11”.
Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza risulterà pertanto necessaria operare una verifica ex ante quando si analizza il concetto di interesse, mentre il vantaggio presuppone un’analisi ex post, per verificare se quella condotta considerata penalmente rilevante abbia creato un effettivo vantaggio alla persona giuridica.
I concetti di interesse e vantaggio sono stati per la prima volta perimetrati e scrutinati con la sentenza del processo Thyssen Group 12.
La decisone del Tribunale creò un importante arresto giurisprudenziale; si ritenne infatti che la società Thyssen avesse conseguito un vantaggio non avendo implementato le necessarie strutture organizzativa volte ad impedire l’evento morte.
La sentenza sul caso Thyssen fu anche uno dei primi momenti di riflessione da parte della giurisprudenza sul nuovo impianto normativo, in particolare la sentenza si focalizzò su tre aspetti cristallizzando alcuni concetti;
a) La normativa ha creato un sistema ibrido, un “tertium genus” , al cui interno convive il diritto penale ed il diritto amministrativo;
b) Riguardo l’onere probatorio si seguono le regole del processo penale e quindi grava sempre su chi sostiene l’accusa provare la responsabilità dell’ente;
c) altro aspetto affrontato riguarda l’organismo di vigilanza, sui requisiti dei suoi componenti e sulla idoneità dello stesso. Nel caso della Thyssen si appurò che al suo interno mancava il requisito di indipendenza ed imparzialità essendo nominato quale membro un dirigente aree sicurezze, ecologica ed ambiente.
6.1 ...(Segue) nei reati colposi
In relazione ai concetti di interesse e vantaggio, una riflessione merita l’art. 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 che ha introdotto tra i reati presupposto fattispecie colpose di evento, come l’omicidio colposo, le lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme in materia di sicurezza su lavoro o di mera condotta, come ad esempio la condotta descritta dall’art. 451 c.p. (omissione colposa di cautele o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro).
Secondo la giurisprudenza di legittimità 13 i concetti di vantaggio e interesse nei reati colposi di evento vanno riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico.
Nel solco di tale impostazione si pone la sentenza n. 22256/2021 che, confermando la teoria dualistica, ha fornito un ulteriore contributo specificando che ai fini della effettiva sussistenza dell’interesse è necessario accertare l’elemento soggettivo della consapevolezza, l’autore di un reato agisce quindi in violazione di una norma in materia antinfortunistica per creare un beneficio all’ente.
Il vantaggio, invece, si realizzerebbe laddove si configura un profitto in favore della persona giuridica come diretta conseguenza della commissione di un illecito.
7. L' Organismo di vigilanza
L’organismo di vigilanza svolge una funzione assolutamente centrale per la corretta attuazione del modello 231, ad esso è infatti demandato il monitoraggio ed il controllo delle procedure adottate dalla società per prevenire la commissione di reati.
All’Organismo di vigilanza, a cui sono attribuiti essenzialmente funzioni consultive, l’azienda deve garantire autonomia e indipendenza rispetto alle decisioni aziendali, al fine di escludere ogni forma di coincidenza o commistione tra soggetto controllante e controllato.
I membri dell’Organismo di Vigilanza dovranno possedere una duplice tipologia di competenza: una di tipo giuridico-penalistico, con particolare riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, l’altra di tipo tecnico-ispettivo per l’analisi dei sistemi aziendali.
I membri dell’O.d.V sono, quindi, tenuti a soddisfare i requisiti di:
autonomia e indipendenza: al fine di escludere ogni forma di coincidenza o commistione tra soggetto controllante e controllato. Sul punto le Sezioni Unite (Cass. Pen. SS.UU. n. 38343/2014 Thyssenkrupp) hanno escluso che possano far parte dell’O.d.V. i referenti interni svolgenti funzioni operative in aree a rischio-reato e, nello specifico, il responsabile della sicurezza della società.
Continuità d’azione: tale requisito è volto a garantire una costante attività di controllo sulle attività sensibili (ossia quelle a rischio reato) e di monitoraggio del modello affinché sia sempre al passo con l’evoluzione normativa e con il mutare dello scenario aziendale.
Professionalità: i membri dell’Organismo di Vigilanza devono possedere una duplice tipologia di competenza, una di tipo giuridico-penalistico, con particolare riferimento ai reati presupposto e alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, l’altra di tipo tecnico-ispettivo per l’analisi dei sistemi aziendali.
Inoltre, è opportuno prevedere, nel regolamento dell’O.d.V., cause di ineleggibilità e decadenza dal ruolo tali da garantire onorabilità e assenza di conflitti di interessi.
Sebbene la normativa non abbia previsto in modo esplicito una responsabilità penale in capo ai componenti l’Organismo di Vigilanza è molto interessante analizzare come in un ambito assai specifico come quello dell’antiriciclaggio l’ ambito di applicazione può in teoria entrare pericolosamente in contatto con le attività svolte dall’ODV.
8. Il Sistema Sanzionatorio
Diverse sono le sanzioni previste dall’art. 9 del Dlgs. n. 231/2001 e nello specifico si individuano:
a) sanzione pecuniaria;
b) sanzioni interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
c) confisca;
d) pubblicazione della sentenza.
La sanzione amministrativa pecuniaria è quella utilizzata maggiormente, viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 (lire cinquecentomila) ad un massimo di euro 1.549 (lire tre milioni).
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Qualora sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, potrà disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può, tuttavia, essere disposta quando l'interruzione delle attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.
9. L'impresa individuale
Le imprese individuali sono scluse dalla applicazione della normativa in esame.
Tale decisione è stato oggetto di un acceso dibattito sia in dottrina che in giurisprudenza, e secondo l’indirizzo giurisprudenziale oggi prevalente la ragione sarebbe da ricercare nella sostanziale assenza di una struttura societaria complessa dove imprenditore e impresa sono spesso una solo entità.
Tuttavia in giurisprudenza si fece strada un altro indirizzo, divenuto poi minoritario, secondo cui la disciplina in esame andava applicata anche alle imprese individuali14, in quanto:
a) La non menzione dell'impresa individuale nella normativa di riferimento non significa esplicita disapplicazione;
b) Le ditte individuali spesso possono avere una struttura complessa non essendo sempre presente una immedesimazione tra impresa e imprenditore.
A dirimere la querelle interpretativa intervenne nel 2012 la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3008515, il cui indirizzo è stato da ultimo ripreso dalla sentenza n. 45534 del 13 novembre 2023 in virtù delle quali l’impresa individuale non costituisce un autonomo soggetto di diritto distinto dalla persona fisica dell’imprenditore. Ne consegue la non appicabilità della normativa in esame 16.
10. Profili transnazionali
La globalizzazione dei mercati economici e le forti interconnessioni degli scambi commerciali rappresentano le principali novità dell’economia mondiale
Rispetto all’anno 2001 il contesto socio economico è radicalmente mutato così come le risposte che il sistema giudiziario è chiamato a fornire innanzi a temi nuovi, uno su tutti è il concetto di “territorialità” dello Stato rispetto ad un reato presupposto commesso sul territorio italiano da una società con sede all’estero.
Ancora una volta è intervenuta la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 32899/2021 per definire e perimetrare l’ambito applicativo 17.
La soluzione adottata riconobbe la competenza territoriale della giurisdizionale italiana in caso di reato presupposto commesso sul territorio italiano da società straniera che non ha sede in Italia.
La sentenza fu emessa nell’ambito di un procedimento penale per fatti che destarono grande clamore mediatico avvenuti il 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio dove a seguito di un disastro ferroviario persero la vita oltre 30 persone18.
Il maxi-processo scaturito dalla tragedia ha visto coinvolte trenta persone fisiche ed otto società, anche estere, quali: Trenitalia S.p.A., RFI S.p.A., Gatx Rail Austria GmbH, Gatx Rail Germania GmbH, Officina Jungenthal Waggon GmbH, Ferrovie dello Stato S.p.A., FS Logistica S.p.A. e Cima Riparazioni S.p.A. , tratte a giudizio per rispondere, a diverso titolo, dei reati di disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e lesioni colpose; veniva contestato, inoltre, l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione ai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo, aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche.
Le società estere furono chiamate a rispondere dei reati sebbene non avessero sede in Italia, legittimando il concetto di “territorialità” e competenza dello Stato, superando, di fatto, le interpretazioni dottrinali ancorate ad antiche visioni dei mercati commerciali.
La decisone della Suprema Corte fu mutuata dalla sentenza emessa dal Tribunale di Lucca quale giudice di primo grado nel processo per la strage di Viareggio.
Il Tribunale di Lucca19 aderì ad un filone ermeneutico divenuto dominante secondo cui sono da sanzionare le attività delle imprese straniere per fatti commessi sul territorio dello stato italiano a prescindere se abbiano una sede secondaria o uno stabilimento operativo.
L’altro filone ermeneutico sostenuto soprattutto in dottrina, riteneva non applicabile agli enti stranieri la normativa in esame per reati presupposti commessi sul territorio italiano dai soggetti posti in posizione di garanzia cosi come disciplinato dall’art. 5
Tale approccio si basava essenzialmente sulla disparità di trattamento che avrebbero le società straniere, nel cui paese non è prevista alcuna analoga disciplina in materia “231”, in particolar modo in relazione alla adozione di modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione del rischio reato; inoltre si ritenne ingiustificato imporre alle società straniere che operano magari in modo occasionale sul mercato italiano l’adozione di compliance onerosi e complessi in materia “231”.
Al di là di quelle che sono le diverse impostazioni interpretative appare comunque necessaria una revisione del paradigma secondo cui la normativa 231 sia sempre e comunque applicabile alla società straniere, ponendo come dominante il concetto di territorialità.
La normativa “231”, soprattutto alla luce delle continue modifiche al catalogo dei reati presupposto è spesso un complicato fardello per le imprese che sono obbligate continuamente ad adeguare il proprio modello dotandosi di nuove procedure o implementando quelle esistenti.
Prevedere anche per le imprese straniere che operano anche in modo occasionale tali livelli di interventi aziendali può diventare una forma di disincentivo ad operare sul territorio nazionale.
Una vexata questio su cui si spera intervenga presto il legislatore nell’ottica di rendere l’adozione del modello 231 una risorsa da sfruttare per migliorare la qualità degli asset aziendali per le imprese sia nazionali che estere.
11. Conclusioni
Da tempo di discute, anche per il tramite di progetti di legge a livello regionale, se rendere l’adozione del modello 231 obbligatorio per le aziende.
La non obbligatorietà della adozione del modello ha un effetto diretto sulla percezione della importanza della normativa.
L’introduzione spesso disorganica di nuove tipologie di reato presupposto è un ulteriore disincentivo culturale verso una adozione consapevole del modello, che invece dovrebbe porsi come una risorsa per le azienda che attraverso la sua adozione riescono ad ottenere sia una vision aziendale differente, che una tangibile comprensione della propria realtà aziendale.
In questa direzione pare muoversi il progetto di riforma voluto dal Governo Meloni.
Il progetto mira a modellare la disciplina normativa all’attuale contesto economico profondamente mutato rispetto a quando la norma è entrata in vigore.
La riforma dovrebbe indirizzarsi verso una maggiore semplificazione per le piccole realtà imprenditoriali ed un potenziamento dei controlli interni con particolare attenzione alla funzione svolta dall’Odv.
La implementazione del modello 231 è basilare per favorire lo sviluppo di una cultura aziendale volta a valorizzare gli asset, prevenire i rischi derivanti dal reato e tutelare le aziende dal rischio reputazionale in caso di commissione di reati.
1. Franz von Liszt (Vienna, 2 marzo 1851 – Seeheim, 21 giugno 1919)
2. De Simone, Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici, 2012.
3. Alberto, L’eta contemporanea Dalle rivoluzioni settecentesche all’imperialismo.
4. Le rivoluzioni borghesi 1789-1848 Eric J. Hobsbawn.
5. Alberto, L’eta contemporanea, cit.
6. A capitalism in America-Aln Greespan e Adrian Woolridge, 2019.
7. Rivista 231.it A corporate crime trial.
8. La responsabilità amministrativa degli enti in Gran Bretagna in Rivista 231. it, 2023
9. Riv. Theodor Roosvelt Center Dickinson State University.
10. Clayton antitrust act del 1914:storia, emendamenti, sighificato- Troy Segal 2023.
11. Cass. pen. n. 24559/2013, Cass. pen. 3615/2006.
12. Cass. SSUU sentenza n. 38343 del 18/09/2014
13. Cass. pen. n.38183/2014, Cass. pen. n. 16713/2018.
14. Cass. pen. n.45534/2013, Cass. pen. n. 38343/2011.
15. Cass. pen. n. 30085/2012.
16. Cass. pen. n.45534/2023.
17. Cass. pen., n. 32899/2021.
18. Riv. Giurisprudenza penale Strage di Viareggio: rinvio a giudizio per gli imputati, 26 luglio 2013.
19. Tribunale di Lucca sentenza del 31/01/2017

