Pubbl. Gio, 1 Mag 2025
Un possibile diritto ambientale a Roma antica
Giuseppe Ferrante
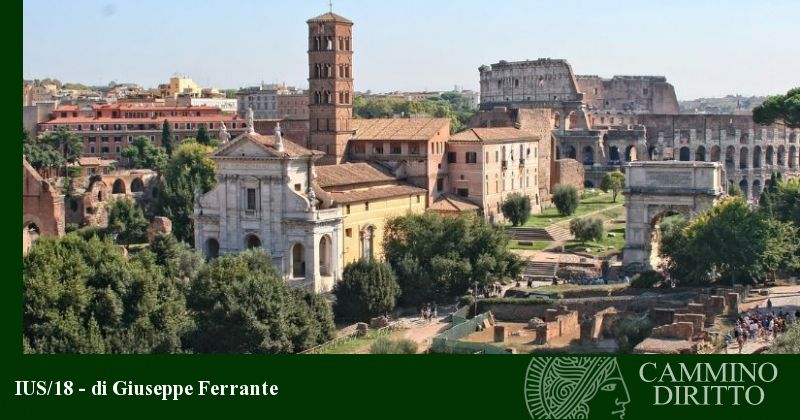
Il presente contributo si propone di esplorare, in una prospettiva sistematica e dogmatica, l’esistenza di un nucleo originario di diritto ambientale nell’esperienza giuridica romana. L’analisi condotta si fonda su una rilettura critica delle fonti giustinianee, al fine di mettere in luce istituti giuridici, categorie concettuali e tecniche processuali che, seppur prive di una sistematizzazione autonoma, anticipano funzioni e finalità proprie del moderno diritto ambientale.
Sommario: 1. Una premessa metodologica: assenza sistematica e presenza funzionale del diritto ambientale romano. 2. Le res communes omnium: beni ecologici ante litteram. 3. Gli strumenti processuali: l’actio aquae pluviae arcendae e la tutela dell’equilibrio idraulico. 4. (Segue) L’actio finium regundorum e l’interdictum quod vi aut clam. 5. Salubrità urbana e infrastrutture pubbliche: una strategia ambientale premoderna. 6. Conclusione: verso una teoria romanistica del diritto ambientale. 7. Appendix: brevi prospettive comparative e attualità della lezione romanistica.
1. Una premessa metodologica: assenza sistematica e presenza funzionale del diritto ambientale romano.
Nell’ordinamento giuridico romano classico non si rinviene una disciplina autonoma rubricabile nomine proprio come diritto ambientale. Tuttavia, una ricognizione attenta del tessuto normativo e delle elaborazioni dei iuris prudentes rivela l’esistenza di dispositivi normativi orientati alla tutela di beni ambientali in senso lato, vale a dire di elementi naturali – quali l’aria, l’acqua, il suolo – funzionali all’ordinata convivenza, alla perpetuazione del rapporto dell'uomo con la natura e alla salus rei publicae.
Nella tripartizione funzionale gaiana su cui si fonda il diritto romano classico – personae, res, actiones – "capace di produrre un sistema normativo flessibile, aperto all’interpretazione e idoneo a evolvere secondo i bisogni della civitas" (1) – le res communes omnium rappresentano il primo punto di contatto con la moderna nozione di bene ambientale, collocandosi fuori dal commercio e al servizio della collettività.
2. Le res communes omnium: beni ecologici ante litteram.
La definizione di Marciano nel Digesto rappresenta uno dei fondamenti teorici della configurazione dei beni ambientali nel diritto romano.
Et quidem naturali iure omnium communia sunt haec: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris (D. 1.8.2.1). Trad.: Invero, secondo il diritto naturale, sono comuni a tutti queste cose: l’aria, l’acqua corrente, il mare, e per questo le spiagge marine.
Con questa enunciazione, il giurista attribuisce ad alcuni elementi naturali essenziali uno statuto giuridico fondato sul ius naturale, un ordine giuridico primario e universale, anteriore al ius civile e valido per tutti gli uomini. L’inclusione di aria e acqua tra i beni comuni naturali implica non solo la loro indisponibilità giuridica (extra commercium), ma anche la necessaria tutela del loro uso collettivo, in funzione della sopravvivenza e del benessere della comunità. La dottrina romanistica ha evidenziato come questa collocazione delle res communes omnium all’interno del ius naturale comporti una forma di sacralizzazione laica della natura, traducibile in un moderno principio di fruizione universale e non discriminatoria.
Ulpiano, sempre nel Digesto, ribadisce da parte sua tale categorizzazione.
Flumina autem publica sunt: itaque riparum usus publicus est, sicut ipsius fluminis (D. 43.8.2.1). Trad.: I fiumi, peraltro, sono pubblici; perciò anche l’uso delle rive è pubblico, così come quello del fiume stesso.
Questo frammento conferma che non solo l’acqua fluviale, ma anche le sponde dei fiumi sono soggette a un regime di utilitas publica, pertanto, destinate al godimento della collettività. L’esegesi romanistica ha chiarito che il concetto di usus publicus implica una fruizione regolata dall’autorità pubblica che garantisce l’equilibrio tra uso individuale e interesse generale. In tal modo, il diritto romano prefigura una concezione funzionale dei beni naturali, in cui l’elemento ambientale è considerato in relazione alla sua utilitas communis, anticipando l’attuale nozione di ambiente come bene comune destinato al soddisfacimento di diritti fondamentali, quali la salute, la sicurezza e la qualità della vita (2).
3. Gli strumenti processuali: l’actio aquae pluviae arcendae e la tutela dell’equilibrio idraulico.
È passando sul piano processuale che si avvalora ulteriormente la tesi che muove il presente lavoro, essendo essenziale ricordare che nel diritto romano una posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico si configurava come tale soltanto se era sorretta da una corrispondente actio ovvero da uno strumento processuale in grado di garantirne la protezione in giudizio. In questo quadro dogmatico, tra le azioni più emblematiche volte a tutelare interessi riconducibili al moderno bene giuridico ambiente, si colloca l’actio aquae pluviae arcendae, azione reale concessa al proprietario di un fondo che subiva un danno a causa di alterazioni artificiali del naturale deflusso delle acque piovane da parte di un fondo vicino.
Tale strumento è ben descritto in un frammento ulpianeo del Digesto:
Si quis de suo in alienum agrum aquam pluviam immiserit, tenetur aquae pluviae arcendae actione (D. 39.3.1.1). Trad.: Se qualcuno avrà convogliato l’acqua piovana dal proprio fondo in un fondo altrui, è tenuto a rispondere mediante l’azione per impedire le acque piovane.
Questa disposizione, in apparenza limitata alla sfera dei rapporti di vicinato, rivela in realtà un principio di più ampia portata: l’equilibrio naturale del territorio non può essere alterato arbitrariamente dall’uomo e la sua violazione attiva un meccanismo giuridico volto a ripristinare l’ordine preesistente.
L’actio aquae pluviae arcendae - una actio in rem e, pertanto, diretta contro chiunque interferisse con il naturale scorrimento delle acque - era fondata su un principio di rispetto dell’assetto idrogeologico naturale. Non si trattava dunque soltanto di evitare un danno contingente al fondo confinante, ma di preservare un equilibrio idraulico che il diritto romano riconosceva come condizione essenziale per la stabilità del territorio e per la funzionalità dell’agricoltura, fondamento economico della civitas. Come è stato osservato, questa azione testimonia una “strategia di prevenzione giuridica” che, pur priva di un’ideologia ambientale in senso moderno, finisce per intercettare i medesimi obiettivi di conservazione e gestione razionale delle risorse naturali (3).
La ratio legis è chiaramente individuabile nella salvaguardia dell’assetto naturale del suolo, il quale, se alterato, può generare effetti a catena – erosione, smottamenti, allagamenti – capaci di compromettere l’utilitas del fondo stesso e la convivenza tra proprietari limitrofi. Si puiò efficacemente definire come una forma arcaica ma sorprendentemente efficace di “tutela del paesaggio agrario e della stabilità ecosistemica” (4). L’actio aquae pluviae arcendae, in tal senso, costituisce un esempio paradigmatico di come il diritto romano intervenisse a monte del danno irreversibile, in funzione non solo riparatoria, ma anche preventiva – anticipando uno degli obiettivi cardine del moderno diritto ambientale (5).
Tale meccanismo si configurava come strumento giuridico volto alla repressione dei delicta lesivi della collettività e alla difesa del bene comune, offrendo al civis Romanus la possibilità di farsi promotore della legalità e del decoro urbano. In altre parole, questo istituto realizzava una forma embrionale di cittadinanza ambientale attiva, idonea a configurare il civis come custos bonorum communium. Il significato di tale affermazione appare oggi ancor più attuale se si pensa al ruolo che le azioni collettive rivestono nella protezione del patrimonio ambientale e paesaggistico.
A ben vedere, l’actio popularis romana, se letta in chiave ambientale, si configura come un archetipo giuridico di tutela diffusa: uno strumento che superava l’interesse individuale per presidiare la dimensione pubblica e comunitaria dell’ambiente. In una società dove la città era percepita come corpo organico e sacro, ogni delictum contro l’equilibrio urbano minacciava non solo l’ordine civile ma anche l’ordine cosmico, e come tale doveva essere represso non solo dal magistrato, ma da ogni cittadino consapevole della propria responsabilità civica.
4. (Segue) L’actio finium regundorum e l’interdictum "quod vi aut clam.
In prospettiva sistematica, si possono rivenire ulteriori strumenti processuali che rivelano una sensibilità giuridica verso l’ambiente come spazio condiviso e fragile. Tra questi si possono ricordare l’actio finium regundorum, impiegata per la determinazione dei confini e il mantenimento dell’ordine agrimensurale, e l’interdictum quod vi aut clam, azionabile nei confronti di chi avesse compiuto interventi lesivi sul fondo altrui senza il consenso del proprietario e con modalità clandestine o violente. Questi strumenti, pur nati in contesti dominati dalla logica proprietaria, mostrano aperture verso forme di tutela dell’ambiente come bene funzionale alla stabilità e alla pacifica convivenza all’interno della comunità civica.
In particolare, l'interdetto quod vi aut clam si rivela strumento di cruciale importanza per la difesa del paesaggio urbano e delle risorse comuni in quanto proteggeva lo status quo possessore anche in assenza di titolarità dominicale, a condizione che l’atto lesivo fosse compiuto vi aut clam.
Assume rilevanza un frammento di Upiano tratto dal titolo "De vi aut clam" (D. 43.24):
Hoc interdictum eo pertinet, ut, si quid vi aut clam in eo loco factum est, restitui debeat* (D. 43.24.7.2). Trad.: Questo interdetto ha lo scopo che, se qualcosa è stato fatto con violenza o di nascosto in quel luogo, debba essere restituito.
L’interdetto de vi aut clam protegge il possesso e l’integrità del fondo da interventi illeciti da parte di terzi. Non importa se il soggetto ha la proprietà del fondo: basta che subisca un'alterazione non autorizzata del luogo. La portata dell'interdetto, un precedente di natura pretoria dei rimedi restitutori e ripristinatori previsti nel diritto amministrativo e civile ambientale, consente di reprimere atti di deturpazione, escavazione, scarico illecito o costruzione abusiva – comportamenti che, se traslati nel contesto odierno, rientrano nel novero dei reati ambientali. (6)
5. Salubrità urbana e infrastrutture pubbliche: una strategia ambientale premoderna.
Anche la presenza di magistrature tecniche, oltre che dei rimedi giuridici specifici sopraesposti, conferma che Roma antica aveva sviluppato una visione complessa e anticipatoria del rapporto tra urbanizzazione e ambiente e ciò risulta evidente in materia di gestione delle cloache, degli acquedotti e degli spazi pubblici nella Roma imperiale. I curatores aquarum e cloacarum erano responsabili della manutenzione delle reti idriche e fognarie, la cui efficienza era condizione essenziale per la sanitas publica. A conferma di ciò, giova citare un frammento del Digesto in cui Pomponio afferma:
In cloacis publicis extruendis aut purgandis populus Romanus curam habet per curatores cloacarum (D. 43.23.1.2). Trad.: Nella costruzione o nella pulizia delle cloache pubbliche, il popolo romano si prende cura (di ciò) per mezzo dei curatori delle cloache.
Questo frammento mostra come l’interesse collettivo per l’igiene urbana trovasse una precisa traduzione giuridico-istituzionale nella figura dei curatores cloacarum, magistrati tecnici incaricati di garantire il regolare funzionamento del sistema fognario. La pulizia delle cloache era infatti considerata un compito non solo tecnico, ma di rilevanza pubblica: la cura publica del populus Romanus si realizzava attraverso strumenti organizzativi e normativi che anticipano l’idea moderna di servizio pubblico ambientale (7).
Parallelamente, i curatores cloacarum erano responsabili delle reti fognarie, e il loro ruolo era determinante per la prevenzione delle esalazioni mefitiche, del ristagno delle acque e delle patologie collettive. La loro attività era tanto tecnica quanto giuridica: il diritto romano prevedeva rimedi anche contro l’omissione di pulizia o la realizzazione abusiva di scarichi.
6. Conclusione: verso una teoria romanistica del diritto ambientale.
L'analisi condotta dimostra come il diritto romano, pur privo di una sezione organica dedicata alla tutela dell'ambiente, contenga in nuce i presupposti teorici e funzionali di una disciplina ambientale complessa. Attraverso le descritte categorie giuridiche, res communes, actio popularis e interdicta prohibitoria, il giurista romano ha saputo costruire una struttura normativa ispirata alla utilitas publica e alla preservazione dell'equilibrio tra uomo e natura.
La lezione romanistica non si esaurisce nella mera archeologia giuridica: essa rappresenta una fonte inesauribile di modelli logici, concettuali e assiologici per la rifondazione di un diritto ambientale contemporaneo che voglia essere, al tempo stesso, efficace e coerente con una visione antropologicamente e storicamente radicata della funzione del diritto. L'attenzione al bene comune, la partecipazione civica e la prevenzione dei danni ambientali sono principi che, sebbene formulati in un contesto storico diverso, mantengono una sorprendente attualità e possono ispirare le moderne politiche ambientali.
7. Appendix: brevi prospettive comparative e attualità della lezione romanistica.
Non è azzardato presumere, alla luce delle considerazioni appena concluse, che il diritto ambientale moderno, tanto a livello costituzionale quanto nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, si fonda su principi che trovano un sorprendente riscontro nella dogmatica romana: il principio di precauzione (art. 191 TFUE), la tutela del bene comune (art. 9 Cost.), la responsabilità diffusa e l’interesse collettivo alla tutela dell’ambiente.
Iniziando dal principio di precauzione, sancito dall'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, si osserva come, stabilendo che in caso di rischio di danno grave o irreversibile per l'ambiente, l'assenza di certezza scientifica non deve giustificare il rinvio dell'adozione di misure efficaci per prevenire il danno, trova una sorprendente affinità con le pratiche preventive del diritto romano (come si è visto, l'azione popolare consentiva a chiunque di agire per la protezione di beni comuni, anche in assenza di un danno immediato, ma in previsione di un potenziale pregiudizio per la collettività).
Anche l'articolo 9 della Costituzione Italiana, tutelando l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, riflette questa tradizione romanistica. Si è avuto modo di vedere, infatti, che il concetto di bene comune nel diritto romano, articolato nelle due categorie principali, le res communes omnium e le res in usu publico, era considerato fuori commercio e non suscettibile di appropriazione privata.
Nel diritto romano, la responsabilità per danni ambientali non era limitata al proprietario diretto del bene danneggiato, ma poteva estendersi a chiunque avesse causato il danno, anche indirettamente. Questo concetto di responsabilità diffusa trova riscontro nel principio "chi inquina paga" del diritto ambientale moderno, sancito dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
L'analisi delle istituzioni giuridiche romane evidenzia una sorprendente attualità nel contesto del diritto ambientale moderno. I principi di precauzione, la tutela del bene comune e la responsabilità diffusa sono concetti che, pur sviluppatisi in contesti storici differenti, condividono una visione comune: la protezione dell'ambiente come bene collettivo e la responsabilità della collettività nel preservarlo. Questa continuità tra diritto romano e diritto ambientale moderno non solo arricchisce la comprensione storica delle istituzioni giuridiche, ma offre anche spunti per l'elaborazione di politiche ambientali più efficaci e radicate nella tradizione giuridica europea.
(1) MADDALENA P., La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche romane (2011) p. 17.
(2) cfr. MADDALENA P., I beni comuni nel diritto romano (2012) p. 4.
(3) FASOLINO S., Cloache e sanità urbana nello specchio del diritto (2018) p. 93.
(4) DI PALMA E., Il diritto dell'ambiente nella storia (2016) p. 41.
(5) Come chiarisce Fargnoli, si tratta di una risposta giuridica alla *ruina naturae*, ossia al disordine ecologico generato da azioni umane prive di contemperamento. FARGNOLI I., Ruina naturae e diritto romano (2015) p 12.
(6) Fasolino evidenzia la stretta connessione tra tale rimedio interdittale e la tutela salubritatis urbis. FASOLINO S., Prime considerazioni in tema di tutela della salubritas fra III e I secolo a.C (2010) p. 15.
(7) Come rileva Fiorentini, tali interventi erano espressione di una praeventio iuridica volta alla preservazione dell’equilibrio urbano, ben prima che l’igiene ambientale divenisse oggetto di disciplina sanitaria moderna. FIORENTINI M., Diritto romano e ambiente (2006) p. 140.

