Pubbl. Gio, 27 Feb 2025
La telematicità degli atti processuali: incidenza del PCT nel processo canonico
Modifica pagina
Giovanni Margherita
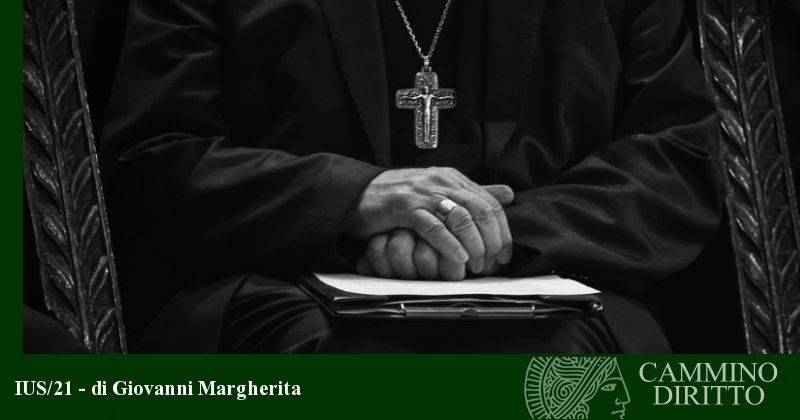
Il PCT ha rivoluzionato la gestione degli atti processuali attraverso la digitalizzazione, migliorando efficienza e accessibilità. L’adozione del fascicolo informatico e del deposito telematico ha ridotto tempi e costi, ma ha sollevato questioni sulla coesistenza con il cartaceo e sulla sicurezza della PEC. L’analisi esplora anche l’applicazione di questi strumenti nel processo canonico, evidenziando come la digitalizzazione possa favorire maggiore rapidità e affidabilità, mantenendo il rispetto delle norme ecclesiastiche. L’analisi delle disposizioni normative e delle implicazioni pratiche dimostra come il passaggio al digitale rappresenti non solo un’evoluzione necessaria, ma anche una garanzia di maggiore affidabilità e sicurezza per il sistema giuridico nel suo complesso.
 ENG
ENG
The telematic nature of procedural acts: the impact of the PCT on the canonical trial
The PCT has revolutionized the management of procedural acts through digitalization, enhancing efficiency and accessibility. The adoption of the electronic case file and telematic filing has reduced time and costs but has raised questions about coexistence with paper-based procedures and the security of PEC (Certified Email). The analysis also explores the application of these tools in the canonical process, highlighting how digitalization can promote greater speed and reliability while ensuring compliance with ecclesiastical norms. The examination of regulatory provisions and practical implications demonstrates that the transition to digital is not only a necessary evolution but also a guarantee of greater reliability and security for the legal system as a whole.Sommario: 1. Introduzione; 2. Il fascicolo informatico; 2.1 Il fascicolo informatico e il fascicolo cartaceo; 2.2 La struttura del fascicolo informatico; 3. Il deposito telematico; 3.1 Disciplina relativa al procedimento di deposito; 3.2 Le modalità alternative di deposito; 3.3 I termini del deposito.
1. Introduzione
Negli ultimi decenni, il progresso tecnologico ha rivoluzionato numerosi ambiti della società, compreso il settore giuridico. L’introduzione degli strumenti informatici nel processo civile ha portato a un cambio di paradigma significativo, trasformando radicalmente le modalità di redazione, gestione e trasmissione degli atti processuali. Questo fenomeno, noto come processo civile telematico (PCT), ha introdotto un nuovo modello operativo fondato sulla digitalizzazione, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, trasparenza e rapidità nella trattazione delle cause.
L’evoluzione normativa ha avuto un ruolo centrale in questa trasformazione, definendo le regole per la creazione, conservazione e validità degli atti digitali. L’adozione del fascicolo informatico ha rappresentato uno dei capisaldi di questo processo, favorendo l’accesso remoto agli atti e la semplificazione delle attività di cancelleria. Allo stesso tempo, il deposito telematico degli atti ha reso possibile una gestione più snella e sicura del contenzioso, riducendo i tempi di trasmissione e archiviazione della documentazione. Tuttavia, la transizione dal cartaceo al digitale ha sollevato numerose questioni interpretative e applicative, tra cui la coesistenza tra fascicolo informatico e fascicolo cartaceo, la validità probatoria delle copie digitali e l’affidabilità della firma elettronica. Inoltre, il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC) per la comunicazione tra le parti e gli uffici giudiziari ha evidenziato vantaggi e criticità, ponendo il tema della sicurezza e della tutela dei dati sensibili.
Queste innovazioni hanno avuto ripercussioni anche sul processo canonico, tradizionalmente caratterizzato da procedure formali e da una gestione documentale cartacea. L’adozione di strumenti digitali in questo ambito potrebbe contribuire a migliorare la celerità e l’efficienza dei procedimenti, assicurando al contempo il rispetto dei princìpi giuridici e dottrinali che regolano il diritto canonico.
Il presente lavoro si propone di analizzare il fenomeno della telematicità degli atti processuali, esaminando il quadro normativo vigente, le implicazioni pratiche e le prospettive future di digitalizzazione nel diritto civile e canonico. Attraverso un’analisi approfondita delle fonti e delle disposizioni legislative, verranno esaminati i benefici e le criticità del PCT, con particolare attenzione alla sua possibile applicazione nel contesto canonico. L’obiettivo è quello di offrire una visione chiara e completa di questa trasformazione epocale, delineando il ruolo che la tecnologia giuridica potrà assumere nei prossimi anni.
2. Il fascicolo informatico
L’utilizzo degli strumenti informatici nello svolgimento del processo, tanto civile che canonico, spinge lo scrivente ad una ulteriore specificazione in materia. Non v’è dubbio che tali strumenti, negli scopi del Legislatore, portarono ad una riflessione circa la facilitazione sulla gestione e l’accesso agli atti processuali e ai documenti informatici garantiti a tutti i protagonisti.
«La scelta di promuovere l’utilizzo di tali strumenti discenda dalla convinzione che essi possano rendere il processo civile meno dispendioso sia dal punto di vista dei tempi necessari alla sua conclusione sia nell’ottica delle energie materiali e personali dallo stesse richieste»[1], ciò vale in considerazione tanto del processo civile, quanto del processo canonico.
Per tali considerazioni la formazione di un “fascicolo informatico” su cui cancelleria ed operatori possano operare, diviene il punto focale per trasformare “l’accesso fisico” in “accesso virtuale”.[2]
La premessa, consequenziale a ciò che si è fino a qui detto, è formata dalla nozione di fascicolo informatico e dalla comprensione di quali materiali confluiranno nello stesso sulla base degli assunti normativi che si sono negli anni stratificati.
La prima definizione di fascicolo informatico, così come rubricato, ci viene offerta dall’art.12, co. 1 del d.P.R. n. 123/2001, antecedente all’avvento della disciplina del processo civile telematico, in cui si dispone che la cancelleria procede alla formazione del fascicolo informatico contenente «gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo». Il co. 2 dello stesso articolato, precisa che siano inseriti nel fascicolo informatico «anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo» e inoltre che «per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l’inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l’operazione non sia eccessivamente onerosa».
Il d.m. 14 ottobre 2004[3], recante le “Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”, all’art. 2, co. 1, lett. h, definisce il fascicolo informatico quale «versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo».
L’art. 9, co. 1, rubricato “Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico”, del d.m. n. 44/2011 conferma che
Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, raccogliendo in un fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
Dalla normativa summenzionata, emergono due chiare disposizioni in merito al fascicolo informatico. Il primo aspetto riguarda l’onere che grava sulla cancelleria rispetto alla formazione del fascicolo e ciò in continuità con quanto disposto dall’art. 168, co. 2 c.p.c., secondo cui «il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, [...], copia dell’atto di citazione, delle comparse [...] e, successivamente, i processi verbali d’udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d’istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze»; il secondo aspetto richiama il fatto che nel fascicolo informatico sono inseriti, oltre che gli atti del processo quali documenti informatici o copie informatiche degli stessi, anche «i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti dal processo» secondo quanto disposto dall’art. 12, co. 2 del d.P.R. n. 123/2001.
Analizzando più in concreto il primo dei due aspetti, principalmente su ciò che riguarda l’onere della cancelleria di formare il fascicolo informatico anche dei documenti depositati su formato cartaceo, risulta necessario menzionare l’art. 14, co. 2 del d.m. n. 44/2011, nel quale si sottolinea che la cancelleria «provvede ad effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 22, comma 3 del codice dell’amministrazione digitale». Ciascuna copia informatica dei documenti cartacei inseriti all’interno del fascicolo informatico corredati di firma digitale del cancelliere è da ritenersi idonea «ad asseverare la conformità della copia informatica all’originale»[4].
All’onere della cancelleria di formare il cosiddetto fascicolo informatico, corrispondono delle conseguenze sulla mancata apposizione della firma digitale del cancelliere sui documenti inseriti all’interno di esso, sia che riguardino le copie informatiche di atti processuali redatti su supporto analogico, sia che riguardino i documenti analogici. Riguardo alle copie informatiche si prevede che nonostante la mancata apposizione della firma digitale attestante la conformità all’originale, si presume l’equivalenza all’originale cartaceo; per ciò che concerne le copie informatiche di documenti analogici sprovviste di firma digitale, la conclusione risulta essere differente.
Per comprendere ciò è doveroso richiamare l’art. 22 del CAD che si occupa precisamente delle copie informatiche di documenti analogici, differenziando, all’interno dello stesso, le copie informatiche per immagine e le copie informatiche non per immagine.
Se all’interno del fascicolo informatico viene depositata una copia informatica per immagine di un documento analogico, l’art. 22, co. 3 specifica che «hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta»; diverso è il caso in cui si tratti di una copia informatica non per immagine che, al co. 1, prevede che «hanno piena efficacia, [...], se sono formati ai sensi dell’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo», cioè quando «vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore» attraverso i requisiti fissati dall’AgID. Ciò impedisce a questi ultimi di ritenersi equivalenti all’originale con la conseguenza che verranno trattati come un «diverso documento informatico che al di più riproduce lo stesso contenuto del documento analogico»[5].
2.1 Il fascicolo informatico e il fascicolo cartaceo
Dopo aver chiarito il concetto di fascicolo informatico e le incongruenze con il fascicolo cartaceo, bisognerà affrontare il problema di quest’ultimo dopo l’introduzione dello strumento informatico. Il compito di questo paragrafo sarà quello di valutare se il fascicolo informatico sia in grado di prendere il posto nella sua interezza di quello cartaceo e se ci sia la necessità di eliminare quello cartaceo nella gestione delle fasi processuali.
L’art. 12, co. 3 del d.P.R. n. 123/2001, dissipa ogni dubbio chiarendo che «la formazione del fascicolo informatico non elimina l’obbligo di formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo», intimando così alle cancellerie di formare, oltre al nuovo fascicolo informatico, anche il tradizionale fascicolo cartaceo.[6] Come si è potuto accennare nel precedente paragrafo, alle cancellerie resta l’obbligo di formare il fascicolo informatico anche nei casi in cui «si proceda all’introduzione del giudizio e all’iscrizione della causa a ruolo su supporto cartaceo» ciò per garantire il successivo deposito in modalità telematica degli atti postumi alla costituzione in giudizio.
Nelle circolari del Ministero della giustizia del 28 ottobre 2014[7] e del 23 ottobre 2015[8], riguardanti gli “Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico”, ai punti 2, si precisa che «può sorgere la necessità, per la cancelleria, di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento».
La possibilità del doppio binario informatico/cartaceo presente all’interno delle cancellerie risponde, almeno nel primo periodo dall’introduzione delle modalità telematiche, alla garanzia di acquisizione dei nuovi strumenti operativi al momento della transizione. Tale possibilità, o meglio l’obbligo di conservazione dei documenti originali, viene definita nell’art. 9, co. 3 del già citato d.m. n. 44/2011, per il quale «la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo», fatti salvi «gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente».
L’art. 22, co. 5 del CAD prevede che
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, [...], permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
Per attuare quanto richiamato nel suddetto articolo, il d.P.C.M. del 21 marzo 2013[9], individua quali siano i documenti originali considerati unici «per le quali pemane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico»; l’allegato al suddetto d.P.C.M. prevede per i documenti ricavati dagli atti processuali, la conservazione degli originali per i venti anni successivi alla loro formazione. Ne deriva che la cancelleria ha l’obbligo di provvedere alla conservazione cartacea ogniqualvolta un atto processuale venga depositato su supporto cartaceo e ciò con la conseguenza della formazione del fascicolo cartaceo.
Una volta chiarito che il doppio binario informatico/cartaceo è previsto dalla normativa sul processo civile telematico, resta da analizzare l’interrogativo circa il contenuto del fascicolo informatico e cartaceo.
Il primo punto da analizzare riguarda il materiale prodotto in originale su supporto cartaceo conservato nell’apposito fascicolo, rispetto all’obbligo in capo alla cancelleria di «estrazione di copia informatica ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico»[10]. Per ciò che concerne i documenti prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, il già citato art. 12, co. 2 del d.P.R. n. 123/2001, dispone che «l’inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche è effettuato dalla cancelleria, sempre che l’operazione non sia eccessivamente onerosa»; la cancelleria, in applicazione del disposto appena citato, potrà eludere tale procedimento soltanto quando l’operazione diventi difficoltosa per la stessa.
Sorte differente sussiste in riferimento agli atti processuali redatti su supporto cartaceo in cui, in capo alla cancelleria, resta l’obbligo di estrazione di copia informatica. Sia l’art. 12, co. 1 del d.P.R. n. 123/2001, sia l’art. 9, co. 1 del d.m. n. 44/2011 precisano che debba essere conservata nel fascicolo informatico una copia di tutti gli atti processuali analogici, senza alcuna eccezione di sorta.
In ultima analisi, in dottrina si è posti l’interrogativo se effettivamente i due fascicoli debbano necessariamente convivere o vivere distintamente l’uno dall’altro. Dalla lettura della normativa si evince come l’obbligo di includere nel fascicolo informatico tutto ciò che è cartaceo non includa anche il contrario; per cui si avranno fascicoli informatici completi in toto nelle loro parti, e, dall’altro, fascicoli cartacei parzialmente completi, ad eccezioni di alcuni documenti in cui è prevista la possibilità, se non l’espressa menzione, di avere a disposizione anche l’originale su supporto cartaceo.
2.2 La struttura del fascicolo informatico
Dopo aver enucleato i princìpi che regolano il binomio informatico-cartaceo, bisognerà analizzare la struttura del fascicolo informatico, soprattutto verificare se ad essa è possibile adattare i princìpi del fascicolo cartaceo.
Come si è detto riguardo al fascicolo informatico, lo scopo del Legislatore fu quello di facilitare la gestione e l’accesso agli atti processuali e ai documenti informatici garantiti a tutti i soggetti interni ed esterni al processo che ne abbiano interesse. A ciò bisogna aggiungere quanto il fascicolo informatico risulti essere una realtà complessa laddove diventa un “contenitore” di un gran numero di informazioni con l’inevitabile conseguenza di dover garantire la consultabilità ad opera della parte, nonché «la facoltà per quest’ultima non solo di verificare quale sia il materiale effettivamente contenuto nel fascicolo, ma anche di individuare e reperire con facilità l’atto o il documento»[11] di suo interesse.
Per uno sguardo d’insieme risulta interessante richiamare la norma che regola la gestione del fascicolo cartaceo; ci riferiamo all’art. 36, commi 4 e 5 delle disp. att. c.p.c.[12], in cui si prevede che «nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli atti inseriti nel fascicolo con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi», e ancora che «gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e muniti di un numero progressivo corrispondente a quello dell’indice».
Richiamato il suddetto articolato bisognerà valutare se anche per il fascicolo informatico sussiste una normativa vigente in cui si delineano i parametri per una struttura ideale a cui fare riferimento. L’unica normativa è contenuta nell’art. 9, commi 4 e 5 del già citato d.m. n. 44/2011 in cui si prevede che il fascicolo informatico rechi l’indicazione «a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) dell’oggetto del procedimento; c) dell’elenco dei documenti contenuti», e anche che «il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti». La disciplina in questione pone l’attenzione sulla garanzia di una facile reperibilità dei documenti contenuti all’interno del fascicolo informatico mediante l’ausilio delle indicazioni dell’oggetto dei procedimenti e dell’elenco degli stessi.
Dall’analisi di entrambe le normative, fascicolo cartaceo e informatico, risulta la prima struttura essere più congeniale per una consultazione pratica e fluida in quanto contenente gli indici degli atti con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di essi; da ciò si presume che la disciplina del fascicolo cartaceo debba essere rispettata in toto anche nella formazione del fascicolo informatico.
3. Il deposito telematico
Il nuovo sistema del PCT induce necessariamente, tra le varie novità, che il deposito di atti e documenti avvenga telematicamente, ciò allo scopo di garantire, sia alle parti che al giudice, una più agevole e rapida accessibilità e consultabilità degli stessi atti e documenti.[13]
A tale scopo, il “deposito telematico” è «lo strumento attraverso il quale la parte provvede all’inserimento nel fascicolo processuale informatico di atti e documenti, ovvero alla iscrizione a ruolo di un nuovo procedimento»[14]. Il suddetto deposito telematico produce gli stessi effetti del tradizionale deposito in cancelleria e lo va così a sostituire; previsto dall’art. 16 bis del d.l. n. 179/2012, è regolato dall’art. 13 del d.m. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche previste dallo stesso. La normativa, all’art. 13, co. 1 del decreto summenzionato, prevede per i soggetti interessati, la trasmissione dei documenti informatici, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo dell’ufficio designato a riceverli; ciò implica che alla parte non è garantita la possibilità di visionare il fascicolo informatico ma solo trasmettere all’ufficio competente i relativi documenti per la formazione dello stesso.
Anche in questo caso la cancelleria ha un ruolo predominante in quanto, ricevuta la busta relativa al deposito, dovrà verificarla e di conseguenza validarla. A tal proposito le regole tecniche regolamentano
- il formato degli atti e documenti informatici depositabili, e la loro sottoscrizione;
- le modalità di creazione della busta e degli allegati “tecnici”, quale l’indice della busta, nonché le modalità della sua sottoscrizione;
- le modalità di invio della busta a mezzo posta elettronica certificata;
- la gestione della ricezione della busta da parte dei servizi informatici del Ministero della Giustizia, salvi i successivi controlli da parte del cancelliere.[15
Nonostante la complessità della procedura nella formazione della busta telematica è indispensabile per l’avvocato e per ogni operatore esterno l’utilizzo di un software che lo assista nella sua piena realizzazione.
In ultima istanza, le divergenze tra il deposito tradizionale e il deposito telematico risultano essere differenti in quanto, il deposito telematico non garantisce nell’immediatezza la visualizzazione ad opera delle parti e del giudice; impone un limite rispetto alla quantità di documenti depositabili e alla loro natura; attribuisce al cancelliere il diritto di visionare i documenti, ancor prima del loro deposito, e di scegliere se depositarli o meno e rendere così non visibile al giudice gli atti stessi.
3.1 Disciplina relativa al procedimento di deposito
La disciplina relativa al procedimento di deposito è contenuta essenzialmente nell’art. 13 del d.m. n. 44/2011 e dalle specifiche tecniche previste dall’art. 34 dello stesso decreto.
L’art. 13, co. 1, già citato nel precedente paragrafo, prevede che
i documenti informatici [...] sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
Ancora, al co. 7 dello stesso articolo, si precisa che «il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche», e al co. 8 che
la dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche [...]. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l’avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
Oltre tale normativa, la legge altro non dispone se non all’interno delle cosiddette “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”.
L’art. 12 delle suddette specifiche tecniche, rubricato “Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento[16]”, prevede, in primis, che l’atto del processo, depositato telematicamente, abbia i seguenti requisiti: 1) è in formato PDF; 2) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna; 3) è formato da un file in formato XML, contenente tutte le informazione della nota di iscrizione a ruolo, «e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5»; è definito DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica avanzata.
In secundis, che la struttura del documento firmato è PAdES-BES o CAdES-BES; la modalità di sottoscrizione è di tipo «firme multiple indipendenti» e prevede che uno o più soggetti firmino lo stesso documento o contenuto della busta.
All’art. 13 delle specifiche tecniche si definiscono i formati dei documenti informatici allegati così come enunciato all’art. 12 del regolamento. I formati suddetti sono: 1) .pdf; 2) .rtf; 3) .txt; 4) .jpg; 5) .gif; 6) .tiff; 7) .xml; 8) .eml.
L’art. 14 disciplina la “Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del regolamento”, così come rubricato. «L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”, ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del sistema ricevente»; la busta, in particolare, contiene il file Atto.enc, prodotto dalla cifratura del file Atto.msg, il quale conterrà al suo interno: 1) l’IndiceBusta.xml; 2) DatiAtto.xml; 3) l’atto in formato PDF sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata; 4) AllegatoX.xxx la cui dimensione massima è pari a 30 Megabyte. La busta telematica, stando al co. 4, «viene trasmessa all’ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati».
In seguito a tale procedimento e in seguito all’invio del messaggio di posta elettronica certificata ha inizio il deposito telematico che si articola nelle seguenti fasi, così come formulato nell’art.14 delle specifiche tecniche: 1) il messaggio viene inviato al gestore PEC del destinatario; 2) il destinatario reca la ricevuta di accettazione della PEC; 3) il gestore PEC del mittente invia il messaggio al gestore PEC del Ministero della giustizia; 4) lo stesso reca la ricevuta di accettazione della PEC; 5) il gestore dei servizi telematici effettua il download del messaggio di PEC; 6) il gestore dei servizi telematici verifica la presenza, del titolare della PEC, nel ReGIndE; 7) il gestore dei servizi telematici effettua i controlli sulla busta telematica e le possibili anomali date dall’elaborazione della busta telematica. Le suddette anomalie, di norma, sono codificate nelle seguenti tipologie: a) Warn (anomalia non bloccante); b) Error (anomalia bloccante); c) Fatal (eccezione non gestita o non gestibile); 8) successivamente l’esito sarà trasmesso con un messaggio PEC al depositante; 9) il gestore dei servizi telematici avrà cura che la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna siano inseriti all’interno del fascicolo informatico; infine, 10) la cancelleria, ricevuto l’atto e accettato, lo inserisce nel fascicolo informatico.[17]
3.2 Le modalità alternative di deposito
Il deposito telematico di atti postumi alla costituzione in giudizio è obbligatorio in tutti i procedimenti civili, contenziosi, dal 31 dicembre 2014[18]; dal 30 giugno 2015 è ammesso il deposito telematico di atti introduttivi dei procedimenti civili davanti a tutti i tribunali e alle corti d’appello. Nei procedimenti di cui sopra, civili, contenziosi, il deposito telematico è peraltro facoltativo per tutti gli atti introduttivi; obbligatorio per i successivi atti processuali che provengono dalla parte costituita; sempre obbligatorio nel procedimento monitorio.[19]
È opportuno sottolineare che il legislatore all’art. 44, co. 2, lett. c del d.l. n. 90/2014, non fa riferimento alla nozione di atti introduttivi ma al deposito di atti processuali e dei documenti «da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite»; in conseguenza a ciò si può dedurre che il deposito cartaceo è ammesso per tutti gli atti introduttivi di un procedimento.
L’obbligatorietà del deposito telematico non esclude la facoltà o l’obbligo, a priori, del deposito cartaceo presso la cancelleria degli originali o di alcuni documenti che, previsti dalla norma, debbano essere depositati in originale.
Concludendo, il Legislatore esclude che «possa procedersi ad un deposito “misto” in virtù della facoltatività del deposito telematico»[20], sottolineando che se il difensore procede al deposito telematico, questo «si perfeziona esclusivamente con tali modalità»[21].
3.3 I termini del deposito
Secondo il disposto dell’art. 16 bis, co. 7 del d.l. n. 179/2012, il deposito con modalità telematiche «si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia».
Il deposito, nelle modalità summenzionate, sarà però visibile nel fascicolo telematico soltanto a seguito dell’accettazione della cancelleria, come disposto dall’art. 13, co. 7 del d.m. n. 44/2011[22], e inviato, con apposito messaggio, al mittente di avvenuta accettazione, a seguito dei controlli sulla busta inviata. Se nonostante l’invio della busta, successivamente ai controlli da parte della cancelleria, si dovessero riscontrare, nella scadenza del termine, dei problemi di deposito, l’avvocato potrà richiedere alla cancelleria stessa il dettaglio dell’errore.
Rispetto tale problematica, si ravvisa che l’art. 16, co. 4 del d.m. n. 44/2011 dispone che
nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, [...] viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, [...], un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto nella cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori.
Il servizio, reso disponibile sul Portale dei Servizi Telematici e sui Punti di Accesso autorizzati permette all’avvocato di accedere ad una specifica pagina web dove visionare le comunicazioni e notificazioni depositate in cancelleria e così permettere di scaricare l’avviso di mancata consegna come ricevuto dal gestore PEC del Ministero della giustizia, evitando in questo modo di recarsi personalmente in cancelleria.
Riprendendo il disposto dell’art. 16 bis, co. 7 del d.l. n. 179/2012, gli atti trasmessi in via telematica si intendono depositati nel momento in cui viene generata la RdAC (ricevuta di avvenuta consegna) da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, secondo cui
Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.
Le cancellerie provvederanno all’accettazione degli atti entro la giornata del deposito secondo l’ordine cronologico delle buste. Per gli atti pervenuti dopo le ore 12, l’accettazione sarà effettuata entro il termine della giornata se non si riscontrano incombenze d’ufficio; inoltre, se ne assicura comunque l’accettazione per il giorno successivo all’invio.[23]
Per concludere, ai fini probatori, è consigliato per l’avvocato conservare le copie di tutte le comunicazioni avvenute tramite posta elettronica certificata, riguardanti il deposito effettuato. Infatti, in caso di contestazioni circa i termini del deposito, sarà necessario ricostruire ex ante i flussi della busta telematica, nonché la ricevuta generata dal proprio gestore PEC, il messaggio PEC contenente l’avvenuta consegna della busta da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia e i messaggi provenienti dal sistema della cancelleria.
Note e Bibliografia
[1] A. BUONAFEDE, Il fascicolo informatico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 175.
[2] I termini sono utilizzati da R. GIORDANO, Fascicolo informatico e fascicolo cartaceo nel processo telematico, in Informatica e diritto, XXXIII (2007), 1-2, 182.
[3] REPUBBLICA ITALIANA, Decreto 14 ottobre 2004, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento ordinario, CLXVII (2004), 272, del 19 novembre 2004.
[4] A. BUONAFEDE, Il fascicolo informatico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 178.
[5] Ivi, 180.
[6] Cfr. S. BRESCIA - P. LICCARDO, Processo telematico, in Enciclopedia giuridica, XXIV, 5.
[7] REPUBBLICA ITALIANA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 28 ottobre 2014, in URL: < https:// www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.pagefacetNode_1=1_1%282014%29&facetNode_2=1_1% 28201410%29&facetNode_3=1_1%2820141028%29&contentId=SDC1076955&previsiousPage=mg_1_8 > (in data 10/08/ 2022).
[8] REPUBBLICA ITALIANA, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 23 ottobre 2015, in URL: < https:// www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1187890&previsiousPage=mg_1_8_1 > (in data 10/08/2022).
[9] REPUBBLICA ITALIANA, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CXXXI (2013), 154, del 6 giugno 2013.
[10] A. BUONAFEDE, Il fascicolo informatico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 185.
[11] Ivi, 188.
[12] REGNO D'ITALIA, Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Supplemento ordinario, CCCII (1941), 302, del 24 dicembre 1941.
[13] Cfr. G. RUFFINI, Il processo civile di fronte alla svolta telematica, in Rivista di diritto processuale, LXXIV (2019), 4-5, 976-977.
[14] N. SOTGIU, Il deposito telematico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 226.
[15] Ivi, 227.
[16] “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” in REPUBBLICA ITALIANA, Decreto 21 febbraio 2011, n. 44, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, LXXXIX (2011), 152, del 18 aprile 2011.
[17] L’intera trattazione è ampiamente sviluppata in N. SOTGIU, Il deposito telematico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 241.
[18] Secondo il dettato dell’art. 16 bis, co. 1 del d.l. n. 179/2012 «a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto [...] e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». Con l’art. 44 del d.l. n. 90/2014 si prevede che il suddetto articolato si applichi «esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest’ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità».
[19] L’intera trattazione è ampiamente sviluppata in N. SOTGIU, Il deposito telematico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 228-236.
[20] N. SOTGIU, Il deposito telematico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 238.
[21] Art. 16 bis, co. 1 bis del d.l. n. 179/2012.
[22] «Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34».
[23] Cfr. N. SOTGIU, Il deposito telematico, in G. RUFFINI (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 249.
Bibliografia
BRESCIA S., LICCARDO P., Processo telematico, in Enciclopedia giuridica, XXIV, 5.
BUONAFEDE A., Il fascicolo informatico, in RUFFINI G. (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 175.
FRANCISCIUS PP., Litterae apostolicae motu proprio datae “Mitis Iudex Dominus Iesus”, 15 augusti 2015, in AAS CVII (2015), 959.
GIORDANO R., Fascicolo informatico e fascicolo cartaceo nel processo telematico, in Informatica e diritto, XXXIII (2007), 1-2, 182.
RUFFINI G., Il processo civile di fronte alla svolta telematica, in Rivista di diritto processuale, LXXIV (2019), 4-5, 976-977.
SOTGIU N., Il deposito telematico, in RUFFINI G. (cur.), Il processo telematico nel sistema del diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 2019, 226.
REGNO D'ITALIA, Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, in Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Supplemento ordinario, CCCII (1941), 302, del 24 dicembre 1941.
REPUBBLICA ITALIANA, Decreto 14 ottobre 2004, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento ordinario, CLXVII (2004), 272, del 19 novembre 2004.
REPUBBLICA ITALIANA, Decreto 21 febbraio 2011, n. 44, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, LXXXIX (2011), 152, del 18 aprile 2011.
REPUBBLICA ITALIANA, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2013, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, CXXXI (2013), 154, del 6 giugno 2013.
REPUBBLICA ITALIANA. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 28 ottobre 2014, in URL: < https:// www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=1_1%282014%29&facetNode_2=1_1%28201410 %29&facetNode_3=1_1%2820141028%29&contentId=SDC1076955&previsiousPage=mg_1_8 > (in data 10/08/ 2022).
REPUBBLICA ITALIANA. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Circolare 23 ottobre 2015, in URL: < https:// www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC1187890&previsiousPage=mg_1_8_1 > (in data 10/08/2022).

