La nuova proposta della Commissione europea per rafforzare il controllo degli investimenti esteri da parte dell’UE
Modifica pagina
Luigimaria Riccardi
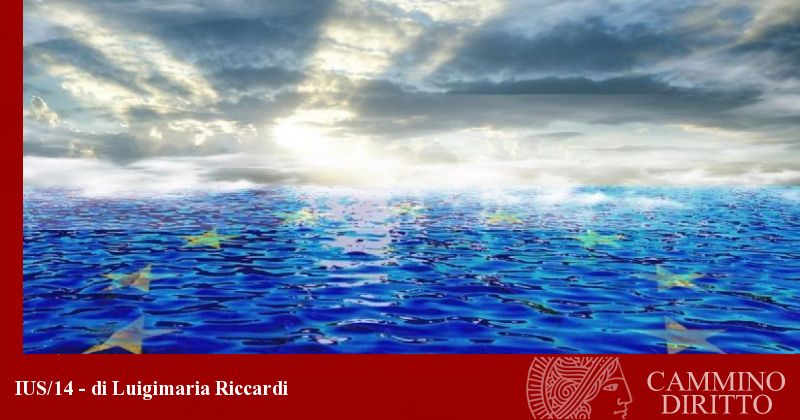
Il 24 gennaio 2024, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento in cui propone misure per monitorare e valutare gli investimenti esteri. L´obiettivo è quello di fornire all´Unione strumenti di controllo più efficaci sugli investimenti effettuati da imprese dell´UE in Stati terzi. Come verrà esaminato più dettagliatamente di seguito, lo scopo principale di questa iniziativa è valutare i rischi per la sicurezza che potrebbero sorgere quando le tecnologie sensibili sono trasferite dall’UE e potrebbero essere sfruttate da Stati terzi in modo da minacciare la pace e la sicurezza internazionali.
 ENG
ENG
The new proposal of the European Commission to extend the control of foreign investments by the EU
On 24 January 2024, the EU Commission published a proposal for a regulation proposing measures to monitor and evaluate foreign investments. The aim is to strengthen the control of outbound investments, i.e. investments made by EU companies in third countries. As will be examined in more detail below, the aim of this initiative is to assess the security risks that could arise when sensitive technologies are transferred from the EU and could be exploited by third states in a way that threatens international security . This paper carries out some critical reflections on the new proposal of the European Commission regarding the control of foreign direct investments, compared it to Regulation (EU) 2019/452 currently in force, also in light of the jurisprudence of Court of Justice of EU.Sommario: 1. Introduzione; 2. Il contesto in cui sono state adottate le nuove misure di controllo sugli investimenti esteri; 3. La causa Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. c. Innovációs és Technológiai Miniszter della Corte di giustizia; 4. Il quadro giuridico delle iniziative della Commissione europea sul controllo degli investimenti esteri; 5. Considerazioni conclusive.
1. Introduzione
Il 24 gennaio 2024, la Commissione europea ha pubblicato una proposta di regolamento in cui introduce nuove misure per controllare gli investimenti esteri diretti[2]. Lo scopo è quello di monitorare e valutare gli investimenti investimenti effettuati da imprese dell’UE in Stati terzi. Come verrà esaminato più dettagliatamente di seguito, lo scopo principale di questa iniziativa è valutare i rischi per la sicurezza che potrebbero sorgere quando le tecnologie sensibili sono trasferite dall’UE e potrebbero essere sfruttate da Stati terzi in modo da minacciare la pace e la sicurezza internazionali.
L’azione dell’UE nel settore del controllo degli investimenti esteri rappresenta una vera novità. Né l’UE né gli Stati membri hanno ancora adottato quadri giuridici uniformi per controllare gli investimenti in uscita, e solo pochissimi Stati terzi hanno adottato o annunciato l’esistenza di tali meccanismi di controllo. Ma anche questa iniziativa non sembra essere nata del tutto dal nulla. Il contesto più ampio dell’azione dell’UE nel settore della sicurezza economica e della politica commerciale è stato recentemente piuttosto movimentato. Innanzitutto, il Libro bianco sugli investimenti in uscita è stato pubblicato come parte di un pacchetto di iniziative volte a migliorare la sicurezza economica dell’UE[3]. Queste iniziative includono anche una proposta legislativa per un nuovo regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri (“IED”) che dovrebbe sostituire il regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri attualmente in vigore (regolamento (UE) 2019/452)[4], rafforzando il quadro normativo e introducendo ulteriori elementi. Il pacchetto contiene anche un Libro bianco sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, cioè di beni e tecnologie che possono avere applicazioni sia civili che militari. Sebbene esistano già quadri multilaterali sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, per prevenire la proliferazione delle armi, l’UE propone misure per uniformare il controllo tra gli Stati membri dell’Unione.
Più in generale, l’UE ha cercato di rinnovare la propria politica commerciale e di intensificare la propria strategia di sicurezza economica rafforzando la cooperazione e l’armonizzazione in questo settore. Il pacchetto del 24 gennaio 2024 fa seguito a una comunicazione del 20 giugno 2023[5] della Commissione e dell'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in cui è stato proposto un quadro comune per rafforzare la sicurezza economica e ridurre al minimo i rischi derivanti da alcuni fattori economici globali. Inoltre, dall’ottobre 2020 è in vigore l’attuale Regolamento sullo screening degli IED, già citato in precedenza. Tale Regolamento introduce un quadro giuridico per identificare e mitigare i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico derivanti dagli investimenti di società straniere nell’UE (ad esempio, in casi in cui aziende straniere acquisiscono aziende dell’Unione attive in settori critici per gli interessi strategici dell’UE). Se un investimento di questo tipo mette effettivamente in pericolo tali interessi, può essere vietato. Inoltre, l’UE ha adottato anche il regolamento sulle sovvenzioni estere (regolamento (UE) 2022/2560)[6], entrato in vigore nel luglio 2023. Il presente regolamento stabilisce una nuova serie di norme per affrontare le distorsioni della concorrenza causate dalle sovvenzioni estere nel mercato unico dell’UE. Più specificamente, mentre gli Stati membri dell’UE non possono concedere determinati sussidi alle loro aziende nell’ambito del quadro normativo sugli aiuti di Stato dell’UE, i governi di Stati terzi possono spesso farlo, poiché non hanno questa limitazione. Pertanto, le imprese straniere potrebbero avere un vantaggio rispetto alle società dell’UE se operano nel mercato unico ricevendo sussidi dai loro governi. Il regolamento sulle sovvenzioni estere conferisce alla Commissione il potere di imporre misure contro le società straniere per neutralizzare gli effetti distorsivi di tali sussidi.
C’è un obiettivo comune che sostiene queste iniziative nel contesto della politica commerciale ed economica dell’UE: lo scopo è, infatti, quello di mitigare alcuni squilibri e alcuni rischi per l’ordine pubblico e la sicurezza economica derivanti dall’integrazione nell’economia globalizzata, garantendo allo stesso tempo che l’UE rimanga aperta al commercio e agli investimenti. Ciò è coerente con la priorità politica generale dell’UE di raggiungere la cosiddetta Autonomia Strategica Aperta[7], l’attuale strategia dell’Unione che, attraverso iniziative come quelle sopra descritte, cerca di trovare un equilibrio tra sicurezza e competitività che garantisca la futura capacità dell’UE di agire autonomamente quando e dove richiesto e di collaborare con i partner commerciali ove tale cooperazione sia in concreto possibile[8].
Il presente contributo ha lo scopo di svolgere alcune riflessioni critiche sulle novità introdotte dalla proposta della Commissione europea in materia di controllo degli investimenti esteri diretti. Ciò verrà fatto tenendo in considerazione la disciplina prevista nell’attuale Regolamento (UE) 2019/452 in vigore e alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE.
2. Il contesto in cui sono state adottate le nuove misure di controllo sugli investimenti esteri
È importante evidenziare che per investimento estero diretto s’intende, come stabilito nell’art. 2 del regolamento 2019/452[9], un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l’investitore estero e l’imprenditore o l’impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un’attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un’attività economica. Il legame durevole è riscontrato, ad esempio, qualora l’investitore diretto possieda almeno il 10 % del capitale sociale con diritto di voto dell’impresa affiliata. Dal punto di vista dell’UE, gli IED sono investimenti effettuati da società o investitori extra-UE nell’UE, con l’obiettivo di stabilire un collegamento diretto tra l’entità estera e un’entità dell’UE che svolge un’attività economica in uno o più Stati membri. Un IED può essere, ad esempio, l’acquisizione di una società stabilita nell’UE da parte di una società extra-UE o la creazione da parte di quest’ultima di una joint venture nell’UE. Gli investimenti in uscita, invece, seguono la direzione opposta: si verificano quando aziende o investitori dell’UE effettuano investimenti al di fuori dell’UE, mettendo a disposizione capitali per svolgere attività economiche in paesi extra-UE. Ancora una volta, come indicato più in dettaglio di seguito, esempi sono le acquisizioni di aziende all'estero o la costituzione di joint venture per operare in Stati terzi.
La disciplina del controllo degli IED ha oggi assunto un ruolo centrale, in ragione della necessità sempre crescente di tutelare la stabilità dei mercati degli Stati membri dell’UE, salvaguardando l’esistenza delle risorse strategiche da attacchi speculativi provenienti di investitori di Stati terzi. Proprio per affermare l’importanza di adeguate forme di tutela, nel marzo del 2019, è stato adottato il Regolamento UE 2019/452 sul golden power[10], istituendo un quadro di riferimento uniforme per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione, volto a coordinare gli interventi dei singoli Stati membri.
Appare importante, quindi, esaminare come tale disciplina possa coniugarsi con le libertà fondamentali dell’Unione europea, di tutela della concorrenza e del diritto di stabilimento e alla libertà di circolazione dei capitali.
Il Regolamento del 2019 istituisce un quadro per lo screening degli IED nell’Unione (nel prosieguo “Regolamento IED”) sulla base dell’art. 207 del TFUE. Il Regolamento disciplina il coordinamento dei meccanismi di “screening” nazionali con l’obiettivo di controllare gli investimenti esteri diretti da parte di Stati terzi. Il Regolamento non limita il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto né impone l’adozione di un meccanismo di controllo. Inoltre, il 25 marzo 2020 la Commissione ha adottato la Comunicazione sugli orientamenti agli Stati membri in vista dell’applicazione del Regolamento UE 2019/452[11]. Essa contiene le linee guida per far fronte alle preoccupazioni sollevate da più parti in relazione ai rischi connessi all’indebolimento dell’apparato finanziario ed economico negli Stati membri dell’UE e a possibili operazioni predatorie volte all’acquisizione di società operanti in settori strategici, come l’energia. L’obiettivo principale è, infatti, quello di tutelare “assets” strategici operanti nei settori della sanità, della ricerca medica, della biotecnologia e delle infrastrutture, ma anche quelli che sono altrimenti essenziali per la sicurezza e l’ordine pubblico dell’UE come quelli in materia di infrastrutture energetiche. Nelle linee guida la Commissione esorta gli Stati membri a fare pieno uso di tutti i meccanismi di screening degli IED pertinenti per evitare che possano avvenire tentativi di acquisizione, tramite investimenti diretti esteri, di aziende della filiera dell’assistenza sanitaria (ad esempio per la fabbricazione di dispositivi medici o di protezione) o di settori correlati, quale quello degli istituti di ricerca (ad esempio lo sviluppo di vaccini). Questa attenzione si può estendere anche ad altri settori critici, come quello delle società che controllano nell’Unione gli impianti di energia. Infatti, la Commissione ha sottolineato che la questione relativa al controllo degli IED (spettante agli Stati membri) va ben oltre il settore sanitario e riguarda, più in generale, le capacità strategiche dell’UE in senso lato che possono essere minacciate a seguito della volatilità e della diminuzione di valore dei titoli presenti nei mercati azionari europei. La Commissione ha evidenziato l’importanza di evitare che la crisi attuale porti alla perdita di beni e tecnologie critiche, come nel settore dell’energia.
Il Regolamento UE 2019/452 attualmente in vigore richiama il rispetto delle libertà di circolazione dei capitali e il diritto di stabilimento[12] come limite entro cui i meccanismi di controllo degli investimenti stranieri previsti da ciascuno Stato membro devono muoversi. Del resto, la Commissione europea aveva già evidenziato l’incompatibilità di provvedimenti nazionali atti ad incidere sulle libertà fondamentali, ammettendo possibili deroghe solo laddove fondate su criteri obiettivi, stabili e resi pubblici e giustificati da motivi imperiosi di interesse generale e nel rispetto del principio di proporzionalità[13]. La Corte di giustizia ha poi avuto modo di statuire più volte, che, se è vero che i principi della libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali possono subire limitazioni, è altrettanto vero che tali limiti debbano essere interpretati e applicati in modo rigorosamente restrittivo, secondo modalità non discriminatorie, giustificate dal perseguimento di interessi generali e strettamente proporzionate all’obiettivo che devono raggiungere. In particolare, con riferimento alla libertà di circolazione dei capitali, la Corte ha avuto modo in passato di pronunciarsi proprio sulla legittimità della normativa francese che stabiliva un’autorizzazione preventiva per gli investimenti esteri, chiarendo che tali restrizioni non possono essere determinate unilateralmente da ciascuno Stato membro senza il controllo delle istituzioni comunitarie, che “l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza possono [...] essere invocati solamente in caso di minaccia effettiva ed abbastanza grave ad uno degli interessi fondamentali della collettività” e “tali motivi non possono essere distolti dalla propria funzione per essere utilizzati in realtà a fini puramente economici [...], che ogni persona colpita da un provvedimento restrittivo basato su una deroga di tal genere deve poter disporre di un rimedio giuridico”[14]. Da tutto ciò deriva che l’ordinamento dell’Unione riconosce la legittimità della disciplina del controllo degli investimenti esteri, ma a condizione che le restrizioni apposte alle libertà fondamentali vadano ricomposte attraverso l’individuazione di limiti interni, assicurando un bilanciamento tra le diverse istanze.
Dopo aver esaminato il reg. 2019/452, appare importante richiamare la causa Xella Magyarország [15] della Corte di giustizia. La sentenza è importante in quanto rappresenta la prima pronuncia sulla compatibilità tra il diritto dell’UE e i meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti.
3. La causa Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. c. Innovációs és Technológiai Miniszter della Corte di giustizia
Il 13 luglio, con la sentenza nella causa Xella Magyarország, la Corte di giustizia si è pronunciata per la prima volta sulla compatibilità con il diritto dell’Unione dei meccanismi di controllo sugli investimenti esteri diretti oggi presenti in larga parte degli Stati membri con specifico riferimento alla disciplina ungherese. Si anticipa sin d’ora che la Corte di giustizia ha chiarito che laddove nell’operazione di investimento siano coinvolte società dell’Unione la questione deve essere affrontata in base all’art. 54 del TFUE sul diritto di stabilimento e che gli Stati membri non possono invocare tra i motivi di ordine pubblico e di sicurezza che eccezionalmente ne giustificano una limitazione fini puramente economici. Nei fatti, il ministro ungherese per l’innovazione e la tecnologia ha vietato l’acquisizione di Janes és Társa Kft da parte di Xella per motivi di interesse nazionale. Il ministro ha ritenuto che Xella, una società ungherese indirettamente controllata da una società registrata alle Bermuda, fosse qualificata come investitore straniero e che la società interessata, la cui attività principale era l’estrazione di ghiaia, sabbia e argilla, fosse una società strategica. L’acquisizione, secondo il Ministro, avrebbe minato l’interesse nazionale e avrebbe creato un rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime nel settore edile, in particolare nella regione della società target. Xella ha contestato la decisione del Ministro davanti all’Alta Corte di Budapest, sostenendo che essa violava i suoi diritti derivanti dalla libera circolazione dei capitali. Tale Corte ha quindi chiesto alla Corte di giustizia dell’UE una pronuncia pregiudiziale sulla compatibilità del meccanismo ungherese di controllo degli investimenti diretti esteri con il diritto dell’UE, in particolare con il regolamento UE 2019/452[16] e la libera circolazione dei capitali.
Come evidenziato nelle conclusioni dell’Avvocato generale Ćapeta nel caso Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. c. Innovációs és Technológiai Miniszter[17] è possibile individuare una certa sovrapposizione giuridica generata dall’aggiunta degli IED nella PCC rispetto alla competenza concorrente in materia di mercato interno. Alla luce di tale situazione, gli IED possono rientrare anche nella disciplina sulla libera circolazione dei capitali e, quindi, nell’ambito di applicazione del mercato interno. Tuttavia, è utile rilevare che, qualora l’investimento attraversi solo le frontiere interne dell’Unione, esso può rientrare nell’ambito di applicazione sia della libertà di stabilimento, ai sensi degli artt. 49 e 54 del TFUE che della libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’art. 63, c. 1 del TFUE, a seconda della forma di partecipazione considerata. Pertanto, da un lato, gli IED, vale a dire la partecipazione ad un’impresa che consente all’investitore di partecipare effettivamente alla gestione e al controllo di quest’ultima, sono disciplinati dalle norme in materia di libertà di stabilimento. Dall’altro lato, gli investimenti a breve termine o minoritari, vale a dire di portafoglio, ad. es., l’acquisto di partecipazioni al solo scopo di realizzare un investimento finanziario, senza intenzione di influire sulla gestione e sul controllo dell’impresa, devono essere esaminati esclusivamente alla luce della libera circolazione dei capitali.
La Corte di giustizia ha innanzitutto individuato il diritto dell’UE applicabile al caso concreto. A tal riguardo, ha ritenuto che l’acquisizione in questione non rientrasse nell’ambito di applicazione del regolamento 2019/452[18]. Tale regolamento, infatti, è limitato agli IED, vale a dire agli investimenti nell’UE effettuati da imprese costituite o altrimenti organizzate secondo le leggi di uno Stato terzo; quindi, non quando una società dell’UE sta acquisendo un’altra società dell’Unione, anche se l’acquirente è di proprietà di investitori extra-UE.
Essendo Xella qualificabile come una società dell’UE, la Corte di giustizia è passata ad esaminare quale libertà fosse violata nel caso concreto. La Corte ha ritenuto che fosse applicabile la libertà di stabilimento, poiché la normativa nazionale riguardava solo le partecipazioni che consentono al titolare di esercitare una sicura influenza sulle decisioni di una società e di determinarne le attività[19].
La posizione della Corte comporta dunque che gli investitori di Stati terzi in società dell’UE beneficiano delle norme sulla libera circolazione sancite dal TFUE, mentre rientrano nel campo di applicazione del Regolamento 2019/452 quando effettuano altri investimenti una volta che sono stabiliti all’interno dell’UE. Il sistema di screening stabilito nel Regolamento si applicherebbe, quindi, solo al momento del primo ingresso di un investimento nell’UE. Ciò implica che gli investitori extra-UE sono incentivati a dirigere i loro primi investimenti in Stati membri dell’UE che hanno un approccio più flessibile allo screening degli investimenti esteri. Infatti, il Regolamento non impone agli Stati membri di predisporre un sistema di screening[20]. L’obiettivo stesso del Regolamento di vagliare gli investimenti esteri alla ricerca di potenziali minacce alla sicurezza e all’interesse pubblico potrebbe essere aggirato (quest’ultima, tra l’altro, era la posizione dell’Avvocato Generale Ćapeta, di cui però la Corte ha scelto di non tenere conto). Infatti, la decisione di investimento sarebbe sì adottata da un investitore con sede nell’UE e quindi fuori dall’ambito di applicazione del Regolamento, ma indirettamente da una società extra-UE. Inoltre, poiché la sentenza conferma un elevato standard nel giustificare qualsiasi decisione dello Stato di bloccare gli investimenti esteri o consentirli solo a determinate condizioni, i regimi nazionali che prevedono criteri permissivi per bloccare le operazioni, dovranno valutare se questi sono conformi al diritto dell’UE.
La sentenza Xella apre la strada, quindi, a possibili contestazioni di decisioni nazionali restrittive in ordine agli investimenti esteri.
Come accennato, gli investimenti in entrata sono già ampiamente oggetto delle norme dell’UE e degli Stati membri. Nell’ambito dei quadri di screening degli IED nazionali e dell’UE, gli investimenti in entrata sono controllati e potenzialmente vietati se comportano l’acquisizione da parte di entità straniere di risorse o tecnologie sensibili. Il rischio legato a tali acquisizioni si concretizza solitamente in termini di minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico se l’entità acquirente potrebbe utilizzare le attività acquisite in un modo dannoso per l’interesse pubblico dello Stato che ospita l’investimento o dell’UE. In poche parole, quindi, lo scopo dei sistemi di screening degli investimenti esteri diretti è quello di evitare l’acquisizione di risorse e tecnologie critiche da parte di entità ostili. Da questo punto di vista, però, il nuovo Libro bianco sugli investimenti in uscita evidenzia una lacuna esistente nel quadro giuridico dell’UE. La Commissione spiega che il trasferimento di tecnologie critiche a entità straniere potrebbe verificarsi anche se le aziende dell’UE portassero tali tecnologie all’estero quando investono al di fuori dell’UE. Sebbene questo rischio sia simile a quello che i sistemi di screening degli investimenti in entrata cercano di affrontare, non esiste un quadro giuridico in vigore per monitorare e valutare gli investimenti in uscita.
In una fase iniziale, tuttavia, non è ancora chiaro se un eventuale meccanismo di controllo degli investimenti in uscita, come proposto dalla Commissione, possa garantire di superare i medesimi punti deboli dell’attuale regolamento del 2019. Quest’ultimo menziona la necessità di controllare gli investimenti in entrata per motivi di «sicurezza e ordine pubblico, un concetto interpretato in modo piuttosto ampio, poiché il regolamento prevede, ad esempio, che gli Stati membri esaminino gli effetti su un’ampia gamma di settori, dall’energia alle telecomunicazioni alla sicurezza alimentare e al pluralismo dei media. D’altro canto, si anticipa sin d’ora che il Libro bianco sugli investimenti in uscita sembra riferirsi principalmente alla necessità di prevenire la fuga di un «insieme ristretto di tecnologie avanzate che potrebbero far avanzare le capacità militari e di intelligence di attori che potrebbero utilizzare queste capacità per minacciare la pace internazionale e sicurezza. Dal punto di vista dei prodotti, come spiegato più dettagliatamente di seguito, il Libro bianco afferma che il monitoraggio degli investimenti in uscita dovrebbe inizialmente concentrarsi sulle tecnologie più sensibili, come i semiconduttori avanzati, l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e le biotecnologie. Dal punto di vista del rischio, il monitoraggio dovrebbe concentrarsi sul possibile utilizzo di queste tecnologie per scopi militari, ad esempio nei conflitti, per violazioni dei diritti umani e per la proliferazione di armi di distruzione di massa.
In considerazione di ciò, la proposta avanzata dalla Commissione sembra suggerire che il controllo degli investimenti in uscita potrebbe avere una portata più ristretta rispetto a quella del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti. Tuttavia, è ancora difficile prevedere come si svilupperà questo nuovo possibile quadro giuridico.
4. Il quadro giuridico delle iniziative della Commissione europea sul controllo degli investimenti esteri
Nella sua proposta, la Commissione introduce una novità giuridica che ha una portata di un certo tenore, con implicazioni relative all’ambito di applicazione dell’attuale Reg. 452/2019 e al diritto di veto degli Stati membri. Vengono, cioè, recepite le indicazioni della recente giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza Xella sopra esaminata. Sebbene la misura non riguardi specificatamente il settore dell’energia, lo scopo principale di questa iniziativa è valutare i rischi per la sicurezza che potrebbero sorgere quando le tecnologie sensibili sono trasferite dall’UE e potrebbero essere sfruttate da Stati terzi in modo da minacciare la pace e la sicurezza internazionali. L’azione dell’UE in questo settore rappresenta una novità. Né l’UE né gli Stati membri hanno ancora adottato quadri giuridici uniformi per controllare gli investimenti in uscita, e solo pochissimi Stati terzi hanno adottato o annunciato l’esistenza di tali meccanismi di controllo. Ma anche questa iniziativa non sembra essere nata del tutto dal nulla. Il contesto più ampio dell’azione dell’UE nel settore della sicurezza economica e della politica commerciale è stato recentemente oggetto di esame. Il Libro bianco sugli investimenti in uscita è stato pubblicato come parte di un pacchetto di iniziative[21] volte a migliorare la sicurezza economica dell’UE.
Queste iniziative includono anche una proposta legislativa[22] per l’adozione di un nuovo regolamento sul controllo degli investimenti diretti esteri che dovrebbe sostituire il regolamento sul controllo attualmente in vigore (regolamento (UE) 2019/452), rafforzando il quadro normativo e introducendo ulteriori elementi. Al contrario dell’attuale Regolamento 2019/452, la proposta impone obblighi minimi di screening. In particolare, gli Stati membri sono tenuti a sottoporre ad autorizzazione gli investimenti esteri nel caso in cui la società target[23]: a) prenda parte a un programma o a un progetto di interesse dell’Unione, anche come destinatario di fondi[24], elencati nell’Allegato I alla Proposta; o b) sia attiva in aree di particolare interesse, indicate all’Allegato II alla Proposta[25]. Nell’ambito dei quadri di screening degli investimenti esteri dell’UE, gli investimenti in entrata sono controllati e potenzialmente vietati se comportano l’acquisizione da parte di entità straniere di risorse o tecnologie sensibili. Il rischio legato a tali acquisizioni si concretizza solitamente in termini di minaccia alla sicurezza e all’ordine pubblico se l’entità acquirente può utilizzare le attività acquisite in un modo dannoso per l’interesse pubblico dello Stato che ospita l’investimento o dell’UE. Pertanto, lo scopo dei sistemi di screening degli investimenti esteri diretti è quello di evitare l’acquisizione di risorse e tecnologie critiche da parte di entità ostili. Da questo punto di vista, però, il nuovo Libro bianco sugli investimenti in uscita evidenzia una lacuna esistente nel quadro giuridico dell’UE. La Commissione spiega che il trasferimento di tecnologie critiche a entità straniere potrebbe verificarsi anche se le aziende dell’UE portassero tali tecnologie all’estero quando investono al di fuori dell’UE. Sebbene questo rischio sia simile a quello che i sistemi di screening degli investimenti in entrata cercano di affrontare, non esiste un quadro giuridico in vigore per monitorare e valutare gli investimenti in uscita.
È stato annunciato un periodo di monitoraggio limitato nel tempo degli investimenti in uscita dagli Stati membri in tecnologie avanzate che potrebbero essere utilizzate per lo sviluppo di capacità militari e di intelligence di Stati terzi che potrebbero minacciare la sicurezza dell’UE (inizialmente questi settori comprendono semiconduttori avanzati, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche e biotecnologie). Un fattore rilevante che il Libro bianco considera per il monitoraggio degli investimenti in uscita è la copertura geografica. Anche se nessuno Stato terzo di destinazione dell’investimento dovrebbe essere escluso a priori dallo screening, la Commissione suggerisce che gli Stati membri dovrebbero dare priorità agli investimenti diretti agli Stati terzi che presentano un profilo di rischio più elevato. Se è vero che il 70% degli investimenti in uscita sono stati diretti verso Stati Uniti e Regno Unito, questo criterio geografico potrebbe limitare il numero di investimenti potenzialmente critici e il loro controllo. Ancora una volta, tuttavia, potrebbe essere rilevante notare che ci sono esempi di investimenti diretti esteri effettuati da entità dell’UE che sono stati bloccati da uno Stato membro dell’UE (un esempio che risale al novembre 2023 è il divieto da parte dell’Italia di un progetto di acquisizione di un’impresa italiana obiettivo di un’azienda francese del settore aerospaziale)[26]. Il Libro bianco suscita dubbi sul periodo coperto dal monitoraggio, suggerendo che dovrebbe concentrarsi sulle transazioni effettuate a partire da gennaio 2019 e fornendo un elenco delle informazioni che gli Stati membri dovrebbero raccogliere sugli investimenti in uscita durante la fase di monitoraggio. In breve, tali informazioni dovrebbero includere tutti i dati necessari per effettuare una valutazione del rischio. L’insieme dei dati è piuttosto ampio e comprende informazioni sulle parti e sui loro proprietari, i settori e le tecnologie coinvolte, le tempistiche, il valore dell’investimento, ecc. Un’altra questione che gli Stati membri devono affrontare è come effettuare il monitoraggio, che è un’attività piuttosto nuova per le autorità pubbliche. Queste ultime dovrebbero essere in grado di raccogliere informazioni sugli investimenti in uscita in modo efficace. A tal fine, la Commissione suggerisce agli Stati membri di designare un’autorità responsabile del monitoraggio e dell’utilizzo, nella misura del possibile, degli strumenti esistenti che potrebbero servire a questo nuovo scopo. Gli Stati membri avranno probabilmente un margine di manovra su come organizzare l’attività. Alcuni degli strumenti esistenti suggeriti dal Libro bianco sono gli obblighi di segnalazione alle banche centrali, agli uffici statistici nazionali e alle autorità di esportazione.
Più in generale, l’UE ha cercato di rinnovare la propria politica commerciale e di intensificare la propria strategia di sicurezza economica rafforzando la cooperazione e l’armonizzazione in questo settore. Il pacchetto del 24 gennaio 2024 fa seguito a una comunicazione del 20 giugno 2023 della Commissione e dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che propone un quadro comune per rafforzare la sicurezza economica e ridurre al minimo i rischi derivanti da alcuni fattori economici globali[27]. Il pacchetto, inoltre, contiene anche un Libro bianco sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso[28], cioè di beni e tecnologie che possono avere applicazioni sia civili che militari. Sebbene esistano già quadri multilaterali sul controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, per prevenire la proliferazione delle armi, l’UE propone misure per uniformare il controllo tra gli Stati membri.
È inoltre in corso un processo di revisione dei meccanismi di sostegno esistenti per la ricerca e lo sviluppo che coinvolgono tecnologie con potenziale a duplice uso. Infine, la Commissione propone una raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza della ricerca. La strategia sulla sicurezza economica del 2023 ha individuato quattro rischi specifici, vale a dire quelli riguardanti le catene di approvvigionamento, la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche, la sicurezza tecnologica e il trasferimento di tecnologia fuori dall’UE e l’utilizzo della dipendenza economica come potenziale arma coercitiva sugli Stati membri dell’Unione. Tutti questi guideranno il processo di riforma sul controllo in materia di investimenti esteri e costituiranno i principali parametri di salvaguardia contro gli investimenti stranieri provenienti da Stati terzi.
Da una prima analisi della Proposta si può intravedere il tentativo dell’Unione di imporre obblighi ulteriori in capo agli Stati membri, armonizzando la materia in misura più significativa di quanto avvenuto con il regolamento del 2019. Ne è prova la circostanza che la base giuridica non è soltanto l’art. 207 TFUE, ma anche l’art. 114 TFUE. Ci si è chiesti in dottrina, quindi, se l’erosione della sovranità degli Stati membri, generata dalla Proposta che sostituisce il vecchio regolamento del 2019, sia legittima oppure no[29]. Di certo la Proposta della Commissione implica un rafforzamento della dimensione dell’Unione insita nella procedura di controllo. Oltre alle già citate raccomandazioni, la Proposta non incide soltanto sull’investimento effettuato dal soggetto extra-UE, come già stabilito nel regolamento del 2019, dal momento che soggetti allo screening devono essere, come scritto nell’articolo 2 della Proposta, anche gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati da un investitore estero “attraverso la propria impresa figlia nell’Unione”. Rientrano, quindi, gli investimenti con “controllo estero”, a prescindere dallo status formale dell’impresa che li effettua, in linea con l’approccio, funzionale, che ispira il regolamento sui sussidi esteri. Inoltre, la Proposta semplifica, armonizza, riduce gli oneri e i costi per Stati e imprese – soprattutto per quelle che intendono notificare operazioni in più di uno Stato membro – e rende più trasparenti le procedure che coinvolgono lo Stato ospite dell’investimento, gli altri Stati e l’Unione, come già evidenziato nello special report del dicembre 2023 dalla Corte dei conti dell’Unione[30]. Tale rafforzamento della dimensione dell’UE comporterebbe il contrasto alle asimmetrie tra Stati membri. Si pensi che in alcuni Stati membri, ad oggi, l’investimento può essere effettuato prima del ricevimento del nulla osta in relazione agli effetti sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, mentre in altri casi l’investimento può essere completato solo previa autorizzazione a norma del meccanismo di controllo.
Le iniziative della Commissione europea si trovano ancora in una fase troppo iniziale per poter prevedere i risultati a cui porterà il processo sopra delineato. Certamente, monitorare gli investimenti in uscita sembra essere un’impresa importante ed impegnativa. Come accennato in precedenza, l’ambito del monitoraggio appare ampio e un primo punto interrogativo riguarda se gli Stati membri saranno in grado di raccogliere dati significativi senza la collaborazione delle aziende coinvolte e degli Stati di destinazione. Se i dati potranno essere raccolti, resta da vedere se saranno sufficientemente specifici e affidabili da poter effettuare controllo effettivo del rischio che tali investimenti comportano. Un ulteriore spunto di riflessione che questa iniziativa potrebbe alimentare, anche se è ancora presto per esprimere commenti di dettaglio, si lega alla necessità di trovare il giusto equilibrio tra apertura del mercato e protezione e mitigazione del rischio da interferenze esterne, un bilanciamento che risulta molto complesso da raggiungere. Per la loro stessa natura, le misure volte ad affrontare i rischi per la sicurezza pubblica generalmente non si adattano agli approcci multilaterali, poiché riguardano l’esercizio dei poteri sovrani (il controllo degli investimenti esteri diretti, ad esempio, è ancora di competenza degli Stati membri pur rientrando i primi nella competenza esclusiva dell’UE ai sensi dell’art. 207 TFUE).
In ogni caso, l’adozione di misure giuridiche in materia di controllo sugli investimenti esteri diretti crea ancora tensioni tra gli Stati membri e l’UE e tende a innalzare barriere al commercio internazionale. Gli oneri giuridici per le imprese dell’UE che cercano di operare a livello internazionale, soprattutto in settori altamente tecnologici, che riguardano oggi soprattutto il settore dell’energia, devono fare i conti con l’assenza di una normativa certa e uniforme in materia di investimenti nell’ambito dell’UE. Questa mancanza potrebbe rappresentare un’ulteriore sfida che le autorità di regolamentazione saranno chiamate a tenere presente nel percorso verso un possibile meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti, soprattutto verso Stati terzi.
5. Considerazioni conclusive
L’iniziativa di monitoraggio degli investimenti esteri della Commissione è sicuramente innovativa e, allo stesso tempo, coerente con il contesto in cui l’UE sta intensificando gli sforzi per rafforzare la sicurezza economica[31].
In materia di controllo sugli investimenti esteri, la sentenza Xella è importante in quanto rappresenta la prima pronuncia sulla compatibilità tra il diritto dell’UE e i meccanismi di controllo degli investimenti esteri diretti. Nella sentenza Xella la Corte ha chiarito il concetto di “investimento estero diretto” adottando un’interpretazione restrittiva delle definizioni riportate nel Regolamento. L’investitore è estero, e l’investimento si qualifica come investimento estero diretto, solamente nel caso in cui la società che esegue l’investimento o l’operazione è costituita in un Paese terzo. La Corte qualifica, dunque, come soggetti europei le società costituite in uno Stato membro da soggetti extra-europei. La proposta di regolamento della Commissione europea sul controllo degli investimenti esteri[32] recepisce quanto affermato dalla Corte e rafforza la posizione dell’UE sul controllo degli investimenti esteri rispetto al regolamento del 2019. La nuova proposta della Commissione cerca di armonizzare le discipline degli Stati membri ed evitare così asimmetrie giuridiche tra gli stessi. L’espansione dei poteri della Commissione europea, l’imposizione di vincoli ulteriori in capo agli Stati circa i meccanismi di notifica, l’ampliamento del novero dei soggetti sottoposti allo screening, l’armonizzazione circa regole e procedure del meccanismo di cooperazione tra Stati e Unione, vanno nella direzione di accentrare e rafforzare il controllo degli investimenti esteri nelle mani dell’UE
L’iniziativa in commento appare attualmente ancora in una fase iniziale per poter prevedere i risultati a cui porterà il processo sopra delineato. Certamente, il controllo degli investimenti in uscita è una questione complessa. Come accennato in precedenza, l’ambito del monitoraggio appare ampio e un primo punto interrogativo riguarda se gli Stati membri saranno in grado di raccogliere dati significativi senza la collaborazione delle aziende coinvolte e degli Stati di destinazione. Se i dati potranno essere recuperati, resta da vedere se essi saranno sufficientemente specifici e affidabili da poter effettuare un controllo effettivo del rischio che tali investimenti comportano. Ulteriori spunti di riflessione che questa iniziativa potrebbe alimentare, anche se è ancora presto per esprimere commenti di dettaglio, potrebbero riportarci ad una delle considerazioni svolte all’inizio del presente contributo, ovvero in materia di autonomia strategica. Nel contesto della strategia Open Strategic Autonomy, trovare il giusto equilibrio tra apertura del mercato e protezione e mitigazione del rischio da interferenze esterne è molto complesso. È stato osservato che, per quanto riguarda la politica commerciale dell’UE, alcune recenti iniziative sembrano tendere verso soluzioni unilaterali che sarebbero meno efficaci di soluzioni multilaterali. Per la loro stessa natura, le misure volte ad affrontare i rischi per la sicurezza pubblica generalmente non si adattano agli approcci multilaterali, poiché vanno al nocciolo dell’esercizio dei poteri sovrani (il controllo degli investimenti esteri diretti, ad esempio, è ancora di competenza degli Stati membri pur rientrando i primi nella competenza esclusiva dell’UE ai sensi dell’art. 207 TFUE).
L’adozione di misure giuridiche in materia di controllo sugli investimenti esteri diretti creano ancora tensioni tra gli Stati membri e l’UE e tendono a innalzare barriere agli affari e al commercio internazionale. Gli oneri normativi e burocratici per le imprese dell’UE che cercano di operare a livello internazionale, soprattutto in settori altamente tecnologici, devono fare i conti con l’assenza di una normativa certa e uniforme in materia di investimenti nell’ambito dell’UE. Questa mancanza potrebbe rappresentare un’ulteriore sfida che le autorità di regolamentazione saranno chiamate a tenere presente nel percorso verso un possibile meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretta, soprattutto verso Stati terzi.
*Ricercatore TDA in Diritto dell’Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Pisa.
[1] European Commission, LIBRO BIANCO sugli investimenti in uscita, COM(2024) 24 def.
[2] Per una prima analisi, v. D. Gallo, La recente proposta della Commissione sul controllo degli investimenti esteri diretti, il principio di sussidiarietà e il Parlamento italiano, in Eurojus, 2024, n. 2, pp. 148-155.
[3] Commission proposes new initiatives to strengthen economic security, v. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_363.
[4] Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, in GUUE L 79, del 21 marzo 2019, p. 1 In argomento, v. G. Napolitano, Il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti: alla ricerca di una sovranità europea nell’arena economica globale, in Rivista della Regolazione dei Mercati, 2019, n. 1, p. 2 ss.; A. Alì, L’intersezione tra la sicurezza dell’UE e dei suoi Stati membri alla luce del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti, in La Comunità Internazionale, 2020, n. 3, p. 439 ss; D. Gallo, Sovranità (europea?) e controllo degli investimenti esteri, in I Post di AISDUE, IV (2022), pp. 194-212; P. Acconci, Investimenti stranieri sostenibili diritto e governance internazionale e dell’Unione Europea, Napoli, 2023, p. 90; S. Robert, Foreign Investment Control Procedures as a Tool to Enforce EU Strategic Autonomy, in European Papers, 2023, p. 513 ss., reperibile online; T. Verellen, A. Hofer, The Unilateral Turn in EU Trade and Investment Policy, in European Foreign Affairs Review, 2023, p. 1 ss., reperibile online.
[5] An EU approach to enhance economic security, su https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3358.
[6] Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, in GUUE L 330, del 23 dicembre 2022, p. 1.
[7] La pandemia di Covid e l’invasione russa dell’Ucraina hanno dimostrato che l’UE è eccessivamente dipendente dai paesi terzi per la fornitura di determinati beni, materie prime e servizi essenziali, e che qualsiasi futura interruzione delle catene di approvvigionamento potrebbe portare a gravi carenze e mettere a repentaglio la crescita economica e il benessere della cittadinanza dell’UE. L’autonomia strategica aperta emerge come risposta a questa minaccia senza cadere nel protezionismo o rinunciare ai valori europei di competitività, sostenibilità e coesione.
[8] V. https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/informal-ministerial-meeting-ecofin-santiago-16-september/.
[9] È importante evidenziare che, dal regolamento del 2019, sono originate, in Italia, molteplici novità legislative, in merito ai c.d. golden powers, alcune non problematiche perché seguono quanto previsto nel regolamento, altre novità sono più problematiche in quanto si tratta di modifiche scollegate dal testo del regolamento. Tra le non problematiche: l’estensione dei settori nei quali i golden powers possono essere attivati, per esempio, non più soltanto energia ma anche il settore bancario. Tra le problematiche: è prevista nella disciplina italiana la possibile attivazione dei golden powers nei confronti anche di investitori UE, non soltanto nei confronti degli investitori extra-UE, che sono invece i soli destinatari del regolamento del 2019. V. D. Gallo, La recente proposta della Commissione sul controllo degli investimenti esteri diretti, il principio di sussidiarietà e il Parlamento italiano, cit., p. 150 ss.
[10] Come evidenziato in dottrina, in quel periodo, infatti, si sottolineava come gli Stati membri dell’Unione dovessero esprimere una politica industriale comune per giustapporsi alle spinte americane (rectius delle multinazionali americane) e cinesi. Nello stesso momento nasceva una riflessione molto qualificata sugli strumenti per promuovere la competitività finanche in deroga – o usando come strumento di politica industriale – il diritto della concorrenza dell’UE. E come, di converso, fosse necessario costruire una ulteriore difesa (oltre ai regolamenti UE 1036 e 1037 del 2016 in materia di sovvenzioni e di dumping) nei rapporti con il far East (che infatti ha generato prima della pandemia da Covid-19) il regolamento 2019/452. Sul punto, v. M. Maresca, La Nuova Europa. Sovrana, unita, competitiva, Genova, 2020. Anche l’Italia ha introdotto una normativa (cosiddetta golden power dopo le golden share) sempre più stringente nei confronti degli investimenti esteri, fino a prevedere per alcuni settori anche un controllo per acquisizioni da parte di investitori dell’Unione. Sul golden power, v. T. Ajello, Le golden share nell’ordinamento comunitario: certezza del diritto, tutela dell’affidamento degli investitori e “pregiudiziale” nei confronti di soggetti pubblici, in Il diritto dell’Unione europea, 2007, p. 811, spec. p. 832; S. De Vido, La recente giurisprudenza comunitaria in materia di golden share: violazione delle norme sulla libera circolazione dei capitali o sul diritto di stabilimento? in Diritto del commercio internazionale, 2007, n. 4, pp. 861-893; S.M. Carbone, Golden Share e fondi sovrani: lo Stato nelle imprese tra libertà comunitarie e diritto statale, in Il diritto dell’Unione europea, 2009, n. 3, pp. 503-546, spec. p. 547 ss; D. Gallo, Le golden shares e la trasformazione del public/private divide: criticità, sviluppi e prospettive del diritto dell’Unione europea tra mercato interno e investimenti extra-UE, in S.M. Carbone (a cura di), L’Unione europea a vent’anni da Maastricht – verso nuove regole, Napoli, 2012, p. 177 ss; F. Bassan, Dalla golden share al golden Power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello Stato nell’economia, in Studi sull’integrazione europea, 2014, n.1, pp. 57-80, spec. pp. 58-60. Nell’ambito specifico del controllo degli investimenti stranieri con regole di ordine pubblico economico, v. M. Maresca, Norme di ordine pubblico e governo dei mercati. Interesse nazionale e autonomia privata nell’epoca di una comunità internazionale debole, Milano, 2023, p. 52.
[11] Comunicazione della Commissione Orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e la libera circolazione dei capitali provenienti da paesi terzi, nonché la protezione delle attività strategiche europee, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/452 (regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti) 2020/C 99 I/01, in GUUE CI 99, del 26 marzo 2020, p. 1.
[12] V. Considerando 10 del Reg. UE 2019/452, cit.
[13] Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti giuridici attinenti agli investimenti intracomunitari, del 19 luglio 1997, sez. 4, par. 9.
[14] Corte di giustizia, sentenza del 14 marzo 2000, causa Eglise de Scientologie, causa C-54/99, punto 17.
[15] Corte di giustizia, sentenza del 13 luglio 2023, Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. c. Innovációs és Technológiai Miniszter, causa C-106/22.
[16] Regolamento 2019/452, cit.
[17] Conclusioni dell’Avvocato generale Ćapeta, presentate il 30 marzo 2023, nella causa C-106/22, Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. c. Innovációs és Technológiai Miniszter, punto 26.
[18] Corte di giustizia, Xella, cit., punto 39 ss.
[19] Corte di giustizia, Xella, cit., punto 41 ss.
[20] V. C. Pettinato, The New EU Regulation on Foreign Direct Investment Screening: Rationale and Main Elements, in G. Napolitano (a cura di), Foreign Direct Investment screening. Il controllo sugli investimenti esteri diretti, Bologna, 2019, p. 57 ss; S. Hindelang, A. Moberg, The Art Of Casting Political Dissent In Law: The EU’s Framework For The Screening Of Foreign Direct Investment, in Common Market Law Review, 2020, p. 1427 ss.; M. Nettesheim, Screening for What Threat: Preserving “Public Order and Security”, Securing Reciprocity in International Trade, or Supporting Certain Social, Environmental, or Industrial Policies? in S. Hindelang, A. Moberg (a cura di), Yearbook of Socio-Economic Constitutions: a Common European Law on Investment Screening (CELIS), 2020, pp. 481- 506; D. Gallo, Sovranità (europea?) e controllo degli investimenti esteri, in I Post di AISDUE, 2022, p. 194 ss.; D. Gallo, Ordine giuridico del mercato 2.0 e Unione europea, in Eurojus, 2023, p. 136 ss., reperibile online; M. Misra, Thinking Past Naivete: Investment Screening by the EU as a Problem of (Mis)trust in International Relations, in European Foreign Affairs Review, 2023, p. 117 ss., reperibile online; S. Poli, D. Gallo, Enhancing European Technological Sovereignty: The Foreign Investment Screening Regulation and Beyond, in K. Armstrong, J. Scott, A. Thies, (a cura di), Liber Marise Cremona, Oxford, 2023, in corso di pubblicazione, pp. 215- 250; E. Tinti, Il regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti al vaglio della Corte: giudici liberisti, Avvocato generale protezionista? In BlogDUE, 29 ottobre 2023, p. 2.
[21] Sul pacchetto di iniziative della Commissione europea, v. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en /ip_24_363.
[22] European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the screening of foreign investments in the Union and repealing Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council, January 24 2024, disponibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52024 PC0023&qid=1707215623156.
[23] Art. 4, par. 4, della Proposta.
[24] Definito ai sensi dell’art. 2, par. 53, del Regolamento UE 2018/1046.
[25] L’Allegato include attività e asset in settori come quello dual use, tecnologie critiche (tra gli altri, semiconduttori, IA, quantistiche, biotecnologie, cybersecurity, sensoristica, robotica), tecnologie spaziali, energia, salute e sistema finanziario. Ai sensi dell’art. 19 della Proposta, la Commissione può aggiornare tali aree tramite atti delegati (i.e. senza ricorrere a un atto legislativo).
[26]Sul punto, v., https://www.defensenews.com/industry/2023/11/21/italy-blocks-safrans-purchase-of-firm-involved-in-making-eurofighters/.
[28] Su questa proposta, v. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5832-2024-INIT/it/pdf.
[29] D. Gallo, La recente proposta della Commissione sul controllo degli investimenti esteri diretti, cit., p. 148.
[30] V. European Court of Auditors, Special report 27/2023: screening foreign direct investments in the EU – First steps taken, but significant limitations remain in addressing security and public-order risks effectively, 6 december 2023, reperibile online. V. D. Gallo, La recente proposta della Commissione sul controllo degli investimenti esteri diretti, cit., p. 153.
[31] Il controllo degli investimenti in uscita non è una prassi ben consolidata a livello mondiale. Come sottolinea il Libro bianco, solo il Giappone e la Cina hanno promulgato leggi che prevedono questo tipo di monitoraggio, e gli Stati Uniti stanno sviluppando un quadro normativo per farlo. È interessante notare che il Giappone monitora un insieme ristretto di settori che includono, oltre alle armi e ai narcotici, anche la pesca e il pellame. Il quadro condiviso della Cina sembra includere una vasta gamma di settori, tanto che le forme di controllo degli investimenti in uscita adottato dallo Stato mirerebbe a proteggere l’interesse nazionale in modo più ampio piuttosto che solo la sicurezza pubblica. Al contrario, gli Stati Uniti sembrano essere abbastanza allineati con l’UE, poiché la loro iniziativa mirerebbe a tecnologie che potrebbero essere sfruttate per scopi militari, di intelligence e di sorveglianza. V. https://home.treasury.gov/system/files/206/Executive%20Order%2014105%20August%209%2C%202023.pdf.
[32] COM(2024) 23, cit.

