Pubbl. Mar, 18 Nov 2025
Il diritto d’autore e l’intelligenza artificiale: un matrimonio difficile, almeno in apparenza
Modifica pagina
Sebastiano Cascio
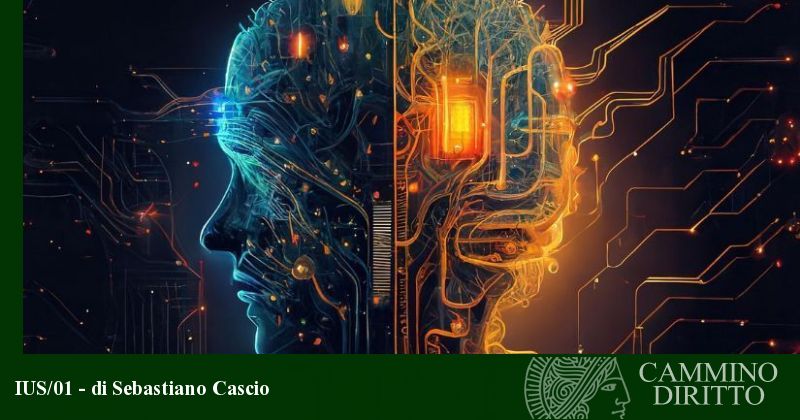
La Legge 23 settembre 2025, n. 132 (“Legge sull’Intelligenza Artificiale”) rappresenta il primo intervento organico dell’ordinamento italiano volto a regolare l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. La novità più rilevante concerne la disciplina del diritto d’autore, con modifica della Legge 22 aprile 1941, n. 633, introducendo il requisito espresso dell’“ingegno umano” e disciplinando l’estrazione di testi e dati mediante IA. L’articolo analizza criticamente tali innovazioni, discutendo le implicazioni in termini di paternità autoriale, originalità e tutela delle opere co-generate da esseri umani e algoritmi. Si propone infine una riflessione sulle prospettive interpretative e applicative del nuovo quadro normativo.
Sommario: 1. Premessa; 2. Il quadro normativo antecedente alla Legge n. 132/2025; 3. Le novità introdotte dalla Legge sull’IA in materia di diritto d’autore; 4. Il requisito dell’ingegno umano e le opere co-generate; 5. Conclusioni.
1. Premessa
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni, la sua libera fruibilità da parte degli utenti tutti, e in particolare lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale generativa, rendono ed hanno reso urgente un ripensamento delle categorie giuridiche tradizionali del diritto d’autore.
Non volendo avere la pretesa di definire in poche righe lo strumento dell’intelligenza artificiale, e pertanto, volendo spostare l’accento del discorso su quanto infra in tema di diritto d’autore, in via del tutto esemplificativa si evidenzia come, per intelligenza artificiale generativa si intende un sistema che, a mezzo input umani, genera contenuti, artistici o culturali che, prima dell’avvento dell’IA stessa erano generati esclusivamente da intelligenza non artificiale[1] e quindi da intelligenza umana.
Il reale problema dei contenuti, e quindi delle opere, create “con l’ausilio” dell’IA sollevano preoccupanti domande di fondo ovvero, in primis occorre valutare chi sia l’autore di un contenuto generato tramite algoritmi o comunque tramite un sistema informatico, in secondo luogo, occorrerà poi valutare quale livello di intervento umano è necessario affinché sussista la tutela autoriale, e quindi a che un determinato contenuto possa esser qualificato come rientrante nel perimetro protettivo proprio della disciplina del diritto di autore.
Sempre in via del tutto preliminare occorre operare ora un ulteriore distinguo, prodromico alla trattazione successiva.
Preliminarmente occorre specificare che, come è ovvio, e come è stato altresì codificato, vi è spazio per parlare di diritto d’autore se vi è un soggetto, persona, cui una determinata opera o contenuto è almeno parzialmente riconducibile.
Ove un contenuto sia interamente oggetto di generazione a mezzo intelligenza artificiale è evidente come non essendovi un autore da tutelare non vi è alcuno spazio per parlare di diritto di autore se non altro posto che non sorge congiuntamente all’opera, alcun diritto morale di autore.
Posta la peculiarità della disciplina e del relativo ambito operativo, ma soprattutto posta la trasversalità dell’argomento, il parlamento, con la nuova Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata in G.U. n. 230 del 2 ottobre 2025 e in vigore dal 10 ottobre, affronta per la prima volta in modo sistematico la questione della creazione assistita da IA, intervenendo sulla Legge sul diritto d’autore del 1941[2].
2. Il quadro normativo antecedente alla Legge n.132/2025
Prima del 2025 e della relativa novella, la disciplina sul diritto di autore e quindi, la relativa normativa, non conteneva riferimenti all’intelligenza artificiale, l’art. 1 stabiliva solamente che “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia”[3].
Invero, anche se in detta norma non era specificato nulla in tema di intelligenza artificiale non può non notarsi come già nel primo articolo della legge vi sia il riferimento espresso alle opere dell’ingegno.
È di tutta evidenza come, ancorché non fosse esplicitata la circostanza per cui l’ingegno deve essere inteso come ingegno umano, la ratio della norma, emanata in un periodo storico in cui i sistemi informatici non erano avanzati come oggi, è da intendersi nel senso che oggetto della tutela è l’opera proveniente da ingegno umano.
Già solo il lemma ingegno varrebbe a sgomberare il campo da qualunque equivoco a che, un’opera oggetto di intelligenza artificiale, o volendo mutuare il lemma specifico, opera oggetto di ingegno artificiale, non poteva esser oggetto di tutela alcuna da parte della esistente normativa.
La giurisprudenza aveva già in tempi recenti chiarito che la tutela sorge solo in presenza di un apporto creativo umano, escludendo le creazioni meramente meccaniche o automatiche.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di novità assoluta, ma con la personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate”[4].
Già solo dalla lettura del dispositivo della sentenza emerge come il postulato essenziale sia proprio l’apporto umano, ovvero l’opera, più o meno creativa, connotata da novità assoluta o parziale, in ogni caso è opera se è riconducibile all’essere umano.
È evidente come ciò fosse ovvio in un momento storico in cui, gli strumenti di intelligenza artificiale non erano, tra il pubblico diffusi.
Occorre valutare dunque se il principio regge anche oggi, e se sì in che misura, proprio alla luce del fatto che i sistemi generativi di intelligenza artificiale sono non ignorabili nella misura in cui liberamente fruibili gli stessi sono, da chiunque possieda un cellulare od un computer.
Negli ultimi decenni, l’ambito oggettivo del diritto d’autore si è ampliato a nuove forme di espressione, dal software[5] alle banche dati[6], e più recentemente ai prodotti multimediali. Tuttavia, il requisito della personalità dell’autore è sempre rimasto imprescindibile. La creatività è da interpretare come la capacità dell’autore di imprimere un’impronta personale all’opera”[7].
Emerge dunque un quadro sempre più specifico, ed emerge come, in ogni pronunzia giurisprudenziale, in ogni norma o altro, imprescindibile sia l’apporto umano alla creazione dell’opera, anche ove stesse parlandosi di banche dati.
La banca dati è ad esempio un raccoglitore di dati multimediali, tuttavia, nell’organizzazione di detti dati così come nell’indicizzazione degli stessi o negli strumenti per la di loro gestione ed il loro aggiornamento, se v’è apporto umano è innegabile vi sia opera di ingegno.
In via del tutto apocrifa può affermarsi che v’è spazio per diritto d’autore e v’è nascita dello stesso in capo all’autore se costui, impiega il proprio tempo ingegno ed energie mentali per la creazione proprio dell’opera, ancorché coadiuvato da strumenti informatici (come accade nella creazione di un software ad esempio).
Viceversa, ove la creazione dell’opera sia interamente riconducibile ad un sistema di intelligenza artificiale non v’è spazio per una tutela del diritto, posto che, ad oggi, i diritti sono delle persone non dei sistemi informatici.
3. Le novità introdotte dalla Legge sull’IA in materia di diritto d’autore
La Legge n. 132/2025 si ispira al Regolamento (UE) 2024/1689 (“AI Act”), ma introduce anche modifiche autonome alla normativa italiana, la novella riformula essenzialmente a finalità esplicativa ciò che tuttavia era già agevolmente desumibile dalla lettura della norma.
Un esempio dogmatico chiarirà meglio il concetto, e pertanto, analizzando la novella, la prima innovazione rispetto alla disciplina previgente è rappresentata dalla modifica dell’art. 1 sul diritto d’autore.
La Legge, con l’art.25, interviene direttamente sull’art. 1 sostituendo la dizione originaria con: “Sono protette ai sensi della presente legge le opere dell’ingegno umano di carattere creativo, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore.”[8]
La disposizione riafferma il carattere antropocentrico del diritto d’autore, o forse è più corretto dire del cervello umano, ribadendo che la protezione resta riservata a opere che manifestino un apporto intellettuale umano riconoscibile.
Orbene, la parola riafferma è stata inserita non a caso nella trattazione.
Vero è che la previgente normativa non offriva uno specifico riferimento all’apporto umano, ma vero è che, nessuno aveva dubbi che l’apporto umano fosse fondamentale al riconoscimento di tutele ordinamentali.
La legge sul diritto d’autore tutela l’autore, e l’autore è, per definizione, una persona, difatti, in diritto, l’autore di un determinato fatto giuridico, è una persona, non un sistema informatico, ancora, la norma specifica che, anche ove l’opera sia creata con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, è tutelata se comunque frutto di lavoro intellettuale dell’autore.
I sistemi dunque sono strumenti per il compimento di attività ma, non essendo soggetti di diritto, non sono qualificabili come autori in via del tutto evidente.
Come sopra evidenziato il concetto, forse ridondante, era già chiaro prima della novella, nella misura in cui, i software si ottengono a mezzo strumenti informatici, ma, dubbio non vi è che questi stessi strumenti informatici ancorché agevolanti il lavoro umano non possono essere sostitutivi dello stesso.
L’esigenza di appesantire la normativa preesistente è evidente miri a prevenire controversie ed anzi a meglio esplicare il perimetro della normativa, tuttavia, la funzione della legge non dovrebbe essere esplicativa della legge stessa.
Ulteriore problematica, e forse la principale della novella, non è chiarito dalla stessa cosa si intenda per apporto umano riconoscibile ed anzi, forse è proprio questo il reale problema della nuova formulazione della normativa.
Prima della novella, l’opera, come sopra evidenziato, se riconducibile all’autore era tutelata, viceversa se non riconducibile all’autore non era tutelata.
In linea di semplificazione estrema, per essere riconducibile ad un autore un’opera presuppone un apporto umano, se non vi era, a previgente disciplina, apporto umano, non vi era opera.
Ad oggi, esattamente, occorre comprendere cosa si intenda dunque per apporto umano riconoscibile e soprattutto, cosa completi l’opera a fronte di un apporto umano riconoscibile e con questo mi spiego.
A fronte di un dato risultato, ovvero l’opera, sottratto l’apporto umano riconoscibile, cosa resterebbe? Verosimilmente un apporto di intelligenza artificiale marginale? Non può parlarsi di marginalità nella misura in cui la norma fa riferimento alla riconoscibilità.
Pertanto già più corretto forse sarebbe stato specificare che l’apporto umano non deve essere riconoscibile quanto piuttosto fondamentale per l’opera stessa. La differenza è di non poco conto, una cosa è un apporto riconoscibile altro è un apporto fondamentale, tuttavia l’esigenza qui manifestata non pare esser stata recepita dal legislatore e pertanto è classificabile come mera speculazione giuridica.
La stessa legge inserisce il nuovo articolo 70-septies, che disciplina l’estrazione di testi e dati mediante IA. Tale articolo stabilisce che l’utilizzo di opere protette per l’addestramento di sistemi di IA è consentito solo nel rispetto delle eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore e “ferma restando la menzione della fonte e dell’autore”[9].
Questa disposizione si pone in linea con la Direttiva UE 2019/790 (c.d. Direttiva Copyright), ma adatta il principio al contesto dei modelli generativi.
Orbene, se a mezzo un sistema di intelligenza artificiale si estraggono dati e altro, probabilmente già prima di questo appesantimento normativo era ovvio che la fonte dovesse esser citata e che le opere intellettuali altrui devono esser fruite nel rispetto della normativa sul diritto di autore.
Ancora una volta, non si comprende affatto, circa detta novella, quale sia effettivamente la portata innovativa della norma, posto che, se l’opera d’ingegno è tale anche se come sopra detto non innova nulla invece connotato tipico della norma giuridica è tendenzialmente innovare l’ordinamento esistente.
4. Il requisito dell’ingegno umano e le opere co-generate
L’inserimento del termine “umano” nell’art. 1 come sopra indicato è una novità forse più simbolicamente che giuridicamente significativa, è forse una provocazione normativa.
Essa, a rigore, esclude esplicitamente dalla tutela le opere generate in modo completamente autonomo da sistemi di IA e apre al contempo alla protezione di opere co-generate, cioè realizzate tramite collaborazione uomo-macchina come evidenziato dalla dottrina che del tema ha discusso[10], tuttavia il problema è sempre il medesimo, ovvero, banalmente, comprendere quale sia la percentuale di collaborazione di un sistema di IA che permetta comunque di ricondurre l’opera alla persona rectius all’autore e quindi di qualificare un’opera come tale.
Essendo incerto quale sia la soglia minima di creatività umana richiesta e la legge per ovvi motivi non fornendo sul punto alcun criterio quantitativo, il dibattito resta aperto, e pertanto suscettibile di interpretazioni anche divergenti tra loro, ad opera non solo degli autori ma anche degli organi giudicanti.
La dottrina suggerisce che l’intervento debba consistere in una scelta libera e consapevole che incida sull’espressione finale dell’opera[11], suggerendo dunque un apporto, in percentuale, prevalentemente umano.
Un semplice “prompt” generico (“crea un paesaggio inglobante un tramonto”) potrebbe non essere sufficiente per la qualificazione in termini di opera, mentre la selezione, modifica o post-produzione dell’output dell’IA potrebbe integrare un apporto creativo, si comprende come queste siano ipotesi, muovendosi l’interprete, così come anche lo scrivente, nel campo dell’opinabile.
Dal punto di vista operativo, artisti e imprese forse dovrebbero, per i contenuti generati in parte o co-creati con IA specificare detta circostanza anche nell’ottica della massima trasparenza possibile, rivolgendosi, soprattutto le imprese, a consumatori, tuttavia nessuna norma esiste sul punto, norma che invece sarebbe stata invero assai utile posto che assente nel panorama normativo attuale per le opere coperte da diritto d’autore.
Il concetto di autore non viene ridefinito dalla Legge n. 132/2025, ma la sua applicazione ai casi di co-creazione solleva problemi.
Secondo l’impostazione tradizionale, l’autore è “colui che ha creato l’opera mediante il proprio ingegno”. Ne consegue che, in caso di creazione assistita, solo la persona fisica che ha contribuito con attività creativa rilevante può essere considerata autore, e più in generale la persona fisica, posto che, come detto sopra, i diritti sono delle persone non già degli strumenti informatici.
Come già concluso qualche riga fa, di fatto sarà la giurisprudenza futura a dover chiarire se, e in quale misura, l’intervento umano di direzione, scelta o combinazione di input e output possa qualificare il prodotto dell’ingegno come opera intellettuale e soprattutto la sussistenza dei requisiti per il conferimento o forse proprio lo spazio a che possa parlarsi di autore e opera intellettuale.
5. Conclusioni
La nuova disciplina tenta di preservare un delicatissimo equilibrio, da un lato cercando di tutelare la creatività umana dall’altro non ostacolare lo sviluppo tecnologico. Tuttavia, il bilanciamento non è affatto agevole, soprattutto in assenza di chiari indici normativi di riferimento.
Ulteriore problema è rappresentato dal fatto che il diritto d’autore è trasversale tra i diversi stati del mondo, si pensi, ad esempio, alle opere musicali più diffuse nel panorama internazionale, oggetto di tutela mondiale e di diffusione mondiale, emerge come la disciplina debba esser quanto più armonizzata tra i vari Stati.
Il rischio è quello di disarmonia con altri ordinamenti. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’U.S. Copyright Office ha negato la registrazione a opere create da IA senza intervento umano (“Zarya of the Dawn”, 2023)[12]. L’Italia, in teoria, alla luce della novella normativa è allineata a tale orientamento, ma la mancanza di criteri uniformi in Europa potrebbe generare incertezza giuridica, così come in altri paesi del mondo.
La Legge n. 132/2025 innegabilmente segna un passo iniziale verso l’aggiornamento del diritto d’autore alla luce dell’intelligenza artificiale.
Essa riafferma il principio dell’antropocentrismo giuridico, sancendo che solo l’apporto creativo umano è suscettibile di tutela, pur riconoscendo ed anzi codificando la crescente rilevanza delle tecnologie generative, quasi postulandone la necessaria utilizzazione in caso di creazione di opere di ingegno.
Rimangono tuttavia aperte tre sfide principali, che come si è detto difficilmente potrebbero trovare soluzione a mezzo legge, ovvero, da un lato la definizione del livello minimo di creatività umana richiesto per la tutela, il chiarimento della paternità nelle opere co-generate; e soprattutto il bilanciamento tra innovazione tecnologica e protezione dell’ingegno umano.
In prospettiva, sarà pertanto necessariamente la giurisprudenza a concretizzare i criteri di applicazione della nuova norma, delineando la frontiera tra creazione umana e artificiale. Nel frattempo vi è la necessità di linee guida interpretative emanate dallo Stato a mezzo dei suoi organi centrali, al fine di garantire certezza giuridica e trasparenza nei processi creativi basati su IA.
In definitiva, il nuovo quadro legislativo non solo protegge l’autore umano, ma impone una riflessione più ampia sul valore della creatività nell’era dell’intelligenza artificiale: una creatività che, pur assistita da algoritmi, resta insostituibilmente umana, almeno in parte e almeno per la legge.
Il matrimonio, se ritenuto necessario tra opera e IA resta difficile, nei patti e negli accordi, la coesistenza invece, quasi postulata dalla legge, del pari è non priva di criticità.
[1] Sul concetto di intelligenza artificiale, si segnala che il Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (Artificial Intelligence Act), art. 3, n. 1, definisce un sistema di IA come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che, per obiettivi esplicitamente o implicitamente assegnati, inferisce, dalle informazioni di input che riceve, come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni».
Per l’analisi odierna è evidente come quello che per noi rileva è la generazione di un contenuto.
[2] L. 22 aprile 1941, n. 633, «Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» con successive modifiche ed integrazioni, quali appunto quelle discendenti dalla novella sopra menzionata.
[3] Art. 1 legge citata.
[4] Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2011, n. 25173: la Corte ha precisato che la tutela delle opere dell’ingegno, ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633, richiede il requisito della creatività, intesa non come novità assoluta, ma come espressione personale e originale dell’autore; è sufficiente un apporto creativo minimo manifestato esteriormente, mentre le idee in sé non sono tutelate.
[5] Art. 2, n. 8, Legge citata, introdotto dal D.lgs. 518/1992, in attuazione della Direttiva 91/250/CEE.
[6] Art. 2, n. 9, Legge citata, introdotto dal D.lgs. 169/1999, in attuazione della Direttiva 96/9/CE.
[7] In tal senso vedasi sentenza della Corte di Cassazione n. 10300 del 29 maggio 2020.
[8] Art. 25, comma 1, lett. a), L. 23 settembre 2025, n. 132, in G.U. n. 230/2025.
[9] Art. 70-septies, Legge diritto d’autore, introdotto dalla L. n. 132/2025
[10] P. Centofanti, Diritto d’autore e intelligenza artificiale: un nuovo orizzonte normativo, in Federagione, 18 ottobre 2025.
[11] A. Lino, Il DDL IA è legge: luci e ombre di un’occasione parzialmente mancata, in MementoPiù, 1 ottobre 2025.
[12] Thaler v. Perlmutter, U.S. District Court for the District of Columbia, Civil Action No. 22-1564 (2023).

