Pubbl. Mer, 29 Ott 2025
Patti prematrimoniali alla luce della nuova giurisprudenza italiana
Modifica pagina
Sebastiano Cascio
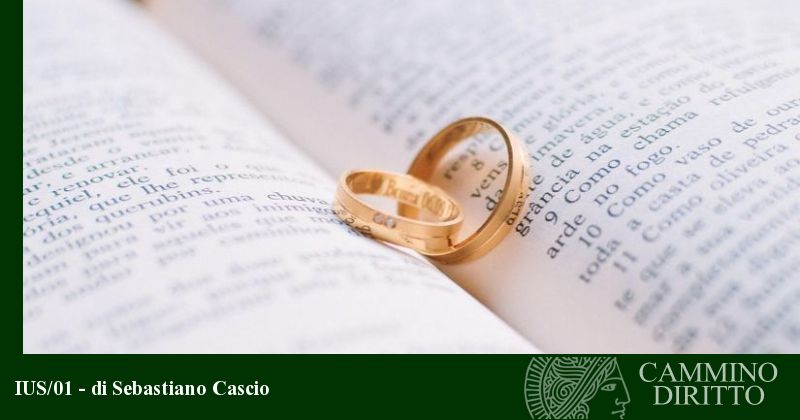
Negli ordinamenti di common law i prenuptial agreements sono da lungo tempo riconosciuti come strumenti di autodeterminazione patrimoniale dei futuri coniugi; in Italia, al contrario, la dottrina e la giurisprudenza tradizionali hanno generalmente escluso la validità dei patti stipulati prima del matrimonio volti a disciplinare anticipatamente effetti patrimoniali in caso di separazione o divorzio, ritenendoli contrari all’art. 160 c.c. per violazione dell’ordine pubblico familiare. Tuttavia, con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 emerge una svolta: la Corte riconosce che accordi patrimoniali stipulati anche prima della crisi coniugale, purché rispondenti a determinati requisiti, possono essere efficaci. Il presente articolo analizza il profilo normativo, le
Sommario: 1.Inquadramento normativo e principi tradizionali; 1.1 Il dettato del Codice civile; 1.2 Giurisprudenza tradizionale: la tesi negazionista; 2. Evoluzioni e apertura giurisprudenziale; 2.2 L’Ordinanza n. 20415/2025: il punto di svolta; 3. Limiti e profili critici e pericolosità di detti accordi; 4. Prospettive di riforma; 5. Conclusioni.
1. Inquadramento normativo e principi tradizionali
1.1 Il dettato del Codice civile
Preliminarmente occorre partire dall’analisi degli articoli del Codice civile per poter comprendere quali siano i poteri riconosciuti ai nubendi.
Nel caso specifico, due sono i principali articoli di riferimento, ovvero: l’articolo 1322 c.c. il quale riconosce la libertà contrattuale dei consociati, purché la stessa sia esercitata nel rispetto delle norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume; l’articolo 160 c.c. dispone che «gli sposi non possono derogare [mediante patti] né ai diritti né ai doveri stabiliti dalla legge per effetto del matrimonio».
Già solo dalla lettura del sopra citato articolo 160 c.c. si comprende come tale norma sia stata interpretata come ostativa alla validità dei patti che modifichino preventivamente gli obblighi matrimoniali o che attribuiscano effetti patrimoniali che scaturiscono in caso di separazione/divorzio.
Unica eccezione, testualmente ammessa dal codice civile inerisce la possibilità, per i coniugi di stipulare le convenzioni matrimoniali anche prima delle nozze (articolo 162 c.c. comma 3).
Dalla lettura di dette norme emerge chiaramente la possibilità a che i coniugi possano, prima delle nozze, stipulare le convenzioni matrimoniali, tra cui, si segnala, il fondo patrimoniale cui all’art 167 c.c.
Tautologico è che, le dette convenzioni saranno efficaci solo una volta che il matrimonio sarà celebrato (non già contratto, non essendo il matrimonio un contratto), essendo dunque le stesse tutte condizionate da legge sospensivamente all’evento nozze (essendo del tutto evidente come trovino la loro causa proprio nelle nozze).
1.2 Giurisprudenza tradizionale: la tesi negazionista
Prima del 2025, la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza[1] riteneva che i patti prematrimoniali – in quanto prevedono anticipatamente gli effetti patrimoniali della fine del vincolo matrimoniale – fossero nulli per illiceità della causa in ragione dell’indisponibilità dei diritti e doveri del matrimonio, del carattere personale e non patrimoniale dello status matrimoniale e del vincolo coniugale come istituto pubblico.[2]
Tali pronunce argomentavano che un accordo preventivo potrebbe pregiudicare il ruolo del giudice nella valutazione degli interessi dei coniugi e soprattutto dei minori, nonché violare la solidarietà familiare[3].
Invero, proprio dalla lettura della normativa cui sopra emerge espressamente come ad essere ammesse, prima delle nozze, siano le convenzioni matrimoniali in vista del matrimonio, ovvero negozi giuridici familiari peculiari che, nel disciplinare il rapporto patrimoniale tra coniugi sono a favore del matrimonio, non già di una sua fase patologica.
L’ordinamento giuridico attuale è strutturato con favore verso il matrimonio e la disciplina della fase patologica dello stesso è rimessa ad una fase eventuale e successiva, non già prodromica allo stesso.
Per la giurisprudenza recente, è valido non già il patto prematrimoniale ma il patto con cui si disciplini un singolo aspetto della più ampia fase della crisi coniugale[4]
2. Evoluzioni e apertura giurisprudenziale
Alcune decisioni precedenti avevano però ammesso accordi stipulati in costanza di matrimonio con efficacia condizionata alla futura separazione, specie per riconoscimenti di contributi economici, rimborso di spese o valorizzazione di apporti personali.
Tali accordi venivano qualificati come negozi atipici, soggetti al controllo del giudice al momento dell’effettiva crisi, e sottoposti ai limiti dell’ordine pubblico familiare.[5]
Del pari pertanto detti negozi sarebbero sottoposti alla condizione sospensiva della futura crisi coniugale.
Sul punto si segnala come codicisticamente la crisi coniugale è divisa in due momenti in caso di matrimonio, ovvero, separazione e poi divorzio.
Sinteticamente, tuttavia, la possibilità a che possa essere stipulata una convenzione matrimoniale anche prima delle nozze non è sovrapponibile alla circostanza della pretesa legittimità dei patti prematrimoniali per il caso di divorzio.
La convenzione matrimoniale ha natura programmatica, non incide sulla crisi delle nozze e non presuppone per la sua efficacia di certo la crisi del matrimonio, anzi, presuppone proprio la corretta celebrazione dello stesso.
La natura programmatica della convenzione la rende astratta rispetto ad un patto concreto per la crisi coniugale, e per questo, proprio perché in vista delle nozze e non già del divorzio è da ritenere aderente la stessa al sistema.
Dottrina recentissima, dopotutto[6] evidenzia come proprio la crisi coniugale non sia passibile di contrattazione ad opera delle parti, essendo pertanto materia indisponibile per i coniugi stessi.
L’alea della separazione e delle conseguenze economiche che ne derivano, non può e non deve essere oggetto di giudizi e contratti prodromici alla crisi stessa, posto che, il matrimonio, per il nostro ordinamento, non ha natura contrattuale e pertanto lo stesso mal si concilia a pattuizioni previsionali in tal senso, pattuizioni astratte.
Di diverso avviso è altra dottrina[7] che offre una visione meno restrittiva, tale posizione dottrinale, partendo dall’assunto per cui di base debba esservi il rispetto dei principi di equità e solidarietà, è aperta a dette pattuizioni, purché le stesse non siano in violazione dei principi sopra esposti.
Dalla lettura di dette teorie emerge come invero entrambe abbiano una visione giusta della vicenda, a parere dello scrivente.
Da un lato innegabile è che l’autonomia privata, enunciata all’art 1321 c.c. sia un principio fondamentale su cui si basa il nostro ordinamento giuridico, ed invero tale principio è più volte declinato nel nostro ordinamento sempre in favore della libera scelta delle parti sul se contrarre e su con chi contrarre e su cosa contrarre.
Se questo è innegabile, tuttavia vero è anche che, un giudizio di equità e quindi di proporzionalità non può essere effettuato da soggetti in conflitto di interessi, e con questo mi spiego.
Nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, quale potrebbe essere un contratto prematrimoniale per il caso di divorzio, per definizioni le posizioni delle parti tra loro confliggono (in astratto) sul contenuto del contratto stesso.
Naturalmente, lemma cui dare una interpretazione letterale, ognuno dei coniugi tenderà a satisfare interessi personali in gioco, o peggio, a tutelare la propria posizione in caso di futura separazione.
Come può pensare di parlare di equità e solidarietà se a decidere dei propri cespiti, e su come impiegarli in caso di divorzio, siano i soggetti cui detti cespiti saranno oggetto di contesa?
Arduo ritenere che possa esservi un giudizio equo da parte di soggetti i cui interessi, per definizione, sono in conflitto.
L’equità difatti nel nostro ordinamento è tipica del giudice, il quale è terzo ed imparziale rispetto alle parti.
In aggiunta, come può ritenersi che la situazione patrimoniale dei coniugi al momento della stipula del patto sia la medesima al momento della crisi coniugale? Si badi, si specifica situazione patrimoniale e non situazione morale.
Ben potrebbe aversi che, nello iato tra patto prematrimoniale e crisi coniugale, la situazione di partenza dei coniugi si rovesci completamente, per uno o per entrambi.
In tale ultima ipotesi, come può sostenersi che un patto sia ancora equo? Verosimilmente sarà iniquo, di qui la necessità a che ogni patto in caso di crisi coniugale, salvo su singoli aspetti di una più ampia vita coniugale, sia vagliato ed omologato da un soggetto terzo (giudice) a che decida con equità e nel rispetto anche del principio di solidarietà.
2.2 L’Ordinanza n. 20415/2025: il punto di svolta
Con l’ordinanza 21 luglio 2025, n. 20415, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità – in linea teorica – di una scrittura privata stipulata tra coniugi prima o comunque in assenza di separazione/divorzio ma con effetti condizionati alla separazione, purché ricorrano una serie di condizioni, non già alternative tra loro ma cumulative, ovvero:
- il patto patrimoniale riguardi oggetti disponibili (cioè rapporti patrimoniali di cui la legge non disponga la indisponibilità);
- non sia lesivo dei doveri inderogabili del matrimonio (assistenziale, materiale, morale, collaborazione, contribuzione economica) stabiliti dal codice civile e dalle leggi speciali;
- non travalichi i limiti posti a tutela dei figli minori e dei loro diritti, in particolare dell’interesse superiore;
- sia chiaro e definito nei termini della prestazione (quantificazione, condizione, modalità).
Nel caso concreto una coppia di Mantova aveva stipulato nel 2022 una scrittura privata nella quale il marito si impegnava, in caso di separazione, a restituire alla moglie una determinata somma, corrispondente ai contributi da lei sostenuti per la casa, arredamento e altri beni; la scrittura privata prevedeva rinunce da parte della moglie su determinati beni (arredi, imbarcazione). La Cassazione ha affermato la validità dell’accordo condizionato alla separazione, distinguendo tra “causa” del patto (non la separazione) e la sua efficacia, che scatta solo al verificarsi dell’evento separazione.[8]
Già dalla lettura della sentenza si comprende come oggetto del patto non sia disporre dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio, quanto piuttosto da un lato operare una ricognizione di debito (corrispondente al contributo del coniuge per l’acquisto di beni ed altri) e impegnarsi a rimborsarlo, dall’altro rinunziare ad una pretesa attributiva.
Pare forse essere in presenza di reciproche concessioni riconducibili ad un contratto di transazione[9] posto che le parti rinunziano entrambe a delle pretese, future, eventuali, per una lite che dovesse eventualmente scaturire in caso di situazione di crisi coniugale.
La causa di questi negozi tuttavia non sarebbe, leggendo la sentenza, la seguente, quanto piuttosto disciplinare i rapporti (taluni) tra i coniugi per il caso di separazione e/o divorzio.
Tali accordi, in ogni caso sarebbero comunque sottoposti al vaglio di un giudice, e, al netto della loro liceità o meno si segnala come il giudice, possa, serenamente non omologarli ove ravvisasse siano gli stessi sproporzionati ovvero più banalmente illeciti.
3. Limiti e profili critici e pericolosità di detti accordi
Prendendo spunto proprio dalla sentenza della Corte occorre valutare quale sia il precipitato di diritto, i limiti e quali spunti operativi possano essere suggeriti all’interprete, partendo sempre dal presupposto che la validità di detti contratti è ammessa solo per il caso in cui l’oggetto patrimoniale del contratto sia disponibile
I diritti dei figli (affidamento, mantenimento, regime delle responsabilità personali) non possono essere oggetto di patti preventivi, in quanto subordinati al giudizio del giudice che tutela l’interesse del minore.[10]
Il patto deve essere sufficientemente specifico e formulato in modo da evitare ambiguità e capziosità, in modo che il giudice possa verificare la trasparenza, il bilanciamento delle prestazioni e l’equità.
Non è chiaro in ogni caso come dovrà essere valutata la “meritevolezza” della causa – ossia la motivazione che legittima il patto – e quali criteri concreti adotterà il giudice per il vaglio di legittimità dell’accordo.
Non è del pari definito se sia possibile rinunciare preventivamente all’assegno di mantenimento (per il coniuge) in modo forfettario, nonostante le implicazioni sulla tutela del coniuge più debole e sul punto pare proprio doversi dare risposta negativa.
Il vero problema è la totale assenza di una normativa di supporto a detti patti, la possibilità concreta a che gli stessi siano ribaltati in sede di separazione e/o divorzio e soprattutto il mutare delle condizioni patrimoniali dei coniugi dal momento della stipula al momento della separazione.
In buona sostanza, vi è totale assenza circa la certezza del diritto, ovvero, la certezza a che un contratto o patto che sia, una volta stipulato, seppur dopo tempo possa produrre determinati effetti giuridici.
Confrontando comparativamente, ad esempio, In Spagna, come evidenziato da Barba (2023), il diritto e la giurisprudenza riconoscono maggiormente l’autonomia negoziale in patti prematrimoniali, come espressione dell’autodeterminazione dei coniugi.[11]
4. Prospettive di riforma
Alla luce della nuova giurisprudenza, emergono alcune proposte che potrebbero essere prese in considerazione dal legislatore:
In primis occorrerebbero delle norme esplicite che regolamentassero i patti prematrimoniali / patrimoniali anticipati in previsione della crisi, con indicazione dei criteri di validità, degli effetti e dei limiti, al fine di ridurre l’incertezza e favorire la certezza del diritto.
Occorrerebbe poi la previsione di forma particolare per tali patti (ad es. atto pubblico o scrittura privata autenticata) per garantire trasparenza e certezza nei contenuti e soprattutto l’intervento del Notaio quale Pubblico Ufficiale super partes, analogamente a quanto previsto in tema di contratti di convivenza[12], figura fondamentale a garanzia della effettiva comprensione del contratto, che svolge ruolo di consiglio alle parti, e che soprattutto è idoneo a poter meglio valutare della meritevolezza degli interessi in gioco, oltre che evidentemente soggetto formato a poter gestire, giuridicamente, contratti.
Il ruolo dell’avvocato, per lo scrivente mal si concilia con detti accordi, nella misura in cui l’avvocato è professionista di parte non super partes come il notaio, inoltre laddove vi siano coinvolti diritti reali su beni immobili è imprescindibile, il ruolo del notaio, sì come già lo è per il caso di negozi in esecuzione degli accordi di divorzio.
5. Conclusioni
La pronuncia della Cassazione n. 20415 del 21 luglio 2025 segna una tappa significativa nella evoluzione del diritto di famiglia italiano, aprendo, seppure con limiti, alla validità di accordi patrimoniali anticipati, purché non travalichino i confini imposti dall’ordinamento per la protezione dei valori fondamentali della famiglia.
Tuttavia, la nuova giurisprudenza non può essere interpretata come un via libera generalizzato ai patti prematrimoniali così come concepiti in altri sistemi: rimangono limiti forti, soprattutto in relazione ai diritti dei figli, all’indisponibilità dei doveri inderogabili del matrimonio e alla necessaria proporzionalità e chiarezza delle pattuizioni.
Una riforma legislativa dedicata potrebbe consolidare questo orientamento e fornire certezze maggiori, favorendo al contempo l’adeguamento del diritto di famiglia alle esigenze moderne di autonomia, trasparenza e protezione, se dette esigenze dovessero poi trovare il loro precipitato in una norma che preveda spostamenti patrimoniali per il caso di divorzio.
Si segnala infine, provocatoriamente come il legislatore sia perfettamente a conoscenza della possibilità a che i rapporti patrimoniali possano tra diversi soggetti esser disciplinati.
Come sopra evidenziato emerge che così è per quanto concerne i contratti di convivenza, ove il legislatore, non a caso fa riferimento proprio ai contratti, ovvero accordi con cui due soggetti disciplinano i rapporti patrimoniali in vista di una attuale convivenza (e relativa crisi della stessa).
La circostanza per cui, già solo nella legge che introduce detti patti non vi sia alcun riferimento o equiparazione al matrimonio dovrebbe far riflettere l’interprete sulla liceità degli stessi, essendo sicuramente il legislatore del 2016 nella possibilità di estendere detti patti/contratti al matrimonio e non avendolo fatto, anzi, avendo separato nettamente le due ipotesi seppur richiamando la possibilità per i conviventi di optare per il regime della comunione legale dei beni.
Il legislatore, conscio della potenziale commistione tra i due istituti ha inteso operare un richiamo solo dal matrimonio al contratto di convivenza, mutuandone una norma per assoggettarla ad una disciplina di dettaglio, non anche l’ipotesi inversa.
Difatti, a detto rinvio non è seguito un rinvio a contrario dei contratti di convivenza al matrimonio o alla sua crisi.
L’impianto normativo attuale è teso alla tutela ed al mantenimento del vincolo coniugale, non già ad altro, e purtroppo non vi è, nonostante una singola sentenza, seppure della Suprema Corte, alcuna certezza a che detti contratti siano stipulabili.
Al contrario, affermarne la liceità è dannoso per i contraenti potendo in loro generare un legittimo affidamento su pattuizioni che potrebbero esser demolite da un qualsiasi giudice, in assenza di un perimetro normativo certo (operando pertanto solo ragionevolezza e meritevolezza), soprattutto se non stipulati innanzi ad un Notaio il quale garantirebbe l’essere super partes.
Le conseguenze di un siffatto approccio liberista sarebbero devastanti proprio per le parti, inoltre, proprio lo strumento del contratto, in ambito familiare potrebbe costituire (e costituirebbe) arma di ricatto tra coniugi, concetto che mal si concilierebbe con il favor della legge nei confronti del matrimonio e soprattutto con l’intero impianto normativo teso a tutelare il coniuge debole.
La circostanza per cui, astrattamente, detti contratti snellirebbero le cause di divorzio è essa stessa una chimera, posta la possibilità per il giudice di poter procedere ad una loro rivisitazione, anche integrale, oltre che ad una semplicissima non omologazione, con conseguente vanificazione di aspettative, di tempo e di affidamento ed eventuali atteggiamenti previsionali al divorzio stesso.
[1] Cass. N. 6857 del 1992 per cui “accordi, assunti prima del matrimonio o magari in sede di separazione consensuale, e in vista del futuro divorzio, nulli per illiceità della causa, perché in contrasto con ì principi di indisponibilità degli status e dello stesso assegno di divorzio”.
[2] Sul concetto di “indisponibilità” dei diritti e doveri matrimoniali, v. dottrina classica, ad es. [Messina, La famiglia nel diritto privato], nonché numerose pronunce della Cassazione che hanno negato la validità di patti che derogassero agli obblighi del matrimonio.
[3] Ad esempio le decisioni che hanno rigettato patti con clausole di rinuncia anticipata agli obblighi assistenziali o di contribuzione economica, ritenuti lesivi dei doveri inderogabili del matrimonio, tra cui:
-Cass. civ. Sez. I, sentenza 30 gennaio 2017, n. 2224 Accordo tra coniugi in sede di separazione, con pattuizione delle condizioni economiche “anticipate” per un futuro ed eventuale divorzio; in particolare, la donna otteneva un ingente versamento che il marito sosteneva destinato a soddisfare anche l’assegno divorzile oltre ad altri contributi.
La Corte ha dichiarato nulla l’intesa avente ad oggetto l’assegno divorzile, per illiceità della causa, violazione del principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale ex art. 160 c.c. (diritto che tutela il coniuge economicamente debole, la funzione assistenziale, la indisponibilità dell’assegno divorzile
[4] Sentenza per cui “ È valido il contratto, stipulato dai nubendi prima del matrimonio, dove si prevede che, in caso di suo fallimento, uno di essi cederà all’altro un immobile di sua proprietà quale indennizzo delle spese sostenute da quest’ultimo per la ristrutturazione di altro immobile da adibirsi a casa coniugale”
[5] Dottrina recente che ha osservato “una linea di tendenza […] dell’espansione della sfera di operatività dell’autonomia privata anche in relazione ai negozi di diritto di famiglia”. Per approfondimenti vedasi: “Nullità per illiceità della causa dei patti”, articoli di dottrina comparative sull’autonomia negoziale. IUSTLAB+3Rivista Cammino Diritto+3Scuola Magistratura+3
[6] G. Ferrando, Manuale di diritto di famiglia, Zanichelli, 2022
[7] C. C. Mandrioli, Famiglia e autonomia negoziale, Giappichelli, 2021
[8] Cfr. ordinanza Cass. n. 20415/2025; notizie e commenti dopo la pronuncia confermano che la Cassazione ha giudicato valido l’accordo condizionato alla separazione, distinguendo la “causa” e l’“efficacia” del patto. Avvocatipersonefamiglie+4ANSA.it+4C&P Legal+4
[9] Il contratto di transazione è disciplinato all’art 1965 cc. Il quale dispone che: “La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”.
[10] Sul punto dei doveri inderogabili: la pronuncia ricorda che obblighi come assistenza morale, materiale e la solidarietà familiare non possono essere oggetto di patti che li esonerino preventivamente o li comprimano in modo sostanziale. Polesine24+2Avvocatipersonefamiglie+2
[11] Barba, Vincenzo, Patti prematrimoniali tra diritto spagnolo e diritto italiano. Riflessioni in attesa della riforma legislativa e suggerimenti per un revirement della giurisprudenza italiana, Rivista di diritto civile, 2023. Iris
[12] Art 1 co 50 l.n.76/2016I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

