Pubbl. Mar, 21 Ott 2025
L´adozione dei singoli alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale
Modifica pagina
Sebastiano Cascio
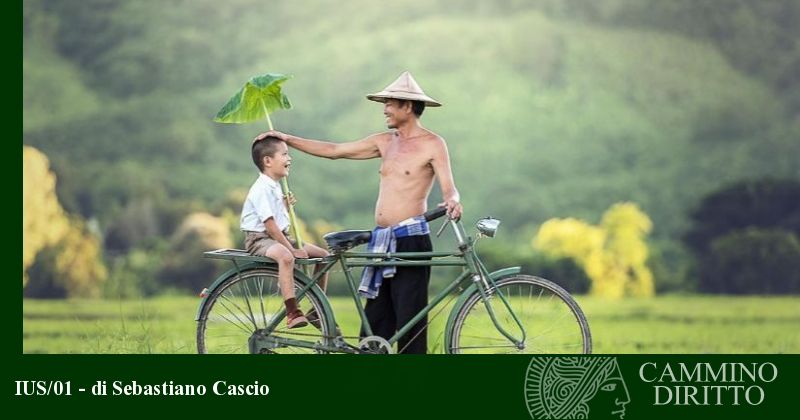
Abstract La sentenza n. 33 del 2025 della Corte Costituzionale italiana ha segnato un punto di svolta nell’ordinamento nazionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale del divieto assoluto per le persone singole di accedere all’adozione internazionale. Il contributo analizza il contenuto della decisione alla luce dei principi costituzionali (artt. 2, 3, 30 e 117 Cost.) e delle fonti sovranazionali, con particolare riferimento all’art. 8 CEDU e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. L’autore ricostruisce il quadro normativo previgente, esamina le ricadute giuridiche e applicative della pronuncia, nonché i profili problematici legati alla discrezionalità giudiziaria e alla mancanza di un intervento legislativo organico.
Sommario: 1. Inquadramento giuridico; 2. La portata dirompente della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025; 3. L’interesse superiore del minore vs status del genitore; 4.Conseguenze giuridiche della pronunzia; Conclusioni.
1. Inquadramento giuridico
Preliminarmente occorre analizzare la situazione legislativa di partenza, ovvero le norme costituzionali e le norme ordinarie che disciplinano la fattispecie.
L’adozione e più in generale la filiazione è uno status che si ottiene a seguito di un complesso procedimento amministrativo o giudiziario.
Per quanto concerne la filiazione, alla manifestazione di volontà del genitore al riconoscimento del figlio segue il procedimento amministrativo (su impulso proprio di detta dichiarazione) con cui l’Ufficiale di stato civile annota proprio la nascita nei registri di stato civile.
L’adozione del pari può essere disposta con sentenza del giudice, (autorità amministrativa), pertanto, in entrambi i casi si nota come vi sia commistione tra volontà del privato e intervento della Pubblica Amministrazione.
In entrambi i casi il figlio riconosciuto o adottato è giuridicamente (figlio) e pertanto attributario dei diritti e doveri riconnessi a detto status (di figlio).
Se i limiti al riconoscimento del figlio biologico sono oramai residuali[1] invero residuano molti limiti per quanto concerne l’adozione soprattutto da parte dei soggetti non coniugati, emerge pertanto una prima disparità di trattamento tra riconoscimento del figlio (naturale) e adozione.
La discriminazione invero è sia per il genitore adottante che per il minore da adottare, ovvero su entrambi i piani, e, detta discriminazione è da rapportare al genitore biologico e figlio biologico.
Posto quanto sopra (nota1) e pertanto determinati figli non immediatamente riconoscibili fattualmente emerge come il riconoscimento del figlio sia immediato ed invece l’adozione sia differita nel tempo e preclusa addirittura in determinati casi a determinati soggetti, non già per questioni legate ad impedimenti giuridici quanto piuttosto ad impedimenti derivanti da peculiari scelte dogmatiche di principio aprioristiche e generalizzate rispetto la singola situazione fattuale.
Sempre ai fini dell’inquadramento normativo si segnala come, con riferimento all’adozione, in via del tutto generale può affermarsi che la legge fondamentale è la legge 4 maggio 1983, n. 184, “Diritto del minore ad una famiglia”, che disciplina l’adozione nazionale, internazionale, l’affidamento, la tutela del minore.
In particolare, l’art. 29‑bis, comma 1 stabiliva che solo le coppie coniugate da tre anni potevano presentare domanda si disponibilità all’adozione internazionale di minori stranieri residenti all’estero[2]. Ciò comportava che il singolo, ovvero il soggetto non coniugato, fosse automaticamente escluso da questa possibilità, salvo eccezioni previste per altri istituti (adozione in condizioni speciali, pre‑adozione, etc.).
In buona sostanza, salvo ipotesi del tutto eccezionali, la regola (poi almeno in parte rovesciata dalla sentenza menzionata infra) era che, per poter procedere ad una adozione di un minore dovesse far alla stessa richiesta una coppia coniugata, principio non esente da critiche[3].
Invero, il limite forse sproporzionato rifletteva una specifica visione del legislatore, difatti, le norme (questa come altre) nulla altro sono se non il precipitato giuridico di principi che una società condivide e che fa propri ed attualizza proprio a mezzo di norme positive che, di quel principio, sono espressione.
Posto il parallelismo cui sopra con il riconoscimento, si segnala come, ad oggi, un pari limite da parte del singolo, al riconoscimento del figlio, non esista ed anzi, è espressamente previsto, agli artt. 251 e seguenti del Codice civile la possibilità a che il riconoscimento provenga proprio da uno solo dei genitori.
Dalla comparazione delle situazioni, emerge una evidente disparità di trattamento.
Se è vero che tanto il riconoscimento quanto l’adozione siano finalizzati a far acquisire al terzo (figlio) lo status di figlio un primo limite allo status di figlio in caso di adozione era rappresentato proprio dalla assenza del rapporto di coniugio.
Il genitore singolo, ha sempre potuto riconoscere il proprio figlio biologico, ma il soggetto singolo non ha mai (salvo casi eccezionali) mai potuto divenire genitore a mezzo adozione se non coniugato.
La barriera all’ingresso alla procedura di adozione impediva sia al soggetto di divenire genitore che al fanciullo a divenire figlio, il tutto in virtù di un’assenza di una scelta a monte, personale e forse personalissima di coniugarsi con un terzo soggetto.
Sempre in via del tutto generale, sul punto giova ricordare gli articoli della Costituzione utili alla ricostruzione sistemica ed alla corretta analisi della questione.
L’articolo 2 del testo costituzionale riconosce i diritti inviolabili (diritti fondamentali), l’articolo 3 enuncia il principio di eguaglianza tra i consociati affidando alla Repubblica (a mezzo legge) la rimozione di vincoli che impediscano la piena attuazione del principio.
L’articolo 30, sempre della Costituzione tutela i diritti del minore ed infine l’articolo 117 dispone che il legislatore sia nazionale che regionale debbano adeguarsi alle norme europee e di diritto internazionale.
Il diritto fondamentale ad essere genitore, per il solo caso di adozione era, giuridicamente sottoposto alla condizione sospensiva del coniugio, cioè, si era in presenza in cui un diritto fondamentale (che si segnala la Costituzione riconosce non attribuisce) era subordinato e quindi vincolato ad una scelta, del pari espressione di un diritto fondamentale (se sposarsi).
Tralasciando valutazioni di merito per un momento logico, è per tutti agevole comprendere come un diritto fondamentale, o meglio il riconoscimento dello stesso, non possa essere vincolato all’esercizio di altro diritto fondamentale, la contraddizione è insanabile.
2. La portata dirompente della sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025
Con la sentenza n. 33 del 21 marzo 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 29‑bis, comma 1 della legge 184/1983 nella parte in cui “non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero residente all’estero” quando la loro idoneità genitoriale sia stata positivamente accertata[4].
Il disposto della sentenza ha una portata dirompente nel nostro ordinamento, essendo Corte Costituzionale il massimo organo giurisdizionale nazionale.
In virtù di quanto detto sopra emerge tuttavia icto oculi la non irragionevolezza della sentenza stessa.
Come esplicato sopra, detta sentenza ha un solido fondamento costituzionale, basandosi sull’art. 2 Costituzione (tutela dei diritti inviolabili della persona), sull’art. 117 Costituzione in relazione all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) [5](diritto al rispetto della vita privata e familiare) e senza dubbio sull’articolo 3 della costituzione.
Se è vero che, come afferma l’art 3 della Costituzione, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscano una piena eguaglianza tra i cittadini innegabile è che uno dei massimi organi della Repubblica (proprio la Corte) abbia dato un impulso in tal senso.
A ben vedere in effetti per come la norma era strutturata pre-sentenza creava una disparità netta tra coppie coniugate e singolo, limitando l’accesso al procedimento di adozione ai soli coniugi.
Indubbio è che l’essere genitore sia un diritto inviolabile del singolo ed indubbio è del pari come limitare in virtù di una petizione di principio l’accesso alla genitorialità ai soli soggetti uniti in matrimonio è indubbiamente discriminatorio e pertanto, almeno astrattamente contrario all’art.3 della Costituzione.
La circostanza per cui la norma appare oggi illegittima tuttavia non deve essere invisa.
Le norme, come sopra accennato, sono il precipitato giuridico del principio che proviene ed è sentito tale da una determinata collettività.
Se negli anni addietro la filiazione e la adozione erano percepite come riconducibili in via generale al coniugio e quindi al matrimonio appare invece evidente come ad oggi in tal binomio (matrimonio filiazione) non vi sia più esigenza di necessaria corrispondenza.
La norma può apparire oggi incostituzionale posto che sono mutati i principi alla stessa sottesi, posto che l’articolo 3 della Costituzione è decisamente precedente alla norma stessa.
La Corte chiarisce infine che non si tratta di un automatismo e pertanto non tutti i singoli saranno ammessi alla relativa procedura (di adozione), ma il divieto assoluto è incostituzionale. Occorrerà che il singolo dimostri, nel corso dell’istruttoria, l’idoneità affettiva, psico‑fisica, e la capacità di garantire un ambiente stabile e armonioso al minore.
Invero anche detta precisazione appare forse ridondante, nella misura in cui anche le coppie coniugate sono tenute a dimostrare quanto sopra, e neanche nel loro caso si è in presenza di alcun automatismo in tal senso.
3. Conseguenze giuridiche della pronunzia
Sono notevoli per l’adozione internazionale di minori stranieri in stato di abbandono, difatti ora anche i singoli possono istanziare la domanda, sottoponendosi alla verifica del Tribunale per i minorenni, come accade per le coppie coniugate.
La normativa che impediva l’accesso è stata, nella parte pertinente, abrogata per incostituzionalità, tuttavia, se questo è vero da un lato vero è anche che non vi è una specifica disciplina di settore per detta eventualità, disciplina che attualmente, almeno in via del tutto astratta costituisce una lacuna normativa in un ambito della vita dei consociati non sottovalutabile.
Tale lacuna tuttavia è colmabile solo dal legislatore, il quale, dovrebbe necessariamente intervenire per adeguare la normativa alla pronunzia della Corte, soprattutto per quanto infra in tema di adozione nazionale.
Invero, la reale problematica sottesa a detta sentenza è quale sia la conseguenza in tema adozioni nazionali da parte del singolo, e la risposta non può essere sul punto frettolosa, meritandosi una riflessione.
Da un lato vero è che la sentenza non ha rimesso in discussione in modo diretto l’esclusione dei single per l’adozione nazionale (o “nazionali” intese come di minori italiani o residenti in Italia), né ha modificato la normativa che regola l’adozione nazionale, e questo è un fatto.
Dall’altro lato è innegabile che il limite per la adozione nazionale ad oggi è, almeno nella sostanza, privo di significato e forse anche incostituzionale e non sono assenti opinioni sulla portata estensiva del fenomeno[6].
Il paradosso che deriva dalla sentenza è che un singolo oggi potrebbe adottare un soggetto minore non italiano e non anche un soggetto italiano.
La discriminazione e pertanto la violazione dell’articolo 3 della Costituzione sono su due piani (almeno), laddove, da un lato sono i minori discriminati nella misura in cui vi sono minori adottabili ed altri no, dall’altro anche i singoli subiscono una limitazione e discriminazione, ancora verso i soggetti coniugati nella misura in cui possono procedere ad adottare solo soggetti stranieri (non anche italiani).
La Corte così come organo giurisdizionale deve sottostare ad un principio, cui all’art 112 cpc[7] principio per cui deve esservi corrispondenza tra quanto oggetto della domanda delle parti e quanto oggetto di sentenza.
La causa innanzi alla Corte non aveva ad oggetto la normativa interna inerente all’adozione dei singoli di soggetti italiani, pertanto, banalmente, la stessa Corte non poteva sul punto esprimersi (ed eventualmente dichiarare incostituzionali le relative norme).
Non mancano, neanche nell’esperienza europea aperture in tal senso, essendo l’adozione dei singoli già possibile in diversi paesi Europei[8]
4. L’interesse superiore del minore vs status del genitore
Invero, il punto fondamentale del discorso, spesso sottovalutato, è proprio nell’articolo 8 della Carta Onu, il punto centrale è l’interesse superiore del minore.
La normativa e la giurisprudenza hanno pertanto il compito di dover assicurare che le regole sull’adozione non ostacolino, quando ciò sia possibile, che un minore in stato di abbandono trovi un ambiente familiare stabile e armonioso. La Corte ha ritenuto che il divieto per i single rappresentasse un divieto in tal senso, e l’apertura delle adozioni ai singoli deve essere bilanciata rispetto all’interesse del minore a vivere in un ambiente salubre e consono alla sua persona, proprio per costui nel rispetto dei di lui diritti fondamentali di minore e di fanciullo.
Conclusioni
La sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2025 rappresenta una svolta significativa nel diritto dell’adozione in Italia, affermando che le persone singole, se idonee, non possono essere escluse a priori dall’adozione internazionale di minori stranieri in stato di abbandono. Questo cambia il paradigma legislativo, introducendo una nuova dimensione del principio di autodeterminazione genitoriale e del principio di uguaglianza.
Tuttavia rimangono questioni aperte quali ad esempio l’estensione al campo dell’adozione interna e la definizione di criteri procedurali chiari.
Il ruolo del legislatore sarà cruciale per dare stabilità normativa e linee guida omogenee, anche e forse soprattutto al fine di tutelare pienamente l’interesse del minore.
Il punto di partenza tuttavia deve essere prendere atto della pronunzia della corte, ma soprattutto prendere atto del principio che la stessa ha affermato.
La Corte ha espressamente sganciato l’adozione dal coniugio, e pare condivisibile questa ricostruzione posto che non è corretto subordinare un diritto fondamentale, quale l’essere genitore all’esercizio di un altro diritto fondamentale (convolare a nozze).
I diritti fondamentali devono dalla legge essere riconosciuti e tutelati così come sono riconosciuti e tutelati dalla Costituzione.
Dall’altro lato non si può operare una discriminazione a monte tra soggetti coniugati e non coniugati nell’accesso allo status di genitore e non può nemmeno operarsi una discriminazione tra minori.
Attualmente, come segnalato sopra, il minore straniero è adottabile anche dal singolo, il minore italiano, per come la legge è formulata, non è adottabile dal singolo, la discriminazione stride con ogni principio giuridico e non in tema di uguaglianza.
Forse, proprio alla luce della recente sentenza, ed alla luce del mutato orientamento a monte in tema di adozione, è il caso di ritenere che si sia in presenza di una norma, ad oggi, ancorché formalmente effettiva, nella sostanza abrogata tacitamente e comunque di certo incostituzionale.
Ancorché forse così può ritenersi, tuttavia, la norma è vigente e pertanto ad oggi il singolo non può proprio avviare il complesso procedimento per l’adozione di un minore italiano.
Vertendosi in tema di diritti super sensibili l’intervento del legislatore non solo è auspicabile sia celere ma soprattutto sia quanto più chiaro e risolutivo.
A parere dello scrivente detto intervento normativo deve essere assolutamente nel senso di abbattere le ultime barriere normative sul punto, attuando non solo la sentenza della Corte ma soprattutto attuando il principio di uguaglianza cui all’art.3 della Costituzione e pertanto, rimuovere gli ostacoli che impediscono ai cittadini di essere eguali.
[1] Riconoscibili solo previa autorizzazione sono, ex art 251 c.c. i figli nati tra parenti e i figli i cui genitori sono minori.
[2] Art. 6, legge n. 184/1983 (come modificata dalla legge n. 149/2001) per le coppie nazionali e articolo 29 bis della medesima legge per l’adozione internazionale.
[3] Cfr. L. LENTI, Il diritto del minore a una famiglia e l'evoluzione delle forme di adozione, in “Famiglia e diritto”, 2020, p. 345 ss.
[4] Corte Cost. n. 33/2025, in www.cortecostituzionale.it; commentata da G. Ferrando in “Giurisprudenza italiana”, 2025, p. 589 ss.
[5] Sul punto, v. A. RUGGERI, L’art. 117 Cost. come veicolo di parametri esterni: problemi e prospettive, in “Forum di Quaderni costituzionali”, 2023 e Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con legge n. 176/1991
[6] V. M. WINKLER, Le potenzialità estensive della sentenza 33/2025 per l’adozione nazionale, in “Diritto di famiglia e delle persone”, 2025, p. 431
[7] Il cui testo è il seguente: “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
[8] Per una panoramica comparata si veda A. MASSARO, Single Parent Adoption in Europe, in “European Journal of Family Law”, 2024, p. 87 ss.

