Pubbl. Mar, 25 Nov 2025
La Cassazione sulla tutela consumeristica nel contratto di fideiussione e le clausole contenute in contratti sottoscritti mediante atto pubblico
Daniela Ferro
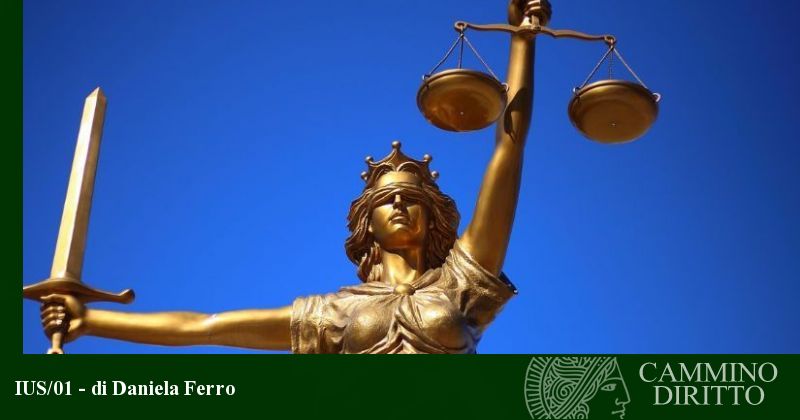
La Cassazione, ancora una volta, ha avuto modo di pronunciarsi con provvedimento Cass. civ., Sez. I, Ord., data ud. 11/06/2025, dep. 10/07/2025, n. 18834, sull´applicabilità della disciplina consumeristica andando ad evidenziare come il giudizio sulla qualifica di consumatore debba essere svolto in concreto e non in modo aprioristico. Con l´ordinanza in oggetto, la Corte ha analizzato l´ipotesi di estendere l´applicabilità della disciplina consumeristica ad un contratto di fideiussione ed alle clausole in esso contenute, con particolare riguardo ai contratti conclusi per atto pubblico.
Sommario: 1.Premessa; 2. La qualifica di consumatore e l’articolo 34 del Codice di Consumo; 3. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione; 4. Le clausole contenute nell’atto pubblico e la disciplina consumieristica; 5. Conclusioni.
1. Premessa
La Corte di Cassazione, nel pronunciamento in oggetto, ha avuto modo di precisare come, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, facendo riferimento anche a quanto già precisato, sul punto dalla giurisprudenza comunitaria[1].
In questo modo si può ritenere consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, abbia posto in essere il contratto di garanzia per finalità estranee allo svolgimento della sua attività professionale in senso stretto, andando a confermare un orientamento già espresso dalla Cassazione[2].
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva ritenuto di escludere l’applicabilità della disciplina consumeristica al contratto di garanzia, argomentando che la stessa non fosse applicabile poiché da leggere in correlazione al fatto che la parte, ovvero il sottoscrittore, fosse un imprenditore commerciale.
2. La qualifica di consumatore e l’articolo 34 del Codice di Consumo
Il percorso che ha condotto alla definizione e qualificazione della figura del consumatore, nel nostro ordinamento, è stato lungo e complesso e, per certi versi, non si può definire concluso, poiché il consumatore rappresenta una figura che si evolve con il mutare dei mercati e, soprattutto, che ha acquisito nel tempo una differente consapevolezza ed un diverso potere contrattuale.
Nel nostro ordinamento il consumatore è definito come quella persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. In altre parole, è colui che acquista beni o servizi per uso personale, familiare o domestico, e non per scopi legati alla propria attività lavorativa.
La definizione di consumatore è importante perché stabilisce la categoria di persone che beneficiano della tutela prevista dal Codice del Consumo[3], ovvero il testo normativo che mira a proteggere i consumatori da eventuali pratiche commerciali scorrette, o da beni o servizi difettosi.
La disciplina specifica, sotto il profilo definitorio, trova compiuta tipizzazione all’articolo 3, che rappresenta la sintesi di un percorso che ha portato solo nel 2005 alla tipizzazione cui stiamo facendo riferimento[4].
Alla luce di queste considerazioni abbiamo che quando ci si riferisce ad un "consumatore" si intende una persona che agisce per scopi personali, e non per scopi legati alla sua attività professionale o imprenditoriale.
Dottrina e giurisprudenza si sono, inoltre, particolarmente interessate, nel qualificare il consumatore, al tema dello squilibrio informativo tra il consumatore stesso ed il professionista e, a tal fine, sul grado di consapevolezza del consumatore nel prendere le proprie decisioni.
In materia vi sono differenti studi e alcuni interventi normativi, specialmente di rango comunitario, che puntano l’attenzione proprio sulla qualificazione del consumatore medio ed il grado di consapevolezza che gli è richiesto per effettuare le sue scelte[5].
Si parla spesso, in questi casi, di determinazione volitiva, che rappresenta, in estrema sintesi, l’esito finale di un processo elaborativo nell’ambito del quale si ricollegano la funzionalità della consapevolezza e l’adeguatezza[6].
Sostanzialmente, quando parliamo di una decisione consapevole dobbiamo mettere al primo posto la disponibilità dell’informazione, relazionandola con il patrimonio conoscitivo di base del consumatore stesso, nell’ambito di un contesto dinamico ed evolutivo che si adatta al consumatore stesso ed alla sua soggettività, ovvero alla sua capacità di ricollegare e sintetizzare le informazioni funzionalmente allo scopo che deve raggiungere.
È importante considerare che le scelte del consumatore possono essere influenzate da una pluralità di fattori che, a loro volta, non sono sempre costanti e che possono risentire dello specifico momento in cui il consumatore stesso deve prendere la decisione andando, in questo modo, a qualificare il cosiddetto consumatore medio, che viene interpretato come il parametro di valutazione di quelle che sono le esigenze di tutela che allo stesso devono essere riconosciute ed accordate dall’ordinamento[7] e che trovano riconoscimento anche in noti pronunciamenti giurisprudenziali[8].
In estrema sintesi, dunque, abbiamo che nella scelta delle informazioni pubblicitarie ricevute, il consumatore medio si identifica con quello normalmente informato e ragionevolmente avveduto[9].
In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia europea secondo la quale non si può procedere alla qualificazione del consumatore in base ad un modello astratto, per questo presupporrebbe che la portata delle informazioni fornite dal professionista in relazione a un determinato prodotto dovrebbe essere sempre la stessa, indipendentemente da chi sia il consumatore determinato che entra in contatto con il prodotto[10].
Si tratta di considerazioni particolarmente rilevanti che possono considerarsi anche alla base del pronunciamento della Cassazione alla nostra attenzione.
3. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte di Cassazione
Oltre ad una serie di ulteriori motivi posti a fondamento del ricorso in Cassazione, ritenuti inammisibili dalla Corte stessa, i ricorrenti hanno proposto impugnazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Palermo che non li aveva riconosciuti come consumatori, non ritenendo loro applicabile la disciplina consumieristica.
Gli stessi avevano invocato l’applicazione di detta disciplina in qualità di sottoscrittori del contratto di fideiussione nell’ambito del quale gli stessi risultavano garanti di una società esercente attività commerciale e non come legali rappresentanti della società medesima.
L’invocazione della disciplina consumieristica derivava dall’esigenza di eccepire la vessatorietà di alcune clausole inserite nel contratto stesso da cui sarebbe potuta discendere la nullità delle stesse.
Nel contratto sottoscritto, infatti, era presenta una limitazione delle facoltà, in capo al garante (o ai garanti come in questo caso) di opporre eccezioni o di far valere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.[11].
Queste clausole dovevano essere considerate come clausole abusive proprio in ragione di quanto stabilito dal codice del consumo.
Nel contratto, inoltre, era prevista una maggiorazione in caso di mora e ad essa si ricollegavano penali e maggiorazioni e rinunce a diritti sanciti dal Codice civile, andando ad integrare, con evidenza, clausole vessatorie, considerato anche che per le stesse non vi era prova che vi fosse stata una specifica trattativa.
Secondo la Corte di Appello, i ricorrenti avevano agito come garanti della società per scopi funzionali all'attività commerciale svolta dalla debitrice e, pertanto, non potevano essere considerati come consumatori.
Differentemente, però, argomenta la Cassazione che sul punto invoca precedenti pronunciamenti della Cassazione stessa[12] e della Corte di Giustizia Europea[13] in ragione dei quali i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto, senza considerare il contratto principale.
In tal senso si può considerare consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, sottoscriva un contratto di garanzia per finalità estranee alla sua attività professionale, considerando che la prestazione della fideiussione <non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento>.
Nella valutazione devono essere presi in considerazioni elementi strettamente soggettivi, come possono essere l'entità della partecipazione al capitale sociale, o la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore[14].
La Corte di Appello, pertanto, erroneamente, aveva ritenuto di doversi limitare a ritenere non applicabile la disciplina consumieristica poiché gli appellanti erano imprenditori commerciali, indipendentemente dal fatto che, nell’ambito del contratto di fideiussione, questa condizione fosse irrilevante.
4. Le clausole contenute nell’atto pubblico e la disciplina consumieristica
L’ulteriore aspetto particolarmente significativo che ha avuto modo di osservare la Cassazione è che la Corte di Appello aveva ritenuto non applicare la disciplina del Codice del Consumo al caso di specie poiché le clausole contestate erano contenute in un contratto sottoscritto per atto pubblico.
Il ragionamento posto alla base della argomentazione della Corte di Appello è che le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, per quanto si possano considerare come predisposte da uno dei contraenti e nel suo interesse, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione[15].
Si tratta di una argomentazione che non tiene conto di quanto stabilito dal Codice del Consumo, con particolare riguardo all’articolo 34[16]. Nell’alveo di questo disposto normativo, in particolar modo, si deve porre l’attenzione sull’ultimo comma in ragione del quale abbiamo che nel contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali è fatto onere al professionista di provare che clausole ed elementi di clausola siano stati oggetto di specifica trattativa.
Questa precisazione della norma, però, non implica che nelle ipotesi di contratti diversi da quelli standard incomba al consumatore che agisce in giudizio fornire una prova negativa, ovvero provare che la trattativa non ci sia stata[17].
In particolar modo è importante osservare come la trattativa non rappresenti un elemento costitutivo della vessatorietà ma debba essere valutato quale presupposto oggettivo di esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in questione andandosi a sostanziare alla stregua di un fatto impeditivo.
Di par contro si osserva come incomba sul consumatore allegare e provare i presupposti ed i requisiti necessari e sufficienti che possano condurre alla declaratoria di inefficacia delle clausole impugnate[18].
In ragione di queste considerazioni la Cassazione precisa che la distribuzione dell'onere probatorio opera solo con riguardo ai negozi conclusi con l'uso di moduli o formulari non distinguendo tra contratti standard e contratti predisposti per singoli affari.
Questa regola, sempre in ragione di quanto stabilito dalla Corte nel pronunciamento alla nostra attenzione, non subisce variazioni particolari nella specifica ipotesi in cui il contratto sia concluso nella forma dell'atto pubblico.
In tempi recenti, infatti, la Cassazione aveva avuto modo di precisare questo concetto, argomentando al contrario ovvero argomentando come anche nelle ipotesi in cui il testo contrattuale venga predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, la disciplina consumieristica può ritenersi esclusa quando il consumatore abbia avuto la possibilità di concretamente incidere sul contenuto del contratto[19].
5. Conclusioni
La Cassazione ha, ancora una volta, avuto modo di precisare come sia necessario, nell’applicazione della legge consumieristica, la valutazione, in concreto, della posizione dei contraenti relativamente allo specifico contratto. Si tratta di un approccio che la Cassazione, a ben guardare, tende ad applicare trasversalmente nell’ottica di rendere le norme dinamiche e plasmabili all’analisi del caso contrato.
Quello che potrebbe emergere, come aspetto critico, da questo pronunciamento, si ricollega maggiormente al tema dei contratti conclusi per atto pubblico ed alla riconducibilità delle clausole in esso contenute al vaglio della disciplina consumieristica.
Quello che ci si chiede è se possano essere sottratte al controllo ed al vaglio del Pubblico Ufficiale e, quindi, passibili di una declaratoria di nullità clausole contenute in un atto pubblico? Sembrerebbe, in tal modo, di depauperare la funzione del Pubblico Ufficiale nello svolgimento del suo ruolo.
La Cassazione giustifica il suo approccio invocando la legge notarile impone, tra gli altri aspetti, al notaio di indagare la volontà delle parti e di curare la compilazione integrale dell'atto stesso sotto la propria direzione e responsabilità[20].
Questa norma invocata dalla Cassazione non implica che il notaio, tra i suoi compiti, abbia l’onere di verificare se il contratto e le clausole in esso contenute siano state oggetto di specifica trattativa.
Questo modo di argomentare conduce la Cassazione a ritenere quando una clausola presumibilmente vessatoria sia frutto di una imposizione unilaterale e non costituisca espressione di una trattativa, non rilevi che il notaio l’abbia esplicitata al contraente consumatore e che lo stesso dimostri di averne conosciuto il contenuto.
Questo approccio, per quanto generalmente condivisibile, apre il fronte a successive osservazioni ed analisi poiché il confine di applicabilità della legge consumieristica tende, nel tempo, a divenire sempre più sottile tale da chiedersi se vale ancora la pena non estendere la disciplina a tutti i contratti indipendentemente dalla qualifica dei contraenti.
[1] Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte Giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras
[2] Cass. Sez. Un. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742
[3] Decreto Legislativo 206/2005.
[4] Art. 3 D.lgs 206/2005: Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis e nell'articolo 128, comma 2, lettera d), il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.
[5] Carmignani S., L’informazione ai tempi della sostenibilità, Rivista di diritto alimentare, Anno XVIII, numero 1 • gennaio-marzo 2024, p.1
[6] Carmignani S., op.ult.cit.
[7] Alpa G., La tutela del consumatore in L. Di Donna, Diritto privato dell’economia. Aspetti e problemi, Torino, Giappichelli, 2019, p. 335.
[8] Corte.App. Bologna 26 ottobre 2000, in Dir. ind., 2001, p. 247 ss.<”consumatore medio” rappresenti una tipologia culturale e astratta di consumatore, che può identificarsi in una modesta minoranza dei consumatori di un determinato settore merceologico. E anche laddove la categoria del consumatore medio fosse ricostruita sulla base di rilevazioni numeriche, ciò avverrebbe senza alcuna preventiva selezione in base alla capacità di giudizio, ai metodi di acquisto, alla cultura di base, alle abitudini alimentari dei soggetti coinvolti nell’analisi statistica, senza, cioè, alcuna garanzia della rappresentatività del campione prescelto
[9] Carmignani S., L’informazione ai tempi della sostenibilità, Rivista di diritto alimentare, Anno XVIII, numero 1 • gennaio-marzo 2024 p.2
[10] Corte Giustizia 10 giugno 2021, da C-776/19 a C-782/19, BNP Paribas Personal Finance
[11] Art. 1957 c.c.: Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.
[12] Cass. Sez. U. 27 febbraio 2023, n. 5868; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742
[13] Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcau, e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras
[14] Cass. 13 dicembre 2018, n. 32225
[15] Sul punto Cass. 16 luglio 2020, n. 15253; Cass. 19 giugno 2017, n. 15237
[16] Art. 34 Codice Consumo: La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
[17] Pagliantini S., Il consumatore frastagliato: (istantanee sull'asimmetria contrattuale tra vicende circolatorie e garanzie), E book, Pacini Editore, 2021
[18] Sul punto Cass. 26 settembre 2008, n. 24262
[19] Cass. 14 febbraio 2024, n. 4140
[20] l. n. 89/1913, art. 47.

