Pubbl. Mer, 4 Giu 2025
La natura e conseguenze del c.d. remand in sede cautelare
Modifica pagina
Federico Loche
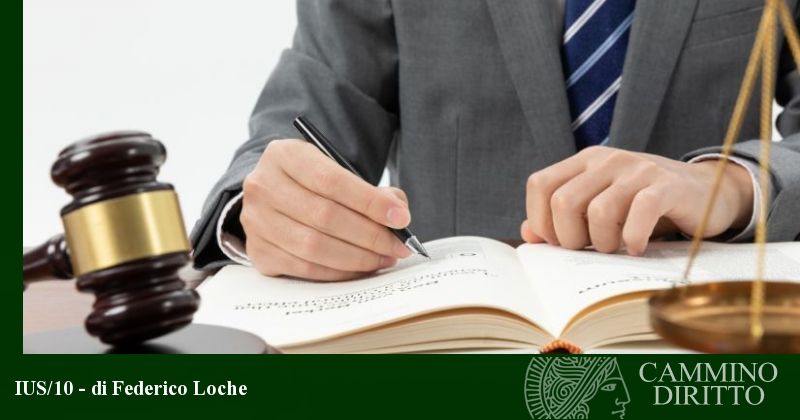
L´Autore, premessa una breve analisi della tutela cautelare, ed esaminato l´istituto del cd. remand, considerato sia sotto la lente dell´orientamento giurisprudenziale che attraverso il filtro dell´analisi dottrinale, commenta la sentenza del TAR Sicilia 5 marzo 2025, n. 818, secondo cui ”qualora l´amministrazione, nell´adozione di un nuovo provvedimento a seguito di ordinanza cautelare propulsiva (remand), manifesti in maniera espressa e inequivoca che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice (e non mera esecuzione a quanto statuito nell´ordinanza cautelare) sarà possibile qualificare quest´ultima a guisa di nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente”.
 ENG
The Author, having first provided a brief analysis of interim relief and having examined the institute of the so-called ”remand”, considered both through the lens of case law and through the filter of doctrinal analysis, comments on the judgment of TAR Sicily of 5 March 2025, no. 818, according to which: ” Where the administration, in adopting a new measure following a propulsive interim order (remand), expressly and unequivocally manifests that such determination is the result of a new and autonomous will to decide on the matter sub judice (and not mere execution of what was ruled in the interim order), it shall be possible to qualify the latter as a new administrative measure, substitutive of the previous one”.
ENG
The Author, having first provided a brief analysis of interim relief and having examined the institute of the so-called ”remand”, considered both through the lens of case law and through the filter of doctrinal analysis, comments on the judgment of TAR Sicily of 5 March 2025, no. 818, according to which: ” Where the administration, in adopting a new measure following a propulsive interim order (remand), expressly and unequivocally manifests that such determination is the result of a new and autonomous will to decide on the matter sub judice (and not mere execution of what was ruled in the interim order), it shall be possible to qualify the latter as a new administrative measure, substitutive of the previous one”.Sommario: 1. La domanda cautelare quale espressione del principio di effettività della tutela; 1.1 Evoluzione della tutela interinale e atipicità della misura cautelare; 2. Il remand quale misura di tutela atipica e propulsiva; 3. La sentenza del TAR Sicilia 05 marzo 2025, n. 818; 3.1 Le tesi pretorie a confronto; 4. Conclusioni.
1. La domanda cautelare quale espressione del principio di effettività della tutela
Scriveva autorevole dottrina che il processo deve dare, per quanto è possibile, a chi esercita il potere di azione, tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire (Chiovenda): in tali termini, viene oggi definito il principio di effettività della tutela, che il legislatore ha alfine positivizzato con l’art. 1 del codice del processo amministrativo. Tale principio sembra, peraltro, assumere la natura di declinazione processuale di un approdo sostanziale di origini risalenti, se è vero che già il giurista romano Ulpiano, nel III secolo d.C., fissando gli iuris praecepta, prevedeva, tra essi, il “suum cuique tribuere”: a ognuno deve dunque essere attribuito quanto gli spetta.
Ciò comporta, evidentemente, che il tempo necessario a portare a conclusione un processo non può ridondare in termini di pregiudizio per chi si rivolge alla Giustizia, giacché, altrimenti, verrebbe frustrata l’esigenza di tutela del soggetto istante, rivelandosi di scarsa effettività.
Per tale motivo, il giudizio amministrativo – in considerazione della esecutorietà che colora la natura del provvedimento amministrativo, giacché, ai sensi dell’art. 21-ter della legge n. 241/1990, l’Amministrazione può eseguire coattivamente il provvedimento - prevede che il ricorrente possa domandare, interinalmente rispetto alla domanda principale, una tutela cautelare atta ad anticipare gli effetti del provvedimento finale, o, quanto meno, a non frustrare l’utilità di un’eventuale sentenza favorevole.
Emerge, dunque, chiara la natura strumentale e transitoria (rispetto al giudizio di merito) della tutela cautelare - la quale, invero, scriveva Calamandrei, ha «lo scopo immediato di assicurare la efficacia pratica del provvedimento definitivo» - atta a evitare che l’esecuzione del provvedimento amministrativo comprometta gravemente, se non in modo irreversibile, la posizione del destinatario dell’atto[ii]. Pertanto, per dirla con il Consiglio di Stato, «La giurisprudenza da tempo assegna ai provvedimenti cautelari emanati dal giudice amministrativo la funzione di escludere o, comunque, di mitigare il danno insito nel provvedimento impugnato, posto che la tutela cautelare è diretta alla temporanea salvaguardia della posizione del deducente, onde consentirgli - qualora risultasse vincitore nel merito - di trarre l’utilità sostanziale offerta dalla decisione, producendo in via temporalmente anticipata nella sua sfera giuridica benefici omogenei e comunque non superiori rispetto a quelle che la sentenza potrà procurare»[iii].
1.1 Evoluzione della tutela interinale e atipicità della misura cautelare
In termini di evoluzione del sistema cautelare, va ricordato che, originariamente, così come la sola azione di merito era quella demolitoria, con la quale l’istante chiedeva in giudizio l’annullamento del provvedimento amministrativo, allo stesso modo la sola domanda cautelare tipica era costituita dalla possibile sospensione della efficacia e della esecutorietà del provvedimento: evidentemente, si trattava di una tutela solo parzialmente satisfattiva per il ricorrente, giacché idonea a tutelare i soli interessi legittimi oppositivi; l’eventuale sospensione di un provvedimento di rigetto opposto dall’Amministrazione – atto, dunque, a frustrare un interesse legittimo pretensivo - non avrebbe potuto portare alcun giovamento all’interessato.
Al fine, dunque, di assicurare una tutela piena ed effettiva anche agli interessi legittimi pretensivi del ricorrente, il sistema si è, dunque, evoluto, contemplando provvedimenti propulsivi e riconoscendo, alfine, l’atipicità delle misure cautelari.
Un ruolo decisivo, in tal senso, lo ha assunto la Corte costituzionale, la quale, con una storica sentenza, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (legge istitutiva dei TAR e recante le norme di procedura fino alla successiva emanazione del codice del processo amministrativo) «nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile»[iv]. Nonostante l’attinenza diretta della citata sentenza alle controversie patrimoniali in materia del pubblico impiego, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la decisione della Consulta ha avuto un ruolo decisivo perché, per la prima volta, si è ammessa l’atipicità della tutela cautelare anche nell’ambito del giudizio amministrativo.
L’intervento della Corte ha trovato, peraltro, una sponda esegetica sovranazionale, giacché la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con due sentenze, ha contribuito alla costruzione di una tutela cautelare atipica, affermando l’incompatibilità con il diritto (prima comunitario, poi) unionale di eventuali norme, o prassi interne, che impediscano al giudice di concedere i provvedimenti provvisori necessari a garantire nelle more del giudizio le posizioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto dell’Unione europea, ivi inclusi i provvedimenti “positivi”[v].
Successivamente, quindi, il legislatore nazionale riscriveva il citato art. 21 della legge TAR, prevedendo che il G.A. potesse emettere le misure cautelari che apparissero, secondo le circostanze, “più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”; tale è, oggi, il contenuto del vigente art. 55/1 CPA, che dunque positivizza il principio dell’atipicità delle misure cautelari, sancendo, da una parte, il passaggio da un sistema cautelare monistico (la sospensione del provvedimento amministrativo) a un sistema aperto, e assicurando, dall’altra, alle misure interinali la stessa elasticità che il sistema del processo civile imprime alle proprie misure cautelari[vi].
2. Il remand quale misura di tutela atipica e propulsiva
Tra le decisioni cautelari che formano parte integrante dello strumentario del Giudice Amministrativo, figurano, dunque, le ordinanze propulsive (cd. remand), la cui particolarità risiede nel fatto che, con esse, il decidente non si limita a sospendere gli effetti del provvedimento impugnato ma, piuttosto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza del privato e ad adottare un provvedimento emendato dai vizi riscontrati dal Giudice. È stato osservato, in dottrina, che la giurisprudenza amministrativa ha fatto un uso sempre più frequente delle ordinanze propulsive in esame al fine di valorizzare il contenuto anticipatorio dei provvedimenti cautelari dal momento che, con esse, il Giudice può ordinare all’Amministrazione di «valutare aspetti non considerati in sede procedimentale, ovvero il riesame di profili valutati in modo non adeguato o incompleto (o anche l’esame di fatti sopravvenuti)»[vii]. Esemplificando: la giurisprudenza amministrativa ha adottato ordinanze propulsive per sospendere, con il fine di riesaminare e diversamente ponderare il compendio istruttorio, il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla commissione per la VIA, in relazione alla realizzazione di un impianto eolico[viii].
Emerge, così, la natura dialogica delle ordinanze propulsive, le quali instaurano «un dialogo diretto tra giurisdizione e amministrazione finalizzato a orientare l’attività discrezionale della seconda nella direzione suggerita dalla prima, onde pervenire all’adozione di un provvedimento emendato dai vizi riscontrati in sede giudiziale»[ix].
Non si è mancato peraltro di osservare, da parte di attenta dottrina, come le ordinanze propulsive, consistendo in «un ordine alla pubblica amministrazione di riesaminare il provvedimento di diniego emanato tenendo conto delle censure formulate nel ricorso e di altre indicazioni fornite dal giudice (cosiddetto remand)», possano anticipare in qualche modo «il contenuto conformativo della sentenza»[x].
Tra ordinanza propulsiva e successiva riedizione del potere da parte dell’Amministrazione v‘è, dunque, potremmo dire, un flusso giuridico di cui è fonte il cennato canale dialogico che intercorre tra il Giudice e la P.A. La giurisprudenza amministrativa parla, sotto tale aspetto, di continuum funzionale, allorquando osserva che «Nel giudizio amministrativo, la circostanza per cui l'ordinanza di sospensione di un diniego sia stata adottata attraverso la cd. tecnica del “remand”, ossia mediante la fissazione delle coordinate operative e sistematiche cui informare la concreta riedizione del potere, non consente all’Amministrazione di limitare la propria attività conformativa alla mera rimozione del provvedimento negativo oggetto di impugnativa, altrimenti venendo meno il “continuum” funzionale (anche in chiave procedimentale) che necessariamente deve intercorrere fra lo “jussum” giudiziale (quand’anche impartito nella forma dell’ordinanza cautelare atipica) e le conseguenze conformative, risolventisi nella riedizione del potere, secondo l’assetto delineato attraverso il comando del giudice»[xi].
Il dialogo tra Giudice a Amministrazione, come è stato osservato, mira «ad orientare l’attività discrezionale [dell’Amministrazione] nella direzione, ritenuta giuridicamente ortodossa, suggerita [dalla giurisdizione]»[xii]. Per tale motivo, la giurisprudenza amministrativa osserva, sul punto, che «è indiscutibile il vincolo conformativo che le ordinanze cautelari del tipo appena descritto [propulsive: NdA] imprimono alla potestà oggetto di vaglio giurisdizionale: di qui la sicura illegittimità di un provvedimento, adottato in seguito ad un impulso cautelare, che ignori completamente il tenore precettivo della misura di carattere propulsivo, fonte e limite della rinnovazione procedimentale»[xiii].
3. La sentenza del TAR Sicilia 05 marzo 2025, n. 818
Nella cornice del descritto quadro sistematico, si inserisce la sentenza 5 marzo 2025, n. 818 del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, secondo la quale «laddove la p.a., nell’adozione di un nuovo provvedimento a seguito di remand, manifesti, in maniera espressa e inequivoca, che tale determinazione sia il frutto di una nuova e autonoma volontà di provvedere sulla vicenda sub iudice, sarà possibile qualificare quest’ultima a guisa di nuovo provvedimento amministrativo, sostitutivo del precedente, con conseguente cessazione della materia del contendere ovvero improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse». Secondo il Giudice siciliano, dunque, soltanto nel caso in cui l’Amministrazione, riesercitando il potere provvedimentale in seguito a un’ordinanza propulsiva del G.A., non si limiti a dare mera esecuzione a quanto statuito nell’ordinanza cautelare, ma, al contrario, effettui nuove valutazioni di ponderazione degli interessi coinvolti nella vicenda amministrativa, e manifesti quindi, espressamente, un’autonoma volontà di provvedere, «in grado di far confluire la (rinnovata) decisione dell’Amministrazione in un provvedimento diverso rispetto a quello originariamente impugnato», sarà consentito parlare di nuovo provvedimento amministrativo, tale che, conseguentemente, esso sostituisca il precedente e determini la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1 Le tesi pretorie a confronto
La decisione del Giudice siciliano giunge a tale conclusione conformandosi alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale aveva già delimitato i casi in cui, dalle ceneri del precedente e impugnato provvedimento, sorga un nuovo assetto regolatorio del rapporto amministrativo. Precisamente: «La concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell'amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito — come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio — ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell'amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l'ordinanza propulsiva per il principio factum infectum fieri nequit dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l'amministrazione effettui una nuova valutazione ed adotti un atto espressione di nuova volontà di provvedere, che costituisca pertanto un nuovo giudizio, autonomo e indipendente dalla stretta esecuzione della pronuncia cautelare, con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata»[xiv].
Ciò comporta, pertanto, che, solo ove l’Amministrazione non si limiti a dare esecuzione all’ordinanza propulsiva del Giudice ma, al contrario, eserciti nuovamente il potere all’esito di una rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti nella vicenda amministrativa, manifestando la volontà di provvedere in tal senso (a valle, dunque, di una nuova valutazione discrezionale che confluisca in un provvedimento diverso da quello oggetto di gravame), la nuova determinazione assunta dall’Amministrazione sostituisce il precedente provvedimento, impugnato dal ricorrente, e determina la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del contenuto satisfattivo, o meno, del nuovo provvedimento rispetto alla pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente.
Tale approdo pretorio si inserisce nel solco dell’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa, il quale ha avuto modo di osservare che esso è l’unico in grado di mostrare un alto tasso di compatibilità con la natura (strumentale e transitoria) dell’ordinanza cautelare.
Ha affermato la giurisprudenza, infatti, in una prospettiva di ricostruzione dogmatica dell’istituto, che «per sua natura il provvedimento cautelare non dovrebbe poter definire il giudizio sull’atto impugnato (né, dunque, potrebbe ordinare di confezionarne uno nuovo, impugnabile con motivi aggiunti, facendo così rinascere il processo dalle sue ceneri sol perché il giudice abbia scelto di non percorrere la via maestra della definizione della causa con sentenza), essendo solo con la sentenza che il giudice deve decidere il giudizio, sicché appare quantomeno opinabile che abbia il potere di (obbligare le parti a) far cessare la materia controversa (circa uno specifico provvedimento) con una mera pronuncia ordinatoria e cautelare»; ne consegue, naturalmente, la perimetrazione delle ipotesi in cui il nuovo provvedimento sostituisce il precedente, dovendosi esse confinare alla sola eventualità in cui l’Amministrazione non abbia voluto dare mera esecuzione all’ordinanza propulsiva; ossia, può convenirsi che «l’efficacia della pronuncia sollecitata dal giudice (in difetto di una diversa autodeterminazione amministrativa, che però risulti in modo espresso essere stata assunta con spontanea volizione di definitività, e non già imposta iusso iudicis) non dispieghi effetti più che interinali, ossia destinati a caducarsi ex se con la decisione della causa nel merito»[xv].
L’orientamento minoritario di segno diverso, invece, parrebbe trarre, da una sovrapposizione in controluce, una perfetta identità tra esercizio del potere amministrativo a seguito di un’ordinanza propulsiva e sterilizzazione del provvedimento gravato, che sarebbe in ogni caso sostituito dalla nuova determinazione amministrativa. In tale prospettiva, è stato infatti osservato che «il c.d. remand, essendo una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l’assetto degli interessi già definiti con l’atto gravato, restituisce all’autorità l’intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; di conseguenza, il nuovo provvedimento di rigetto, anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, costituisce espressione di una funzione amministrativa e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale, implicando il definitivo superamento delle valutazioni poste alla base del provvedimento confermato, sicché la parte ricorrente non conserva più interesse alla coltivazione dell’impugnativa proposta avverso tale ultimo provvedimento, impugnativa che è, pertanto, destinata ad essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse»[xvi].
Tale orientamento, tuttavia, nel momento in cui consente al remand di soffocare il provvedimento gravato, spegnendone definitivamente ogni residuo sospiro, anche nelle ipotesi in cui l’Amministrazione si limiti a dare mera esecuzione all’ordinanza propulsiva, e quindi omettendo di valorizzare la volontà della P.A., parrebbe porsi in contrasto con la natura strumentale e transitoria delle ordinanze (cautelari, e nello specifico) propulsive, le quali assumerebbero, per tale via, la natura di sentenza anticipata.
Tale orientamento, pertanto, non convince, anche perchè, di tal guisa, osserva la sentenza del TAR Sicilia in commento, si finirebbe per «attribuire alla parte ricorrente, sempre e comunque e per il sol fatto di avere adottato un'ordinanza propulsiva, un vantaggio addirittura maggiore di quello che deriverebbe dall'accoglimento della domanda di annullamento nella sede di merito, con evidente snaturamento delle caratteristiche e della finalità delle misure cautelari». Inoltre, l'esposta tesi espone il fianco alle critiche di una parte della dottrina, la quale non ha mancato di criticare l’istituto del remand, osservando che, ove il Giudice, richiesta all’Amministrazione una nuova valutazione della vicenda al suo esame, tenda poi «a considerare definita la controversia» si porrebbe in tal modo all’esterno del perimetro normativo, atteso che «un tale potere del giudice non trova riscontro nella disciplina normativa, che configura la tutela cautelare unicamente come tutela anticipatoria, provvisoria e strumentale alla decisione di merito»[xvii].
4. Conclusioni
Le conclusioni cui giunge il TAR siciliano, con la sentenza in commento, sono condivisibili: non soltanto perché, come afferma il Giudice amministrativo, la tesi sostenuta dall’orientamento prevalente – la quale condiziona la rinnovazione provvedimentale alla volontà dell’Amministrazione di determinarsi in questo senso (in disparte, dunque, i casi in cui ritenga di limitarsi a dare mera esecuzione all’ordinanza propulsiva) - sembra maggiormente in linea con la natura strumentale e transitoria delle misure cautelari, parendo, dunque, tale soluzione, la sola compatibile con la struttura dogmatica delle ordinanze cautelari, le quali non dovrebbero poter assumere sostanza di sentenza definitoria del giudizio; ma anche perché, inserendosi nel flusso dialogico tra giurisdizione e amministrazione, di cui si è detto retro, le ordinanze di remand non frustrano la discrezionalità dell’Amministrazione che valuterà se determinarsi in via di mera esecuzione dell’ordinanza propulsiva, ovvero se adottare, a valle, un nuovo provvedimento sostitutivo che sottenda, a monte, una rinnovata ponderazione degli interessi coinvolti nella vicenda amministrativa al suo esame.
[i] G. SANTUCCI, Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Emilio Betti e quel senso di autoresponsabilità, che i romani mostrano così vivo,Bologna, 2024, 71.
[ii] A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2021, 291.
[iii] Cons. St., sez. V, sent. n. 2708 del 27.05.2014.
[iv] Corte cost., sent. n. 190/1985.
[v] Corte giust. UE, sentt. 19.06.1990, C-213/89 (Factortame) e 09.11.1995, C-465/93 (Atlanta).
[vi] F. CARINGELLA, A. E. BASILICO, I principi di diritto amministrativo, Napoli, 2024, 14-15.
[vii] A. POLICE, Lezioni sul processo amministrativo, Napoli, 2023, 213.
[viii] Cons. St., sez. V, ord. 27.09.2011 n. 4253.
[ix] A. POLICE, Ibid., 214.
[x] M. CLARICH, Manuale di giustizia amministrativa, Bologna, 2021, 223-224.
[xi] Cons. St., sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 651.
[xii] F. CARINGELLA, M. GIUSTINIANI, Manuale del processo amministrativo, Cercola, 2023, 483.
[xiii] Cons. St., sez. V, sent. n. 833 del 19.02.2007.
[xiv] Cons. St., sez. VI, sent. n. 5662 del 2023.
[xv] Cons. reg. sic., dec. n. 38 del 27.01.2024.
[xvi] TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. n. 888/2024.
[xvii] A. CARBONE, Potere e situazioni soggettive nel diritto amministrativo, II-1, La situazione giuridica a rilievo sostanziale quale oggetto del processo amministrativo, Torino, 2022, 212-213.

