Pubbl. Mer, 19 Mar 2025
Maternità surrogata. Riflessioni sulle condizioni legittime per accedere alla genitorialità
Valeria Ferro
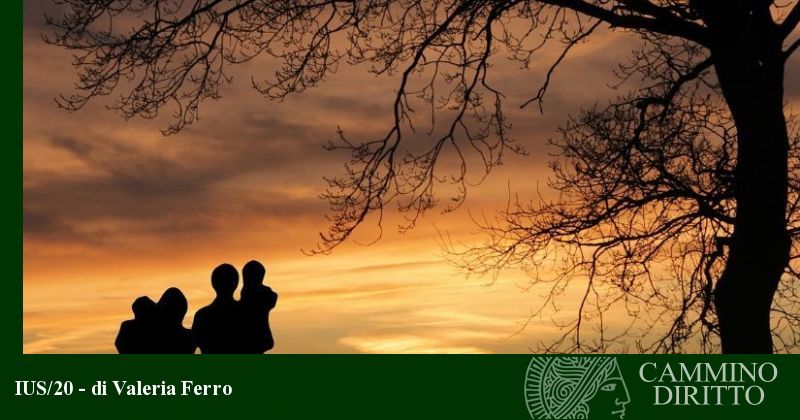
Nel contesto contemporaneo, in cui il dibattito sulla maternità surrogata è frequentemente inquadrato come una questione di diritto penale universale, è fondamentale sottolineare con fermezza che tale pratica non dovrebbe essere trattata esclusivamente come una questione politica, ma, prima di tutto, come un problema etico di rilevante importanza. Ridurre questa tematica a una mera contrapposizione ideologica o a un confronto legislativo rischia di distogliere l´attenzione dalle implicazioni morali che essa comporta, in particolare dalle profonde ripercussioni sulla dignità e sull'autonomia delle donne, sul benessere psicofisico dei bambini e sui principi di giustizia sociale che devono orientare ogni decisione normativa e bioetica.
19/03/2025
Sofia Greco|sofiagreco8@gmail.com Valeria Ferro|ferrovaleria@libero.it Nel contesto contemporaneo, in cui il dibattito sulla maternità surrogata è frequentemente inquadrato come una questione di diritto penale universale, è fondamentale sottolineare con fermezza che tale pratica non dovrebbe essere trattata esclusivamente come una questione politica, ma, prima di tutto, come un problema etico di rilevante importanza. Ridurre questa tematica a una mera contrapposizione ideologica o a un confronto legislativo rischia di distogliere l´attenzione dalle implicazioni morali che essa comporta, in particolare dalle profonde ripercussioni sulla dignità e sull'autonomia delle donne, sul benessere psicofisico dei bambini e sui principi di giustizia sociale che devono orientare ogni decisione normativa e bioetica. In the contemporary context, where the debate on surrogacy is frequently framed as a matter of universal criminal law, it is essential to assert with conviction that this practice should not be treated solely as a political issue, but, first and foremost, as an ethical concern of significant importance. Reducing this issue to a mere ideological confrontation or a legislative debate risks diverting attention from the moral implications it entails, particularly the profound impact it has on the dignity and autonomy of women, the physical and psychological well-being of children, and the principles of social justice that must guide every normative and bioethical decision.
Sommario: 1. Premessa; 2. La maternità surrogata: definizioni e tipologie; 3. Le implicazioni etiche della maternità surrogata; 4. La posizione giuridica italiana attuale; 5. Il diritto alla genitorialità: estensione e limiti giuridici; 6. Conclusioni: riflessioni finali.
Allora il re ordinò: “Prendetemi una spada!”. Portarono una spada alla presenza del re.
Quindi il re aggiunse: “Tagliate in due il figlio vivo e datene una metà all’una e una metà all’altra”.
La madre del bimbo vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: “Signore, date a lei il bambino vivo; non uccidetelo affatto!”.
L’altra disse: “Non sia né mio né tuo; dividetelo in due!”.
Presa la parola, il re disse: “Date alla prima il bambino vivo; non uccidetelo. Quella è sua madre”.
(La Sacra Bibbia Capitolo 1 RE 3,16-28)
Nel celebre passo biblico di Re Salomone (1 Re 3,16-28), il gesto della madre naturale, che preferisce cedere il suo diritto di maternità pur di salvare la vita del figlio, si erge come simbolo di un amore profondo e incondizionato.
Oggi, di fronte alla maternità surrogata, ci troviamo a confrontarci con due prospettive che sollevano interrogativi profondi sulla natura della genitorialità e sulla tutela dei soggetti coinvolti.
Da un lato, la madre surrogata: colei che, pur non avendo un legame genetico con il bambino, attraversa comunque il processo fisico e psicologico della gravidanza.
Qual è il prezzo emotivo di portare in grembo una vita per poi separarsene definitivamente? Può una donna accettare pienamente questa separazione senza conseguenze sul proprio equilibrio psicologico? La gestazione non implica forse un legame che va oltre la mera funzione biologica, un vincolo affettivo che potrebbe lasciare tracce indelebili nel suo vissuto? Ignorare questo aspetto non rischia di ridurre la madre surrogata a un mezzo, privandola di un riconoscimento pieno della sua esperienza e dei suoi diritti?
Dall’altro lato, vi sono i genitori intenzionali, coloro che, privi della possibilità biologica di concepire, vedono nella maternità surrogata una via per realizzare il proprio diritto alla genitorialità.
Non si tratta, forse, di una forma di aspirazione legittima, espressione del desiderio di dare amore e accudimento a un figlio? Se la maternità surrogata è frutto di un consenso informato e consapevole, non dovrebbe essere considerata un’opportunità per superare le barriere imposte dalla natura o dalle circostanze personali? E se il legame genitoriale non fosse solo una questione biologica, ma anche e soprattutto una scelta, un atto d’amore che prescinde dalla gestazione?
Queste due prospettive si scontrano e si intrecciano in un dibattito che non può risolversi in una visione unilaterale. La maternità surrogata impone un ripensamento profondo del significato di essere madre e genitori, chiedendoci di trovare un equilibrio tra diritti, dignità e responsabilità.
1. Premessa
Nel contesto contemporaneo, il dibattito sulla maternità surrogata è spesso inquadrato come una questione di diritto penale universale o come un tema di scontro politico e ideologico. Tuttavia, una riflessione approfondita impone di considerarla innanzitutto come una problematica etica e sociale di grande complessità, che coinvolge molteplici attori e interessi contrapposti. Limitare la discussione a un confronto normativo o a una rigida dicotomia tra divieto e liberalizzazione rischia di ridurre la portata di un tema che tocca dimensioni fondamentali come la dignità e l'autonomia delle donne, il benessere psicofisico dei bambini e i principi di equità e giustizia sociale.
Da un lato, la maternità surrogata è considerata da alcuni come un'opportunità per consentire l'accesso alla genitorialità a coloro che, per ragioni biologiche o personali, non possono avere figli. Secondo questa prospettiva, il ricorso alla gestazione per altri potrebbe essere legittimato se regolato da un quadro giuridico chiaro che garantisca il rispetto dei diritti delle parti coinvolte, evitando forme di sfruttamento. In quest'ottica, alcuni modelli legislativi adottati in diversi paesi cercano di bilanciare i diritti dei genitori intenzionali con la tutela della madre surrogata e del nascituro, introducendo criteri rigorosi per prevenire abusi e coercizioni.
Dall'altro lato, esistono preoccupazioni significative legate al rischio di mercificazione del corpo femminile e alla possibilità che le dinamiche economiche e sociali trasformino questa pratica un'espressione di disuguaglianza piuttosto che di autodeterminazione. Il dibattito si concentra dunque sulla distinzione tra una libera scelta consapevole e il condizionamento derivante da difficoltà economiche o pressioni culturali. Inoltre, si sollevano interrogativi sul rapporto tra la madre gestazionale e il bambino, e sugli effetti psicologici che la separazione potrebbe avere su entrambi.
Alla luce di queste considerazioni, appare evidente che il dibattito sulla maternità surrogata non possa essere ridotto a una contrapposizione netta tra proibizionismo e liberalizzazione, ma debba essere affrontato attraverso un'analisi multidisciplinare che consideri gli aspetti giuridici, etici, sociali e scientifici. Un approccio equilibrato dovrebbe basarsi su una regolamentazione che garantisca la protezione dei diritti umani fondamentali, tuteli le parti coinvolte e sia coerente con i principi di solidarietà e giustizia sociale.
2. La maternità surrogata: definizioni e tipologie
La maternità surrogata è una pratica in cui una donna, chiamata madre surrogata, porta avanti una gravidanza con l'intenzione di consegnare il bambino a una coppia o a un individuo, noti come genitori commissionari, che per vari motivi non sono in grado di concepire o portare avanti una gravidanza. Questa pratica può avvenire attraverso diversi approcci, ma i due principali tipi di maternità surrogata sono la surrogata tradizionale e la surrogata gestazionale.
Nel caso della maternità surrogata tradizionale, la madre surrogata fornisce il proprio ovulo, quindi è biologicamente correlata al bambino che porterà avanti. Questo implica una fecondazione in vitro (FIV) utilizzando lo sperma del padre commissionario o di un donatore di sperma. La madre surrogata diventa, quindi, sia la portatrice che la madre biologica del bambino.
Nell'ipotesi, invece, della maternità surrogata gestazionale, la madre surrogata non contribuisce geneticamente al bambino. Invece, vengono utilizzati gli ovuli della madre commissionaria o di un donatore e lo sperma del padre commissionario o di un donatore per la fecondazione in vitro. Una volta che l'embrione è stato creato, viene impiantato nell'utero della madre surrogata, che funge solo da portatrice. In questo caso, la madre surrogata non è biologicamente correlata al bambino che sta portando avanti.
La maternità surrogata è vietata per legge in Italia, ma alcune coppie italiane si rivolgono comunque a Paesi dove la surrogazione è legale, come gli Stati Uniti, il Canada e alcuni Paesi dell'Europa orientale (come la Georgia e l'Ucraina), per avvalersi di questa pratica. Questo fenomeno ha dato origine a un certo numero di viaggi per la maternità surrogata da parte di cittadini italiani, sebbene il ricorso alla surrogazione all'estero comporti problematiche legali, specialmente riguardo al riconoscimento giuridico dei genitori e ai diritti del bambino.
In Italia, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha dichiaratamente condannato questa pratica in modo definitivo, quanto meno con riferimento alla maternità surrogata compiuta dietro corrispettivo. Con la mozione intitolata Maternità surrogata a titolo oneroso, datata 18 Marzo 2016, ha ricordato che «il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto» e che «la maternità surrogata è un contratto lesivo della dignità della donna e del figlio sottoposto come un oggetto a un atto di cessione». Il CNB, infatti, ritiene che questa ipotesi di «commercializzazione e di sfruttamento del corpo della donna nelle sue capacità riproduttive», indipendentemente dalla forma del pagamento, sia in «netto contrasto con i principi bioetici fondamentali» che il Comitato ha fatto propri.
3. Le implicazioni etiche della maternità surrogata
Le questioni etiche associate alla maternità surrogata coinvolgono principi fondamentali come l'autonomia individuale, la dignità umana e il rischio di sfruttamento. Da un lato, vi è chi sostiene che le donne che scelgono di diventare madri surrogate esercitino un diritto legittimo all'autodeterminazione. Dall'altro, sorgono preoccupazioni relative alla possibilità che fattori economici, sociali o pressioni esterne influenzino tale scelta, limitandone la piena libertà.
Oltre all'autonomia della madre surrogata, il dibattito etico si estende al benessere del neonato, in particolare agli effetti che la separazione dalla madre biologica potrebbe avere sullo sviluppo della sua identità e delle sue relazioni affettive future. La complessità del tema richiede, quindi, una riflessione approfondita che consideri i diritti e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, nonché le implicazioni psicologiche e sociali della pratica.
Un aspetto centrale riguarda il rischio di sfruttamento, che si manifesta sotto diversi profili. In primo luogo, vi è la questione dello sfruttamento economico delle donne coinvolte nella maternità surrogata, soprattutto quando la decisione è motivata da necessità finanziarie. In alcuni contesti, il compenso ricevuto potrebbe risultare inadeguato rispetto ai rischi fisici, psicologici e sociali associati alla gravidanza, e i contratti stipulati potrebbero non offrire tutele sufficienti per la loro salute e i loro diritti.
Le disuguaglianze socio-economiche rappresentano un fattore rilevante: le donne in situazioni di difficoltà economica potrebbero essere maggiormente esposte a pressioni che le inducono a scegliere la maternità surrogata come mezzo per migliorare la propria condizione finanziaria. Ciò solleva interrogativi sulla reale libertà della loro scelta. Inoltre, le pressioni sociali e culturali possono influenzare la decisione, portando alcune donne ad accettare tale ruolo senza una piena consapevolezza delle implicazioni fisiche, psicologiche e legali.
Un ulteriore elemento critico riguarda la necessità di normative chiare e di adeguate tutele legali per le madri surrogate. L'assenza di una regolamentazione rigorosa può esporle a vulnerabilità significative, tra cui il rischio di complicazioni mediche mal gestite, la mancanza di supporto psicologico durante e dopo la gravidanza e una tutela insufficiente del loro benessere a lungo termine.
Per affrontare le sfide etiche della maternità surrogata, è fondamentale considerare anche le implicazioni psicologiche per la madre surrogata, garantendo l'accesso a supporti adeguati per accompagnarla nel processo di separazione e adattamento post-gravidanza. La protezione del suo benessere psicologico e il rispetto delle sue esperienze emotive sono essenziali per ridurre il rischio di sfruttamento e assicurare che la maternità surrogata avvenga nel rispetto dei principi etici fondamentali.
4. La posizione giuridica italiana attuale
Di recente, è stata approvata in Senato una Legge che interviene sulla perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da un cittadino italiano.
Viene introdotto un nuovo periodo al termine del comma 6 dell'articolo 12 della Legge n. 40/2004, al fine di estendere la giurisdizione italiana alle azioni compiute da cittadini italiani, connesse al reato di maternità surrogata, anche se commesse al di fuori del territorio nazionale.
«Con il disegno di legge sulla maternità surrogata, una pratica che viola i diritti dei bambini così come quelli delle donne, noi diciamo no al business della genitorialità e alla mercificazione del corpo della donna. Rispettiamo le visioni di tutti ma, secondo noi, il diritto di un bambino è di avere una famiglia, che sia composta da un padre e da una madre. Questo è il valore che appartiene alla nostra storia e alla nostra identità politica. È pura follia concepire i bambini come se fossero prodotti da acquistare», ha dichiarato il senatore e presidente dell'Udc, Antonio De Poli.
Sebbene il tema della maternità surrogata sollevi importanti interrogativi etici e giuridici, il dibattito dovrebbe concentrarsi maggiormente su un'analisi delle implicazioni di queste pratiche per le donne che scelgono di 'affittare' l'utero, nonché sulle difficoltà e vulnerabilità ad esse associate.
Infatti, ancorché l'intervento del senatore evidenzi le problematiche relative alla mercificazione della genitorialità e del corpo della donna, risulta altresì essenziale interrogarsi sui reali effetti di tali pratiche sulle madri surrogate, le quali spesso si trovano ad affrontare situazioni di potenziale sfruttamento e disuguaglianza. È necessario prendere in considerazione le condizioni economiche, sociali e psicologiche di queste donne che non di rado si vedono costrette, in virtù di circostanze particolarmente difficili, a intraprendere questa strada.
Inoltre, sebbene la visione della famiglia tradizionale rappresenti un valore significativo per alcune correnti culturali e politiche, è importante riconoscere che la realtà familiare contemporanea è plurale e diversificata. Piuttosto che focalizzarsi esclusivamente sulla struttura ideale della famiglia, l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di garantire a ogni bambino, indipendentemente dal contesto in cui nasce, il diritto di crescere in un ambiente sano, affettuoso e stabile.
Invero, il diritto alla procreazione può essere interpretato attraverso il prisma della libertà riproduttiva, un principio riconosciuto in numerose costituzioni e trattati internazionali, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (articolo 16) e la Convenzione sui diritti del bambino (articolo 7). Tali documenti sanciscono il diritto di ogni individuo, o coppia, di decidere liberamente se e quando avere figli, senza interferenze arbitrarie da parte dello Stato.
Questo diritto implica, in linea di principio, che ciascuna persona abbia la libertà di esercitare la propria capacità riproduttiva secondo le proprie scelte, sia attraverso la concezione naturale che mediante l'utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Tuttavia, è fondamentale sottolineare che tale diritto non si traduce in un diritto assoluto alla genitorialità, né implica che ogni desiderio di procreare debba necessariamente trovare realizzazione. Al contrario, il diritto alla procreazione deve essere bilanciato con altre considerazioni etiche, legali e sociali, che possono limitare l'accesso a determinati metodi riproduttivi.
V’è di più. Il divieto assoluto imposto dall'ordinamento nazionale potrebbe indurre coloro che desiderano ricorrere a tale pratica a rivolgersi a un mercato parallelo, al di fuori dei canali legali e regolamentati. Tale fenomeno, oltre a sollevare complesse questioni etiche e giuridiche, apre il dibattito sulla possibile esistenza di una dimensione clandestina della surrogazione di maternità, con tutte le problematiche che ne derivano.
Il ricorso a circuiti alternativi e privi di adeguati controlli normativi potrebbe esporre le parti coinvolte a situazioni di vulnerabilità e sfruttamento, aggravando le criticità già insite in una materia di per sé complessa. Oltre al fatto che, come accennato, il fenomeno si intreccia inevitabilmente con la problematica del riconoscimento legale dei minori nati attraverso la surrogazione, specialmente quando la procedura avviene all'estero. In questo contesto, il diritto internazionale privato si trova a dover gestire una situazione già difficilmente armonizzabile tra diversi ordinamenti, ulteriormente complicata dalla possibilità che la pratica venga eseguita in modo informale o privo di tutele giuridiche adeguate.
In effetti, l’assenza di una regolamentazione uniforme e il divieto assoluto pongono interrogativi sulla necessità di valutare un approccio normativo che, pur mantenendo le tutele etiche e giuridiche necessarie, possa contrastare i rischi derivanti dalla clandestinità e garantire una maggiore protezione dei soggetti coinvolti.
5. Il diritto alla genitorialità: estensione e limiti giuridici
Il diritto alla genitorialità è un tema di rilievo nel panorama giuridico italiano, trovando tutela nella Costituzione, in particolare negli articoli 2, 29 e 30, che proteggono la famiglia e il diritto di ogni individuo di formarne una. Tuttavia, questo diritto si inserisce in un quadro normativo che prevede specifiche limitazioni, come stabilito dalla legge 40/2004 sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Tale normativa consente l'accesso alle tecniche di PMA esclusivamente alle coppie di sesso diverso, sposate o conviventi stabilmente, escludendo altre configurazioni familiari, tra cui le coppie dello stesso sesso.
Questa impostazione legislativa solleva interrogativi su quali criteri debbano orientare l'accesso alla genitorialità assistita. Alcuni sostengono che la regolamentazione vigente garantisca la tutela del minore e rispetti una concezione consolidata della famiglia, mentre altri ritengono che escludere determinate categorie di individui o coppie possa costituire una restrizione ingiustificata e discriminatoria. Il dibattito ruota attorno alla domanda se il diritto alla genitorialità debba essere condizionato da fattori quali l'orientamento sessuale o lo stato civile, o se debba essere garantito a chiunque possa assicurare il benessere del bambino.
Le istituzioni giuridiche hanno più volte affrontato la questione. La Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno sollevato dubbi sulla compatibilità di tali limitazioni con i principi costituzionali e i diritti umani fondamentali, evidenziando la necessità di bilanciare i diritti individuali con l'interesse superiore del minore. Tuttavia, la normativa vigente continua a riflettere un'impostazione restrittiva del diritto alla genitorialità, suscitando un dibattito che coinvolge aspetti giuridici, etici e sociali legati all'evoluzione delle strutture familiari.
6. Conclusioni: riflessioni finali
La questione della maternità surrogata si inserisce nel più ampio dibattito sul diritto alla genitorialità, poiché coinvolge direttamente le modalità con cui tale diritto può essere esercitato, nonché le implicazioni legali, etiche e sociali legate alla filiazione.
Il dibattito non si concentra unicamente sulla legittimità giuridica della maternità surrogata, ma anche sulla sua compatibilità con i principi di dignità, autonomia e tutela dei soggetti coinvolti. Da un lato, vi è chi ritiene che tale pratica possa offrire un'opportunità a coppie o individui impossibilitati a procreare, garantendo il diritto alla genitorialità in un quadro regolamentato e rispettoso. Dall'altro, emergono preoccupazioni legate al rischio di sfruttamento delle donne e alle possibili implicazioni per il nascituro, in particolare rispetto alla sua identità e al contesto affettivo in cui cresce.
Ridurre la maternità surrogata a una mera questione economica o giuridica rischia di semplificare un fenomeno che solleva questioni di ampio respiro, tra cui il bilanciamento tra desiderio di genitorialità, tutela delle donne coinvolte e il diritto del minore a una nascita in condizioni di piena protezione. Alcuni sostengono che la regolamentazione possa offrire garanzie adeguate per evitare abusi e mercificazioni, mentre altri ritengono che qualsiasi forma di compensazione economica possa trasformare la gestazione per altri in una pratica di sfruttamento.
Il dibattito si sviluppa anche rispetto ai limiti dei diritti individuali. Così come diritti fondamentali quali la libertà personale o la proprietà trovano limitazioni in funzione di altri principi, anche il diritto alla genitorialità viene regolato alla luce di considerazioni etiche e sociali. In questo contesto, si pone la questione di quali siano i criteri che dovrebbero guidare le scelte legislative: se garantire un accesso più ampio alla maternità surrogata, regolamentandola in modo rigoroso, o se vietarla per prevenire possibili abusi.
Un altro punto di riflessione riguarda la gestione delle eventuali complicazioni che possono sorgere durante il percorso della maternità surrogata. Ad esempio, in alcuni ordinamenti si sono verificati casi in cui il nascituro presentava condizioni di salute non previste, sollevando interrogativi sulla responsabilità e sulla tutela dei diritti del bambino e della madre surrogata. Questi scenari pongono questioni complesse, che richiedono un approccio equilibrato tra diritti e doveri delle parti coinvolte.
L'eventuale regolamentazione della maternità surrogata potrebbe includere criteri volti a ridurre i rischi per le donne che scelgono di portare avanti una gravidanza per altri. Alcuni modelli legislativi suggeriscono che limitare l'accesso alla surrogacy alle donne che abbiano già avuto figli potrebbe contribuire a mitigare l'impatto emotivo del distacco post-parto. Tuttavia, questa restrizione solleva interrogativi sulla libertà individuale e sulla diversità delle esperienze personali.
Per giungere a una posizione equilibrata, potrebbe essere utile analizzare le normative adottate in altri paesi, al fine di individuare soluzioni che garantiscano il benessere delle madri surrogate, dei genitori intenzionali e dei bambini nati attraverso questa pratica. L'introduzione di protocolli specifici, tra cui il supporto psicologico obbligatorio, la tutela legale e la garanzia di compensi adeguati, potrebbe rappresentare un compromesso tra il riconoscimento del diritto alla genitorialità e la necessità di prevenire forme di sfruttamento.
In definitiva, la maternità surrogata rappresenta un tema complesso, che richiede un confronto approfondito tra le diverse prospettive coinvolte. Al di là delle posizioni ideologiche, è fondamentale interrogarsi sulle implicazioni etiche, sociali e giuridiche di questa pratica, garantendo un equilibrio tra i diritti dei soggetti coinvolti e i principi fondamentali del nostro ordinamento.
M. COSSIO, La maternità surrogata: Tra bioetica, diritto e libertà, 2019
M. LA TORRE, Bioetica, diritto e società. Le sfide della maternità surrogata, 2020
M. MAZZARELLA, La maternità surrogata tra bioetica e diritto: una riflessione critica, 2020
D. VITIELLO, La maternità surrogata e la normativa italiana: tra divieto e regolamentazione, 2021
D. FUSARO, l diritto alla genitorialità e le sue implicazioni giuridiche nelle società contemporanee, 2021

