Pubbl. Mer, 12 Lug 2023
Il testimone assistito: interventi della Corte Costituzionale, ambito soggettivo e status del dichiarante
Modifica pagina
Raffaele Granata
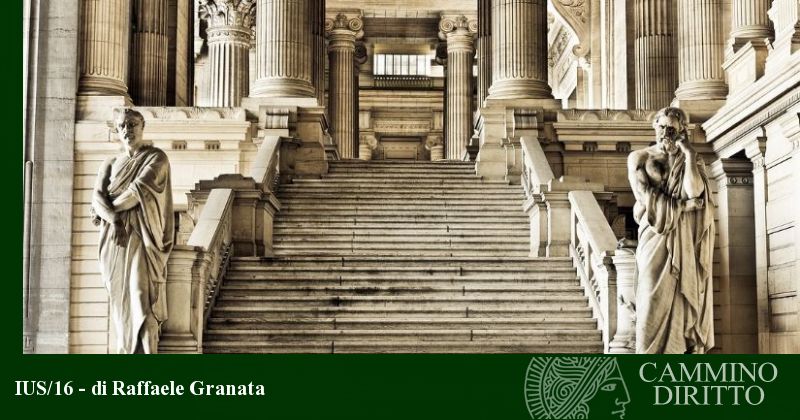
L´elaborato si propone di descrivere la figura del testimone assistito, disciplinata dall´art. 197 bis c.p.p. Trattasi di un ibrido a metà tra il testimone ordinario e l´imputato nel procedimento connesso o collegato. Il legislatore ha introdotto detta figura in ragione del possibile apporto conoscitivo che la persona è in grado di fornire, assicurando al contempo una serie di garanzie volte ad evitare che dalle dichiarazioni rese nel procedimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli. L´elaborato si propone di distinguere, all´interno della categoria della testimonianza assistita, le figure soggettive intermedie, il cui status e le cui garanzie si allargano o si restringono a seconda dello status processuale in cui versa il dichiarante.
 ENG
ENG
The protected witness. Interventions of the Constitutional Court, subjective sphere and status of the declarant
The paper aims to describe the figure of the assisted witness, governed by art. 197 bis c.p.p. It is a hybrid halfway between the ordinary witness and the defendant in the connected proceeding. The lawmaker has introduced this figure due to the possible cognitive contribution that the person is able to provide, while ensuring a series of guarantees aimed at avoiding that detrimental consequences may arise from the statements made in the proceeding. The paper aims to distinguish, within the category of assisted testimony, the intermediate subjective figures, whose status and whose guarantees widen or narrow according to the procedural status of the declarant.Sommario. 1. Introduzione dell’istituto; 2. Gli interventi della Corte Costituzionale: le sentenze n. 381/2006 e 21/2017; 3. Ambito soggettivo e status del dichiarante; 3.1. Il testimone – soggetto “garantito”; 3.2. Il testimone – imputato “giudicato”; 3.3. Il testimone – imputato “non giudicato” e la portata dell’avviso ex art. 64 co. 3 lett. c) c.p.p.; 3.4 Il testimone – soggetto “archiviato” e il testimone prosciolto con sentenza di non luogo a procedere; 3.5 Il testimone – soggetto “indagato”; 4. Conclusioni.
1. Introduzione dell'istituto
L’art. 6 della legge n. 63/2001 ha delineato la figura del testimone “assistito”. La testimonianza assistita non è un mezzo di prova ulteriore e distinto da quelli già previsto dall’ordinamento processuale, bensì una species appartenente al genus della prova testimoniale. La disciplina prevedeva che gli imputati nel procedimento penale chiamati a deporre nel procedimento connesso o per reato collegato, in luogo della veste di testimone comune come accadeva in passato, dovessero assumere quella di “testimoni assistiti”, assoggettati alla speciale disciplina disposta dall’articolo 197 bis c.p.p., formulato così come riportato di seguito.
1. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
2. L’imputato in un procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell’articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall’articolo 64, comma 3, lettera c).
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l’ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all’articolo 192, comma 3.
Tale disposizione venne introdotta, non a caso, contestualmente con la riduzione del perimetro applicativo della incompatibilità a testimoniare ex art. 197 c.p.p. Il legislatore volle inserire una disciplina che garantisse una adeguata tutela per le persone in relazione alle quali si prospettava un “inedito obbligo di verità”[1]. Le due norme erano di fatto speculari: da un lato il rinnovato art. 197 c.p.p. sanciva la compatibilità con l’ufficio di testimone di quei soggetti imputati nel procedimento connesso o collegato nei cui confronti fosse stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, condanna o patteggiamento, dall’altro l’art. 197 bis c.p.p. statuiva per le stesse persone una tutela ulteriore, tesa alla garanzia di un completo esercizio dei diritti di difesa correlati alla posizione di imputato.
Di fatto, l’innovazione consisteva nella rappresentazione di una figura a metà strada tra quella delineata dall’art. 210 c.p.p. e il testimone: come nel caso dell’esame dell’imputato nel procedimento connesso, si assicura la presenza del difensore durante l’esame e si richiede che le dichiarazioni vengano attentamente scrutinate per il tramite di elementi di riscontro; così come nella ipotesi del testimone, si prevede l’obbligo di testimoniare, dato il venir meno dell’incompatibilità, fermo restando i limiti alle domande che possono essere poste (in modo da evitare o escludere quelle che potrebbero tradursi in un’autoincriminazione in forza del principio secondo cui nemo tenetur se detegere), e con la previsione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni contra se eventualmente rese[2].
Dopo l’introduzione dell’art. 197 bis c.p.p. la Corte costituzionale venne interpellata ripetutamente al fine di estendere il perimetro applicativo della norma in esame. Il rimettente, in questa prima circostanza, chiedeva al Giudice delle leggi se il trattamento previsto per il teste assistito potesse riguardare anche i destinatari di una sentenza di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione, risultanti, secondo il testo dell’articolo, non compatibili a testimoniare dato che il provvedimento di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere non rientravano tra quelli contemplati dall’art. 197 c.p.p., in presenza dei quali l’incompatibilità poteva cadere. La Consulta, tuttavia, si limitò a dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni[3].
Sempre il Giudice delle leggi, inoltre, ebbe modo di chiarire, in occasione della rimessione effettuata dal Tribunale di Novara nel 2004 in relazione al comma sesto dell’art. 197 bis c.p.p., la disciplina creata dal legislatore con la norma in esame[4]. In questa ipotesi il giudice rimettente dubitò della legittimità costituzionale della norma suddetta in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui la disposizione impone con riguardo alle dichiarazioni dei soggetti nei cui confronti sia intervenuta una sentenza di patteggiamento irrevocabile una valutazione congiunta con i riscontri esterni.
La Corte ebbe modo di specificare come il legislatore, nella scia dell’allora recente riforma costituzionale, avesse «voluto enucleare una serie di figure di ‘dichiaranti’ nel processo penale in base ai diversi ‘stati di relazione’ rispetto ai fatti oggetto del procedimento, secondo una graduazione che, partendo dalla situazione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma ‘estrema’ di coinvolgimento, rappresentata dal concorso del dichiarante nel medesimo reato»[5]. Il coinvolgimento originario nel fatto lascia infatti residuare un margine di ‘contiguità’ rispetto al procedimento, che si riflette su peso probatorio della dichiarazione.
2. Gli interventi della Corte Costituzionale: le sentenze n. 381/2006 e 21/2017
La prima pronuncia della Corte costituzionale che ha inciso sulla lettera dell’art. 197 bis c.p.p. giunse nel 2006. La Consulta, con la sentenza n. 381/2006, si avvalse delle stesse argomentazioni utilizzate con l’ordinanza n. 265/2004, seppur con esiti completamente differenti.
La questione di legittimità avanzata dal Tribunale di Fermo ebbe ad oggetto l’art. 197 bis commi 3 e 6 del codice di rito penale, nella parte in cui prevedevano l'obbligo di assistenza difensiva e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. (i cd. “riscontri esterni”) anche alle dichiarazioni rese dalle persone indicate al comma 1 dello stesso art. 197 bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione. La Corte, nel ricostruire il substrato giuridico-normativo che aveva giustificato la rimessione da parte del giudice a quo, ritorna sull’ordinanza di cui sopra, rammentando che «l’armoniosa coesistenza tra disciplina del diritto al silenzio ed obbligo di dichiarazione nel processo è stata normativamente realizzata con l'applicazione di un principio di graduazione: principio, espresso dalla diversificazione delle figure di dichiaranti nel processo, in ragione dei diversi ‘stati di relazione’ rispetto ai fatti oggetto del procedimento. Partendo da una condizione di assoluta indifferenza propria del teste ordinario, giunge fino alla forma del totale coinvolgimento propria del concorrente nel medesimo reato»[6].
La questione venne dichiarata fondata e l’articolo venne dichiarato illegittimo nella parte in cui prevedeva l’assistenza difensiva e la necessità di riscontri esterni anche nell’ipotesi di deposizione della persona assolta per “non aver commesso il fatto” con sentenza irrevocabile. Nel motivare la propria decisione, la Corte aveva sottolineato come lo “stato di relazione” tra il fatto oggetto della ricostruzione e il dichiarante fosse del tutto eliminato dalla sentenza di proscioglimento con l’ampia formula secondo cui l’imputato “non ha commesso il fatto”. Stante l’efficacia di tale formula e la conseguente garanzia del ne bis in idem, che astrattamente lo tutela da nuove azioni penali per lo stesso fatto, l’assolto recupera la sua totale estraneità rispetto al fatto oggetto dell’addebito[7] e riacquista la capacità a testimoniare, i cui presupposti necessari risiedono nella imparzialità e terzietà rispetto ai fatti oggetto della vicenda. Per questo motivo la necessità dell’assistenza difensiva e dei riscontri determinerebbe in capo al dichiarante in precedenza assolto una perdita ingiustificata della credibilità e dell’affidabilità. Una capitis demenutio potrebbe essere motivata solo da ragioni di interesse verso i fatti di causa, interesse che viene meno con l’irrevocabilità della sentenza di proscioglimento.
La decisione della Corte costituzionale non ha mancato di sollevare critiche in dottrina. In una nota a commento della sentenza[8] il Cordì mette in discussione i presupposti di partenza del ragionamento condotto dal Giudice delle leggi. Si fa qui riferimento alla considerazione secondo cui la sentenza di proscioglimento consacra la totale estraneità al fatto dell’imputato assolto. Secondo l’autore il giudicato assolutorio non determina l’estraneità al fatto per l’imputato, con la conseguenza che non possono escludersi pregiudizi derivanti dalle sue dichiarazioni, inevitabilmente condizionate dall’obbligo di verità sancito per chiunque ricopra l’ufficio di testimone.
Questo rischio emerge nell’ipotesi in cui l’imputato viene assolto non per l’esistenza di risultanze probatorie a suo favore in grado di scagionarlo, bensì per l’assenza, la contraddittorietà o l’insufficienza di prove a suo carico e la conseguente applicazione dell’art. 533 comma 1, che impone la condanna dell’imputato solo quando questi risulta colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”. In questo caso i giudizi civili e amministrativi che vertono sugli stessi fatti oggetto del processo penale saranno inevitabilmente pregiudicati dalla testimonianza resa nel processo penale, testimonianza alla quale il soggetto de quibus non può sottrarsi vista la piena equiparazione con il testimone comune.
Tale costrizione ha generato in dottrina l’idea che il raggiungimento di una disciplina pienamente rispettosa dei princìpi garantisti potrebbe aversi mediante l’estensione della facoltà di non rispondere a domande vertenti sulla responsabilità per il fatto proprio già giudicato o sub iudice[9].
Altra ipotesi che impedisce una piena assimilazione del testimone comune con il soggetto in esame consiste nel plausibile pregiudizio derivante dall’obbligo di verità su fatti dai quali potrebbero emergere profili di responsabilità penale in ordine a procedimenti diversi da quelli che non sono si sono ancora conclusi[10]. A ciò si aggiunga che i divieti probatori che scaturiscono dal combinato disposto degli artt. 63 e 197 bis c.p.p. non paiono sufficienti a tutelare l'interesse autodifensivo del testimone assolto in via definitiva. L’assunzione del contributo di questi successivamente al giudicato di assoluzione, nell’ammettere ulteriori spunti investigativi conseguenti dalle dichiarazioni di chi è costretto a testimoniare in ordine al fatto proprio già giudicato, rende concreto e attuale il rischio di autoincriminazione in ordine a fatti nuovi.
Ulteriori perplessità derivano dalla concezione secondo cui la sentenza di assoluzione è dotata dell’effetto di dissolvere qualsiasi residuo collegamento tra la persona giudicata e il fatto oggetto della originaria imputazione. Può pacificamente affermarsi infatti che l’idea secondo cui l’assoluzione dell'imputato costituisce una dichiarazione giudiziale idonea a definire in maniera assoluta come inesistente quanto in essa accertato è un retaggio della vecchia cultura inquisitoria, dato che dà credito alla tesi secondo cui la ricostruzione fattuale del giudice ha un’affidabilità pressoché indiscutibile.
Stante l’efficacia del principio del ne bis in idem, che in nessun caso ammette di perseguire in relazione al medesimo fatto lo stesso soggetto, risulta non corretto affermare che «la sentenza di proscioglimento emessa a favore del primo imputato possa determinare un recupero della posizione di ‘terzietà’ che questa persona, divenuta ora testimone, aveva perduto»[11].
L’accertamento da cui sorge la statuizione giudiziale non produce gli stessi effetti dell'autorità della cosa giudicata. L’efficacia della sentenza dipende dunque dal contenuto della stessa: la decisione penale deve essere assistita dal pieno accertamento dei fatti solo quando il giudice intenda condannare, mentre per l'assoluzione chi si pronuncia non è tenuto ad affermare indubitabilmente l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli[12].
Per questo motivo, la sentenza di proscioglimento risulta inidonea a recidere del tutto il legame sussistente tra il soggetto non più imputato e gli interessi legati all’esito del giudizio.
Occorre specificare che con la sentenza n. 381/2006, la Corte non ha inteso porre tout court sullo stesso piano il testimone comune e l’imputato assolto con formula piena. Lasciando inalterato il testo del comma 5, che stabilisce l’inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni eventualmente rese nei procedimenti civili o amministrativi, è esclusa una totale equiparazione tra il testimone comune e il soggetto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto[13]. Per quest’ultimo l’escussione dovrà essere comunque “garantita”, stante la prevista inutilizzabilità delle sue dichiarazioni nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna o in altro giudizio civile o amministrativo.
La precisione della pronuncia del 2006 ha determinato la delimitazione del suo perimetro di efficacia solamente al soggetto assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”, lasciando fuori dal dictum l’imputato assolto con formula “il fatto non sussiste”.
La Corte costituzionale ha fugato ogni dubbio attraverso la declaratoria d’illegittimità contenuta nella sentenza n. 21/2017: la disciplina del comma 6 dell’art. 197 bis c.p.p. è stata dichiarata incompatibile con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione dei riscontri esterni anche ai soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Conseguentemente a tale pronuncia, la dichiarazione di illegittimità è stata estesa anche al comma 3 dello stesso articolo, nella parte in cui prevede l’assistenza difensiva in favore dello stesso soggetto[14]. La Consulta resta nel solco della suindicata sentenza del 2006, ritenendo che la formula “perché il fatto non sussiste” costituisce «una formula liberatoria nel merito di uguale ampiezza»[15]. Di conseguenza sarebbe stato irragionevole un trattamento diverso tra due soggetti la cui sentenza di merito, pur contenendo una diversa formula assolutoria, giunge alla medesima conclusione. Il regime della testimonianza dei soggetti assolti perché il fatto non sussiste è così parificata a quello dei soggetti assolti per non aver commesso il fatto. Sinteticamente per la Corte coloro che rientrano in tali categorie non devono essere assistiti da un difensore, né tantomeno le loro dichiarazioni necessitano di riscontri ab externo, nonostante persista l’applicazione della disciplina del comma 5.
La sentenza in esame sollevò le stesse reazioni della prima pronuncia sullo stesso tema risalente al 2006. In tal senso, autorevole dottrina rimarcò gli stessi dubbi sui presupposti di partenza e sulle conclusioni alle quali giungeva il ragionamento della Corte, ritenuti eccessivamente semplicistici.
La cosiddetta “rete di protezione”[16], vale a dire il complesso sistema di garanzie composto dall’irrevocabilità della sentenza di assoluzione, dal principio del ne bis in idem, dal divieto di revisione in peius e dalla inutilizzabilità delle dichiarazioni anche nei giudizi extrapenali sancita dall’art. 197 bis comma 5 c.p.p. messo a punto dal legislatore, nulla possono dinanzi al rischio che nel nuovo processo la responsabilità penale dell’ex imputato riemerga, divenendo oggetto di un accertamento incidentale sui generis. Pur sapendo con certezza che non potrà più essere condannato, il dichiarante sarà, anche inconsciamente, condizionato dalla «insopprimibile esigenza di proseguire nell’esercizio del diritto di autodifesa, anche dopo la formazione del giudicato assolutorio»[17].
Ancora una volta la Corte risulta essere insensibile rispetto alle problematiche già enucleate dai commenti alla sentenza del 2006: una sentenza di proscioglimento nel merito con formula ampia non può determinare la dissoluzione totale del legame intercorrente tra fatti oggetto di causa e persona assolta. Inoltre non può essere sottostimato il rischio che, una volta assolto, il soggetto proponga la stessa versione dei fatti che aveva proposto quando rivestiva nel giudizio i panni di imputato con annessa facoltà di mentire. La probabilità che entrino nel processo narrazioni mendaci, non rispondenti al vero, figlie della volontà del dichiarante di evitare di autocontraddirsi confermando quanto asserito nel precedente giudizio è elevata. È evidente che l’imporre un obbligo di verità a soggetti che dalla medesima verità potrebbero subire pregiudizio potrebbe generare risultati quantomeno fuorvianti[18].
Tali dichiarazioni potenzialmente distanti dalla verità sono determinate, il più delle volte, da considerazioni e valori extragiuridici, quali il mantenimento e la salvaguardia della reputazione e dell’onore. Non è erroneo affermare che le dichiarazioni effettuate dal soggetto precedentemente assolto siano frutto più della volontà di tutelare la propria credibilità che del rispetto delle norme che impongono il racconto della pura verità.
Tale questione venne affrontata dalla Corte di cassazione, la quale a sua volta recepì un orientamento della giurisprudenza di merito[19], e affermò che «la condotta di colui che rende falsa testimonianza, per non confessare d’aver commesso fatti costituenti reato (..), pur se già processato e assolto per quel fatto, deve ritenersi scriminata, ai sensi dell’art. 384 c.p., poiché tale disposizione si fonda sulla necessità di evitare un grave e inevitabile nocumento non solo nella libertà, ma anche nell’onore»[20].
Sul tema si è espressa anche dottrina minoritaria[21], la quale ha indicato i rischi connessi ad un’eccessiva apertura in tal senso da parte della giurisprudenza. Un’interpretazione dell’art. 384 c.p. eccessivamente ampia, risulterebbe in grado di scardinare l’obbligo di verità imposto dalle norme processuali. Tale norma tutela lo ius tacendi e costituisce un argine all’applicazione del delitto di falsa testimonianza, che non può essere indiscriminatamente applicata ai soggetti di cui all’art. 197 bis c.p.p.
Rispetto ai soggetti assolti, questi godrebbero – almeno sul piano formale – della tutela del ne bis in idem oltre che dell’inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni rese in occasione della testimonianza assistita. Ciò non toglie che essi potrebbero ricevere un danno sostanziale alla loro reputazione e nel loro onore, concetti che risultano meritevoli di tutela. Nel caso in cui questi risultino reticenti o rendessero false dichiarazioni, i soggetti assolti potrebbero invocare a loro discolpa l'art. 384 c.p.[22].
3. Ambito soggettivo e status del dichiarante
L’articolo 197 bis c.p.p. è divisibile in due parti. La prima parte è composta da due commi che individuano le categorie di soggetti suscettibili di assumere la veste di testimoni assistiti. La seconda, formata dai commi 3, 4, 5 e 6, indica le speciali previsioni applicabili all’escussione della testimonianza assistita, disciplina che deroga alle modalità ordinarie della prova testimoniale ex art. 194 c.p.p.
Dal dato positivo dell’art. 197 bis c.p.p., ed in particolare dai commi 1 e 2, è possibile estrapolare diverse categorie soggettive, con riferimento allo “stato di relazione” con i fatti oggetto di accertamento processuale. I testimoni assistiti possono essere suddivisi secondo il criterio già elaborato dalla giurisprudenza costituzionale. La sentenza n. 381/2006 e, prima ancora, l’ordinanza n. 256/2004, avevano avuto modo di esplicare il disegno che il legislatore aveva predisposto nel 2001 era finalizzato all’armonizzazione della disciplina del diritto al silenzio con l’obbligo di dichiarazione.
Le pronunce indicate differenziavano i dichiaranti a seconda dell’esistenza di un vincolo più o meno forte con i fatti di causa. Tra il testimone comune, ovverosia chi non ha (e non deve avere) alcun legame con il processo, e il concorrente nel medesimo reato, che è pienamente coinvolto dai fatti di causa, la legge n. 63/2001 ha delineato una serie di figure, denominate appunto testimoni assistiti. Ciascuno di questi è dotato di un particolare status e per ognuno valgono determinate modalità di dichiarazione e diverse valenze probatorie del dichiarato, in virtù del legame più o meno forte con il processo.
La determinazione dello status del dichiarante dipenderà da una pluralità di elementi: l’addebito formulato a suo carico e il tipo di connessione o collegamento che il pubblico ministero ritiene che intercorra tra i procedimenti interessati. Una simile determinazione è rimessa alla pubblica accusa, tenuta a stabilire sia la qualificazione giuridica da attribuire al fatto, quanto la determinazione della veste con la quale sentirlo, cioè se sentirlo come imputato connesso o collegato.
Fermo restando la discrezionalità del P.M. nella operazione di qualificazione del fatto tipico e, ancor di più, nella distinzione tra connessione e collegamento tra più soggetti, dal dato letterale può evincersi la sussistenza delle seguenti categorie dei testimoni assistiti: gli imputati in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 lettera a) o di un reato collegato ai sensi dell’art. 371 comma 2 lettera b), nei cui confronti sia intervenuta una sentenza divenuta irrevocabile (sia essa di proscioglimento, condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.); gli imputati connessi ai sensi dell’art. 12 lettera c) o collegati ai sensi dell’art. 371 comma 2 lettera b), il cui procedimento sia ancora pendente o chiuso con una sentenza non passata in giudicato. Per questi ultimi è necessario specificare che la loro compatibilità a testimoniare è limitata ai fatti in relazione ai quali abbiano reso dichiarazioni eteroaccusatorie, e subordinata all’avviso di cui all’art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p. Tale avvertimento rende edotto il propalante del fatto che da tali dichiarazioni ha origine il dovere di ricoprire l’ufficio di testimone.
In sintesi la differenza sostanziale tra gli uni e gli altri consiste nel passaggio in giudicato o meno della sentenza che definisce il giudizio. Il legislatore, nel configurare il dovere di testimoniare, ha tenuto in considerazione l’intensità del legame tra soggetti e procedimenti in cui questi sono chiamati a testimoniare.
La persona già imputata, chiamata a rendere dichiarazioni a norma dell'art. 197 c.p.p., è un testis suspectus. Il suo tasso di credibilità è affievolito in ragione del nesso logico-probatorio sussistente tra il fatto per il quale è già stata giudicata ed il fatto oggetto di accertamento nel processo in cui viene assunta la testimonianza.
Ciò non toglie che, anche riguardo ai soggetti appartenenti alla stessa categoria, quali sono i soggetti nei cui confronti sia intervenuta una sentenza irrevocabile, risulta necessario un chiarimento, anche alla luce delle elaborazioni della giurisprudenza costituzionale.
3.1 Il testimone – soggetto “garantito"
Il comma 1 dell’art. 197 bis c.p.p. statuisce che il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sia questa di proscioglimento, condanna o patteggiamento, determina la compatibilità dell’imputato con l’ufficio di testimone, seppur con le tutele e le garanzie del caso.
Come visto in precedenza, la disciplina in esame ha subìto delle modifiche da parte del Giudice delle leggi, il quale ha limitato il perimetro applicativo dell’art. 197 bis c.p.p. ad alcuni casi. L’assetto normativo, così come risulta dalle pronunce della Consulta, consente di configurare una figura intermedia tra il testimone comune e il testimone assistito.
La figura in esame è il testimone garantito[23], che coincide con il soggetto assolto nel merito con formula “per non aver commesso il fatto” o “perché il fatto non sussiste”. Il soggetto imputato assolto, secondo queste ampie formule liberatorie, non potrà godere dell’assistenza del difensore durante il suo esame e le sue dichiarazioni non dovranno essere valutate congiuntamente con elementi esterni corroboranti[24]. Ovviamente, resta necessario per il giudice valutare le dichiarazioni sulla base del canone dell’al di là di ogni dubbio, in forza del fatto che una quasi piena equiparazione tra teste comune e teste garantito non determina una variazione dei criteri valutativi del giudice.
Da un’interpretazione “a contrario” è possibile affermare che a seguito di sentenze di proscioglimento meno favorevoli, contenenti formule quali “il fatto non costituisce reato”, “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, “l’imputato non è punibile”, e dalle quali è implicito dedurre una sorta di legame tra imputato e i fatti, il testimone, una volta imputato, rientrerà a pieno titolo nella disciplina prevista dall’art. 197 bis c.p.p. Tali formule, pur avendo una piena efficacia liberatoria, sono dotate di un’ampiezza inferiore.
L’esistenza di una sorta di differenziazione tra le formule assolutorie venne per la prima volta indicata dalla Corte costituzionale stessa, la quale ebbe modo di chiarire che esiste una vera e propria “gerarchia” delle formule di proscioglimento «da determinare in considerazione dell'interesse dell'imputato a venire assolto con l'impiego di quella fra esse che risulti produttiva degli effetti per lui meno pregiudizievoli»[25].
Le formule assolutorie che determinano, per la stessa Corte, una (quasi) piena equiparazione tra testimone comune e testimone giudicato sono le più favorevoli per l’imputato dato che, rispettivamente, escludono l’esistenza di qualsiasi nesso tra l’imputato e il fatto addebitatogli, oppure affermano alla radice che il fatto penalmente rilevante non si sia verificato.
Diversamente, la sentenza di proscioglimento che contiene la formula “il fatto non costituisce reato” è applicabile quando, la verità storica del fatto e il nesso causale che lo lega alla condotta dell'imputato è accertata ma non sussiste l’elemento psicologico del reato[26].
In maniera simile, la sentenza secondo cui “il fatto non è previsto dalla legge come reato” trova applicazione nei casi in cui il fatto non corrisponde ad una fattispecie incriminatrice in ragione di un’assenza di previsione normativa, a causa di un’intervenuta abolitio criminis o per una dichiarazione integrale di incostituzionalità.
In ultimo, la formula assolutoria per cui “il reato è stato commesso da persona non imputabile” o “non punibile per un'altra ragione”, presuppone l'accertamento di un fatto costituente reato, attribuibile all'imputato[27].
In questi tre casi, non è possibile affermare che tra l’imputato e il fatto vi sia quella estraneità necessaria a consentire all’imputato stesso di partecipare alla vicenda giudiziaria senza le tutele previste dalla disciplina del teste assistito.
Ciononostante permangono vistose differenze tra la disciplina che regola l’escussione del quivis de populo e l’esame del teste garantito, alla luce del fatto che quest’ultimo gode della tutela contro la self incrimination. Le dichiarazioni rese dal teste precedentemente assolto con le formule suindicate non potranno essere utilizzate nei giudizi civili o amministrativi, aventi ad oggetto gli stessi fatti oggetto del procedimento penale chiusosi favorevolmente per il de quibus.
3.2 Il testimone – imputato “giudicato”
Il legislatore del 2001 ha ritenuto che la pronuncia di una sentenza di assoluzione, condanna o patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p. sia in grado di ripristinare quelle condizioni di terzietà e indifferenza ai fatti necessarie per ricoprire l’ufficio di testimone, nei confronti del soggetto imputato connesso o collegato. La norma, che evidentemente patisce un’eccessiva genericità, nella prassi giurisprudenziale è stata interpretata in maniera da sopperire alle lacune lasciate dal legislatore.
In giurisprudenza è emersa la questione circa l’applicabilità del comma 1 dell’art. 197 bis c.p.p. anche ai casi in cui il soggetto, tenuto a ricoprire l’ufficio di testimone, non abbia ricevuto l’avviso di tale obbligo nel caso in cui rilasci dichiarazioni eteroaccusatorie. I giudici di legittimità hanno affermato che l’irrevocabilità della sentenza determina la compatibilità del soggetto assolto, condannato o che ha patteggiato, con l’ufficio di testimonianza assistita, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia ricevuto l’avvertimento di cui all’art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p. A sostegno di questo orientamento vi sarebbe una interpretazione strettamente aderente al comma 1 dell’articolo, contenente l’espressione “sempre” la quale, nell’idea della Corte di Cassazione, non lascia adito a dubbi[28].
Nel ricordare le precedenti affermazioni della sua stessa giurisprudenza, la Corte di cassazione ha affermato che è necessario riconoscere la piena capacità a testimoniare del testimone imputato in un procedimento connesso conclusosi, a prescindere dal fatto che questi non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p., comma 2 lett. c), in quanto «l’esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il procedimento si sia già concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia dell’art. 64 cit. rimane, in questo caso, priva di funzione». Il conseguimento della compatibilità con l’ufficio di teste, seppur assistito, è automatica.
Non osta in alcun modo all’applicazione dell’art. 197 bis c.p.p. l’eventuale omissione illo tempore dell’avviso da effettuare in sede di interrogatorio se, intanto, si è giunti ad una conclusione definitiva del giudizio[29]. La giurisprudenza prevalente ha imposto l’orientamento secondo cui gli imputati “giudicati” sono muniti della capacità di testimoniare su qualsiasi fatto oggetto di prova, a prescindere dalle loro stesse dichiarazioni antecedenti[30].
L’interpretazione prospettata dalla Suprema Corte, che ha cercato di essere il più aderente possibile rispetto alla voluntas legislatoris, stabilisce che l’imputato legato da una connessione “forte” ex art. 12 comma 1 lettera a) c.p.p. resta incompatibile con la qualifica di testimone fino alla sentenza irrevocabile. Agli imputati in procedimento connesso deve essere dato solo l’avvertimento circa la facoltà di astenersi dal deporre e non anche l’ulteriore avvertimento previsto dall'articolo 64 comma 3 lettera c) c.p.p.: questi rientrano nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio di testimone per il carattere forte della connessione e non possono essere chiamati a testimoniare se non in presenza di una sentenza irrevocabile[31].
In ultimo è opportuno sottolineare la vistosa lacuna di cui il legislatore è incorso relativamente alla mancata disciplina per i soggetti che hanno visto definire la propria posizione processuale a seguito di emissione di decreto penale di condanna. Il testo dell’art. 197 bis c.p.p. infatti non indica, tra i provvedimenti in grado di determinare l’assunzione della qualifica di teste, il decreto penale di condanna. Il procedimento per decreto, che nell’affastellato mosaico di riti differenziati si presenta come quello più distante dall’archetipo ordinario[32], consente di anticipare la condanna dell’imputato, adottata de plano dal giudice per le indagini preliminari. Il contraddittorio, imprescindibile nel procedimento ordinario, è in questo caso solo eventuale e posticipato.
Questa grande distanza dai fondamentali parametri costituzionali e pattizi del processo, oltre ad aver ingenerato dubbi circa la legittimità costituzionale del rito speciale, risolti sempre negativamente, genera forti perplessità sulla efficacia dell’accertamento contenuto nel decreto. Si è sostenuto che, se il processo deve costituire un accertamento garantito, risulta prima facie complicato affermare che questo rito speciale è in grado di rispettare i parametri imposti dall’art. 111 Cost.
La Corte costituzionale[33] ha da tempo fugato i dubbi circa la compatibilità di questo rito con i princìpi del nostro ordinamento. Restano però gli interrogativi circa l’effettiva ampiezza e profondità dell’accertamento, derivanti dalla deviazione nella fase monitoria dall’ordinario metodo cognitivo e di accertamento della responsabilità[34]. Riguardo questi dubbi, dottrina autorevole ma minoritaria ha affermato che la cognizione svolta nel procedimento per decreto non è altrettanto profonda rispetto a quella esplicata in un giudizio ordinario.
Nel procedimento speciale de quo tanto la forma quanto il fine del provvedimento mirano a “liquidare gli affari minuti”[35]. In realtà sussistono numerosi elementi a favore della tesi secondo cui nel procedimento per decreto la cognizione sia piena. L’assenza totale di contraddittorio nella fase monitoria impongono un accertamento forte della responsabilità, fondato sulla ordinaria regola di accertamento propria del processo penale, condensata nella formula “oltre ogni ragionevole dubbio”.
Proprio le finalità deflattive, comportanti la necessità di limitare le opposizioni, impongono un certo rigore nell’accertamento della responsabilità nella fase monitoria, essendo verosimile che ad una cognizione imprecisa e superficiale è più probabile che segua una opposizione. Può così dedursi pacificamente che nel procedimento per decreto penale di condanna l’accertamento della responsabilità penale sia pieno anche nella fase monitoria.
A tal proposito è stato evidenziato come il decreto penale di condanna, una volta divenuto irrevocabile, sia in grado di definire la posizione processuale dell’imputato in maniera «equipollente rispetto alla sentenza di proscioglimento, condanna o patteggiamento, almeno con riferimento alla intangibilità dell’affermazione di responsabilità relativa al fatto oggetto di condanna»[36]. Tale equivalenza è desumibile dal codice. L’art. 649 c.p.p., nel porre per iscritto il divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto, considera il decreto penale di condanna al pari della sentenza come in grado di fondare un accertamento pieno. Per questo motivo, è corretto affermare che anche chi subisce una condanna nelle forme del decreto penale sarà soggetto alla disciplina dell’art. 197 bis c.p.p.
3.3 Il testimone - imputato “non giudicato” e la portata dell’avviso ex art. 64 co. 3 lett. c) c.p.p.
Quando la sentenza non ha raggiunto la condizione di irrevocabilità l’imputato non giudicato ha il dovere di testimoniare nelle ipotesi in cui sussiste la connessione ex art. 12 co. 1 lett. c) (se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri - connessione “teleologica”), oppure, ai sensi dell’art. 371 co. 2 lett. b) (reati collegati), sui fatti relativamente ai quali ha reso dichiarazioni eteroaccusatorie, sempre che abbia ricevuto l’avviso ex art. 64 comma 3 lettera c).
Nel quadro giuridico in esame l’avviso assume una funzione fondamentale, essendo in grado di trasformare la qualifica del soggetto avvertito. L’imputato titolare del diritto al silenzio ed incompatibile con l’ufficio di testimone in altro procedimento connesso o collegato diventa testimone, anche se solo relativamente ai fatti dichiarati e con tutte le garanzie del caso.
Il necessario avvertimento non evita possibili condotte abusive. Il pubblico ministero, conscio dell’omissione, potrà ripetere l’interrogatorio avendo cura di rivolgere l’avvertimento. In questo caso, le dichiarazioni erga alios oltre ad essere utilizzabili contro gli accusati, potranno determinare l’assunzione dell’ufficio di testimone da parte del dichiarante. Inoltre nulla vieta che il dichiarante che non abbia ricevuto originariamente l’avviso, una volta stabilizzatasi la sua posizione processuale, potrà effettuare tutte le dichiarazioni consentite ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p.
Dalla rubrica stessa dell’articolo in cui è situato (“Regole generali per l’interrogatorio”) si deduce l’ampia portata della norma. L’avvertimento è di fatto sempre previsto dal codice di rito ogni qualvolta ad un soggetto sia chiesto di effettuare delle dichiarazioni. Ne troviamo traccia nell’art. 350 comma 1 c.p.p., nell’ambito delle sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e con la presenza necessaria del difensore dell’indagato; nell’interrogatorio dell’arrestato o del fermato svolto dal pubblico ministero, all’articolo 388 c.p.p.; nell’interrogatorio dell’imputato, che ne faccia richiesta, nel corso dell’udienza preliminare, agli artt. 421. comma 2 e 422 comma 4 c.p.p.; nell’interrogatorio dell’imputato in procedimento connesso o collegato svolto dal pubblico ministero o dalla polizia delegata, agli artt. 363 e 370 c.p.p.
Non è stato indicato come essenziale l’avviso nella ipotesi di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria su iniziativa delle persone imputate di procedimento connesso o collegato, di cui all’articolo 351 comma 1 bis c.p.p. La convinzione è che non si tratti di una precisa volontà del legislatore escludere da questo novero i soggetti tenuti a fornire delle informazioni, ma di una svista. Sembrerebbe del tutto irragionevole che l’indagato principale, sentito dalla polizia giudiziaria a norma dell’articolo 350 comma 1 c.p.p., possa assumere la qualifica di testimone se accusa altri nel corso della prescritta attività procedimentale, mentre l’imputato connesso o collegato, sentito dalla polizia giudiziaria in un procedimento diverso dal suo, non assume alcuna responsabilità in ordine alle dichiarazioni erga alios.
L’avviso di cui all’art. 64 c.p.p. richiama l’articolo 197 c.p.p. nell’escludere che la previsione si applichi ai soggetti incompatibili a testimoniare. Dal combinato disposto delle due norme suddette può ricavarsi che gli unici soggetti che non potranno essere chiamati ad assumere la veste di testimone, neppure nel caso in cui dopo aver ricevuto l’apposito avvertimento abbiano reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità altrui, sono i coimputati e gli imputati di procedimento pendente, connesso ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera a) c.p.p. Questi conservano la qualifica di soggetti incompatibili con l’ufficio di testimone fino all’irrevocabilità della sentenza di proscioglimento condanna o applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. pronunciata nei loro confronti.
Il comma 3 bis dell’art. 64 c.p.p. prevede una duplice sanzione conseguente all’omesso avvertimento del soggetto che si appresta ad effettuare delle dichiarazioni. La prima consiste nell’inutilizzabilità soggettiva delle dichiarazioni rese. Sono infatti utilizzabili nei confronti del dichiarante ma non nei confronti dei soggetti a cui si riferivano i fatti oggetto delle dichiarazioni erga alios. La seconda determina la preclusione di escutere la testimonianza del dichiarante sui fatti concernenti l’altrui responsabilità.
Autorevole dottrina, nell’analizzare la struttura della norma, ha messo in luce le criticità del sistema edificato dal legislatore. La norma che dovrebbe descrivere la fattispecie in grado di qualificare l’imputato – teste come tale si limita ad un mero rinvio al caso previsto dall'art. 64 comma 3 lett. c). Nella norma richiamata ciò che si rinviene è la previsione di una condotta del magistrato, che ha il dovere di avvertire l’indagato circa gli effetti di un comportamento futuro, a sua volta presupposto dell’ufficio di testimone[37]. Una tale vaghezza può essere spiegata solo alla luce del fatto che il dovere dell’imputato di deporre sul fatto altrui in pendenza del proprio processo nasce da una mera esigenza probatoria che fa capo all'organo della accusa. L’appello al dovere di coerenza[38] dell’imputato che ha già effettuato in altra sede dichiarazioni indirizzate verso terzi, oltre ad essere il portato del right of confrontation, costituisce il mezzo per non disperdere quanto ottenuto in fase di indagini preliminari.
L’impianto previsto dal legislatore segue quindi la logica di garantire alle complesse ipotesi di imputato - testimone il rispetto del principio del nemo tenetur se detegere, seppur non senza prestare il fianco ad alcune inevitabili criticità.
Quando il legame intercorrente tra imputato e procedimento in cui è chiamato a deporre è meno intenso (come nella ipotesi di cui all’art. 197 bis comma 2 c.p.p.), lo stesso imputato potrà assumere la veste di testimone anche prima di una completa definizione della sua stessa vicenda processuale[39]. Tuttavia, per l’ambito dei soggetti non ancora giudicati, la disciplina del comma 2 impone alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero di effettuare l’avvertimento di cui all’art. 64 comma 3 lettera c). Ciò significa che il soggetto che durante l’interrogatorio stia rendendo delle dichiarazioni accusatorie erga alios deve essere avvertito circa il dovere di ricoprire l’ufficio di testimone riguardo quelle stesse accuse.
La norma in esame sembra rifarsi al principio condensato nel brocardo secondo cui semel loquens semper loquens: se il dichiarante la prima volta che rende delle dichiarazioni che hanno un effetto accusatorio verso altri è stato messo in condizione di sapere le conseguenze determinate dalle sue dichiarazioni in quanto tempestivamente avvertito, allora non gli sarà più consentito tornare sui suoi passi.
Giova ricordare che l’esame del teste assistito può aver luogo esclusivamente con riguardo alle dichiarazioni inerenti il fatto altrui già rese in precedenza. In ordine ad altri fatti la disciplina vigente continuerà ad essere l’incompatibilità a testimoniare di cui all’art. 197 c.p.p. comma 1 lettera a) e b), con la eventuale applicazione dell’art. 210 c.p.p., ovverosia l’esame di persona imputata in procedimento connesso.
Ciò determina un’inevitabile difficoltà nell’applicazione della complessa disciplina, formata dalle incompatibilità e dalle relative eccezioni e discipline derogatorie. In tal senso la dottrina ha parlato di testimonianza “ad intermittenza”, sottolineando come, all’interno della medesima deposizione, risulti quantomeno complicato sapere quando effettuare l’audizione del soggetto nelle vesti di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., apportando determinate garanzie, e quando ascoltare lo stesso soggetto secondo la disciplina che detta le regole per l’esame di persona in un procedimento connesso.
Questa complessità deriva dal fatto che il soggetto potrebbe, durante la stessa deposizione, dichiarare quanto affermato in sede di interrogatorio, per i quali sarà tenuto a ricoprire l’ufficio di testimone assistito, ai sensi del combinato disposto formato dalle norme di cui agli artt. 197 bis comma 2 e 64 comma 3 lettera c) c.p.p., e in un momento immediatamente successivo, senza soluzione di continuità, potrebbe dichiarare fatti che determinerebbero, in capo a chi depone, una violazione del diritto al silenzio, dato che la disciplina da applicare sarebbe quella di cui all’art. 210 c.p.p..
La situazione dell’imputato connesso teleologicamente o collegato che diviene testimone prima della sentenza irrevocabile, nonostante l’avallo ricevuto dalla Corte Costituzionale, subì numerose critiche da parte della dottrina. In letteratura, le principali voci critiche verso l’assetto predisposto dal legislatore, hanno specificato come l’avviso al dichiarante circa i doveri conseguenti alla dichiarazione etero accusatoria renda solo astrattamente liberi di scegliere se persistere nell’accusa ergo alios o meno. Nella realtà dei fatti, tale scelta è, nell’opinione della dottrina maggioritaria, “coatta” e non libera[40].
A questa conclusione si è giunti attraverso due ordini di ragionamento.
Il primo sottolinea come l’ambito in cui tali dichiarazioni eterodirette vengono rese, ossia l’interrogatorio, ne compromette inevitabilmente l’attendibilità. È risaputo che nell’interrogatorio, nonostante tutte le garanzie e le tutele predisposte dalla legge, il dichiarante si trova in un ambiente quanto meno ostile, in cui non è assicurata quasi mai la piena libertà di autodeterminarsi. La situazione psicologica che ricorre in sede di interrogatorio svolto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria non coincide quasi mai con una condizione di libertà. Come è noto, nel corso dell’interrogatorio non è raro che l'autorità inquirente metta “sotto torchio” il dichiarante, attraverso l’esercizio di un’influenza psicologica sulla persona. Sul punto è stato scritto che «la facilità con cui nei suoi confronti sono esercitabili pressioni volte ad indurne l’atteggiamento»[41]. Pertanto, quando l’obbligo testimoniale matura durante l’interrogatorio, è possibile parlare di testimonianza “coatta”[42].
Le critiche della dottrina si muovono inoltre su un altro piano. La natura coatta è dovuta al fatto che, l’assunzione della qualifica di teste, anche quando avviene in forza di dichiarazioni rese dinanzi al giudice, consegue ad una valutazione circa la “altruità” dei fatti dichiarati, effettuata da un soggetto diverso dal dichiarante. Se per “fatto proprio” si intende un accadimento che si pone rispetto al dichiarante in termini di attribuibilità soggettiva, il “fatto altrui” differisce per non essere riconducibile a chi effettua tali dichiarazioni. La distinzione è fondamentale, dato che sul fatto proprio la parte deve poter esser messa in condizione di esercitare il diritto al silenzio. La determinazione della pertinenza delle dichiarazioni alla responsabilità altrui è rimessa alla discrezionalità dell'autorità inquirente o giudicante[43], che di volta in volta deciderà di sentire l’imputato come teste assistito. Non sempre la persona interrogata è in grado di prevedere ex ante la altruità dei fatti che sta per esporre.
Da ciò deriverebbe il potenziale vulnus di libertà in capo al dichiarante, il quale potrebbe essere costretto a deporre su fatti contigui al proprio, se non addirittura coincidenti con lo stesso, violando così lo ius tacendi, prerogativa fondamentale del diritto di difesa. Il labile confine tra il fatto proprio e il fatto altrui non consente di sapere quando poter escutere l’imputato nelle vesti di teste assistito e quando no. Chi rende delle dichiarazioni potrebbe non scegliere le circostanze altrui su cui deporre, dato che questa decisione, di fatto, è assunta dall’autorità giudicante o inquirente, dotate di un amplio margine discrezionale.
Come ricordato in precedenza, la Corte costituzionale ha avallato in più occasioni l’impianto scelto dal legislatore, escludendone la illegittimità. La Consulta ha escluso l’irragionevolezza della disciplina allestita dal legislatore, dichiarando che la disciplina composta dagli artt. 197, 197 bis e 210 del codice di rito penale non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost., ma è frutto delle «scelte discrezionali, non irragionevolmente esercitate, con cui il legislatore ha individuato situazioni nelle quali il diritto al silenzio va garantito, malgrado dal suo esercizio possa conseguire l’impossibilità di formazione della prova testimoniale».
3.4 Il testimone – soggetto “archiviato” e il testimone prosciolto con sentenza di non luogo a procedere
Il legislatore, nell’individuare le categorie soggettive alle quali applicare le norme della testimonianza assistita, non ha dedicato una disciplina specifica al soggetto per il quale sia stata avanzata richiesta di archiviazione, accolta dal giudice con decreto motivato o (a seguito di opposizione della persona offesa) con ordinanza, né tantomeno ha regolato lo status del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere.
Tanto l’atto con cui è disposta l’archiviazione del procedimento quanto la sentenza di non luogo a procedere hanno una stabilità sicuramente inferiore rispetto ad una sentenza dibattimentale, specie se irrevocabile. Il legislatore avrebbe dovuto predisporre una disciplina ad hoc per il soggetto archiviato o per il quale non è stato predisposto il rinvio a giudizio, i quali si trovano in una situazione sensibilmente diversa da chi ha visto la propria posizione definirsi stabilmente o comunque in via di consolidamento.
Partendo dal dato letterale si evince che il legislatore, nelle lettere a) e b) dell’articolo in questione, ha legato l’applicabilità della norma ad una situazione di “definitività”. Le sentenze di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti sono connotate da un’intrinseca stabilità, dettata dai caratteri e dalle garanzie che la legge ha imposto nel procedimento necessario al raggiungimento di questi provvedimenti giudiziali. Tale definitività comporta il venir meno delle esigenze difensive ed in particolare della tutela del diritto al silenzio per chi è al riparo dal rischio di autoincriminazione relativamente allo stesso oggetto di accertamento, in forza di un giudicato oramai divenuto irrevocabile – e quindi definitivo – per l’operatività del principio del ne bis in idem. Il carattere definitivo dell’accertamento giudiziale implica la scomparsa degli ostacoli all’assunzione, da parte dell’imputato giudicato irrevocabilmente, dell’obbligo testimoniale penalmente sanzionato di deporre secondo verità, anche nel procedimento penale connesso o collegato ancora in pendenza.
Lo stesso non potrà dirsi del provvedimento di archiviazione o della sentenza di non luogo a procedere.
L’archiviazione è disposta in una serie di casi. In primo luogo, la principale ipotesi di archiviazione è quella prevista e disciplinata dall’art. 408 c.p.p., ossia il caso in cui la notizia di reato risulta infondata. In questo caso, l’analisi delle risultanze istruttorie consente di prevedere l’infruttuosità dell’esercizio dell’azione penale. La seconda ipotesi prevista dal codice è quella di cui all’art. 411 c.p.p.: l’assenza di una condizione di procedibilità (mancata querela; estinzione del reato per amnistia, prescrizione, oblazione). Un’ulteriore ipotesi, di recente introduzione, codificata nell’art. 131 bis c.p. consiste nel riconoscimento della particolare tenuità del fatto, data dalla modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo generato dalla condotta stessa. Chiude questa elencazione l’archiviazione prevista dall’art. 415 c.p.p., ovverosia il caso in cui risulta ignoto l’autore del reato.
Nel diritto che vive nella pratica quotidiana non è raro che l’iscrizione nel registro delle notizie di reato sia disposta al fine di adempiere ad un mero obbligo burocratico. In tali casi, l’iscrizione è seguita, in rapida successione, da un provvedimento di archiviazione.
Viste le ipotesi di archiviazione previste dal nostro ordinamento, sorge la necessità di delineare lo status in cui versa il soggetto, nel momento in cui sia chiamato a deporre nel procedimento connesso o collegato che abbia visto il proprio nome venire depennato dal registro degli indagati per effetto dell’archiviazione.
Dall’elenco delle ipotesi di archiviazione emerge che in nessun caso un eventuale decreto od ordinanza sarebbero in grado di precludere l’esercizio dell’azione penale in un momento successivo. Non è da escludere, ad esempio, che la notizia di reato, in un secondo momento risulti fondata dato il rinvenimento di nuovi elementi probatori, astrattamente in grado di sostenere l’esercizio dell’azione penale. Così come è ammissibile che l’autore del reato venga successivamente identificato o che la condizione di procedibilità che originariamente non sussisteva venga posta in essere, come nel caso dei reati procedibili a querela. Per questo, è ammessa, ai sensi dell’art. 414 c.p.p., la possibilità che il p.m. richieda la riapertura delle indagini.
La legge predispone un controllo giurisdizionale successivo alla richiesta di riapertura delle indagini, che sarà giustificata solo da un quid novis per giustificare l’autorizzazione del giudice, ma la sola possibilità che chi una volta aveva visto il proprio procedimento “archiviato” possa essere in un secondo momento accusato di un reato, evidenzia come l’archiviazione non goda del carattere di definitività di cui godono i provvedimenti giudiziali di cui all’art. 197 bis alle lettere a) e b) del c.p.p.
In senso analogo si pone la sentenza di non luogo a procedere, la quale non può avere la stessa efficacia o attitudine al giudicato che attribuiamo alle sentenze definitive. La sentenza emessa al termine dell’udienza preliminare da parte del G.u.p. si fonda, tra le altre cose, sul fatto che l’azione penale non è giustificata dagli elementi acquisiti fino a quel momento, in forza della loro contraddittorietà o della inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio. Il giudice chiamato a valutare le condizioni per l’esercizio dell’azione penale, dovrà considerare, oltre alle condizioni elencate dall’art. 425 comma 1 c.p.p., le ragioni che riguardano la consistenza probatoria degli elementi raccolti fino a quel momento dal pubblico ministero. Anche in questo caso, il provvedimento giudiziale è contraddistinto da una sorta di precarietà.
Tale carattere è dato sia dalla possibilità di appellare la sentenza di non luogo a procedere, sia dalla revoca della medesima. Nel primo caso, qualora la Corte di Appello accolga l’impugnazione, decreta il rinvio a giudizio disponendo la formazione del dibattimento, determinando così l’effetto di far riavviare il processo. Nel secondo caso, sarà il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del p.m., a disporre la revoca della sentenza, giustificata dal sopravvenire o dalla scoperta di nuove fonti di prova che aggiungono o contribuiscono a rivalutare delle stesse il quadro probatorio già esistente.
La posizione del soggetto archiviato o prosciolto a seguito di una sentenza di non luogo a procedere è una posizione non definitiva, potenzialmente variabile e che non assicura al destinatario di tali provvedimenti giudiziali un’adeguata distanza dai fatti. Per questo motivo, l’interrogativo che giudici e dottrina hanno dovuto affrontare ha riguardato essenzialmente la qualifica soggettiva da attribuire al soggetto “archiviato” o prosciolto con sentenza di non luogo a procedere. I riscontri giurisprudenziali e dottrinali che hanno tentato di dare una risposta agli interrogativi sorti dal silenzio del legislatore sono stati diversi, se non del tutto divergenti, tanto da indurre le Sezioni Unite della Corte di cassazione a pronunciarsi per dirimere il contrasto venutosi a creare.
Le qualifiche attribuite da dottrina e giurisprudenza al soggetto “archiviato” o prosciolto in udienza preliminare sono riducibili a tre tipi: la qualifica di testimone assistito ex 197 bis c.p.p., quella di testimone comune, quella di testimone con procedimento pendente che avesse reso delle dichiarazioni a seguito degli avvisi ex art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p.[44].
Il primo orientamento della giurisprudenza di legittimità è quello che ha esteso la qualifica di teste assistito anche ai soggetti archiviati o prosciolti con formula di “non luogo a procedere”. Tale indirizzo prospettava un’interpretazione analogica della posizione dei soggetti indicati a norma dell’art. 197 bis c.p.p., equiparando agli epiloghi processuali indicati nella lettera della disposizione (qualsiasi sentenza irrevocabile) il provvedimento di archiviazione nonché quello di proscioglimento per non luogo a procedere.
La Corte di cassazione nella pronuncia in esame[45] prende spunto da un erroneo presupposto concettuale utilizzato dal Giudice territoriale nella sentenza oggetto del suo scrutinio. Si fa riferimento nello specifico alle dichiarazioni rese dai soggetti connessi o collegati, relativamente ai quali è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere. Tali soggetti risulterebbero per il Tribunale idonei allo svolgimento dell’ufficio del testimone comune, dato che risulterebbero del tutto estranei alla vicenda al pari dei soggetti assolti con formula piena. Tale equiparazione determina una palese elusione del precetto contenuto all’interno del comma 1 dell’art. 197 c.p.p. La disposizione richiamata, nel sancire l’incompatibilità a testimoniare dei soggetti imputati in procedimenti connessi da un nesso inscindibile fino a che non siano stati irrevocabilmente giudicati, determina uno stato di incompatibilità con l’ufficio di testimone anche per quelle persone che hanno visto chiudersi il proprio procedimento con un provvedimento revocabile quale, appunto, la sentenza di non luogo a procedere.
A sostegno di quanto affermato sinora vi è la suindicata sentenza della Corte Costituzionale n. 381/2006, che ha limitato le garanzie del teste assistito nelle ipotesi in cui il soggetto sia stato assolto da una sentenza recante la formula “per non aver commesso il fatto” e, cosa più importante, divenuta irrevocabile. La pronuncia della Consulta, con lo stabilire la necessarietà di un accertamento della posizione dell’imputato connesso o del coimputato così definitivo da divenire intangibile, corrobora l’interpretazione della Cassazione, secondo cui la funzione primaria dell’art. 197 bis c.p.p. è la tutela del dichiarante. Il Giudice di legittimità indica che l’esigenza di tutela del soggetto dichiarante impone l’utilizzo delle garanzie tipiche del testimone assistito, dato che la sua posizione, nell’essere definita da una sentenza revocabile, è ancora incerta. Questi verrebbe esposto all’incertezza dell’esito delle sue dichiarazioni laddove il procedimento potrebbe comunque riaprirsi. La possibilità che vi sia un ulteriore seguito alla vicenda giudiziaria costituisce un caso espressamente contemplato dall’art. 434 e seguenti c.p.p.
Ha così ragion d’essere la linea interpretativa secondo cui l’imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 c.p.p. o di reato collegato a norma dell’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza non impugnabile di non luogo a procedere, indipendentemente dalle ragioni del proscioglimento, non può essere sentito come testimone comune. L’applicazione analogica all’archiviato e al giudicato ex art. 425 c.p.p. delle norme a garanzia previste per il testimone assistito crea una sfera di protezione a presidio dei rischi di autoincriminazione e di ogni altro effetto pregiudizievole che possa scaturire dalle dichiarazioni rese.
A sostegno di questa tesi vi è la soluzione prospettata dalla dottrina, che prende spunto da un ineludibile dato testuale. L’art. 197 bis comma 4 secondo periodo c.p.p. prevede che il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o “si è proceduto” nei suoi confronti. E ciò in forza del fatto che il secondo periodo del comma 4 in esame si riferisce ai casi di procedimenti diversi da quelli di cui al comma 1, ossia a procedimenti non definiti con sentenza irrevocabile. Trattasi dei procedimenti per i quali “si è proceduto” con sentenza revocabile, visto che altrimenti si applicherebbe la garanzia del primo periodo del comma 4, che si riferisce esclusivamente ai soggetti condannati nei procedimenti in cui gli stessi non avevano reso alcuna dichiarazione o avevano negato la propria responsabilità. Così l’unico significato attribuibile alla locuzione “si è proceduto” è quello che attiene alla sentenza di non luogo a procedere. La logica conseguenza di questa lettura è l’attribuzione dello status di testimone assistito al soggetto prosciolto ai sensi dell’art. 425 c.p.p.[46].
L’uso del termine “testimone” non lascia adito a dubbi interpretativi: è necessario prendere atto che con il riferimento ad esso ed alla sentenza di non luogo a procedere il legislatore abbia inteso affermare che il dichiarante ritualmente avvisato ex art. 64 comma 3 lett. c) c.p.p., che abbia effettuato dichiarazioni contra alios e abbia profili di connessione dettati dagli artt. 12 comma 1 lettera c) o 371 comma 2 lettera b) c.p.p., dovrà essere sentito come testimone assistito ancorché la sua posizione sia stata definita con sentenza di non luogo a procedere.
Da una simile conclusione, sempre secondo quanto affermato dalla dottrina summenzionata, è possibile trarre ulteriori conseguenze attinenti al profilo del testimone soggetto “archiviato”. Il ragionamento che segue parte dal presupposto secondo cui le norme che stabiliscono garanzie e diritti di qualsiasi tipo in favore dell’imputato debbono essere applicate anche alla persona sottoposta alle indagini (art. 61 c.p.p.). Per questo motivo il soggetto nei cui confronti si applichi la disciplina della connessione ex art. 12 comma comma 1 lettera c) o art. 371 comma 1 lettera b) c.p.p., che è stato ritualmente avvisato dell’obbligo di ricoprire l’ufficio di testimone, che ha effettuato delle dichiarazioni accusatorie erga alios e che ha visto pronunciare un provvedimento di archiviazione nei suoi confronti deve essere sentito come testimone assistito. La lex specialis contenuta nell’art. 197 bis c.p.p., rispetto agli imputati con procedimento pendente, andrà così applicata anche ai soggetti de quibus, a patto che questi siano consapevoli del fatto di dover, in un secondo momento, testimoniare su fatto altrui (dato l’avvertimento ex art. 64 comma 3 lettera c) c.p.p.).
Un’altra soluzione fornita da giurisprudenza e dottrina prevede che l’ufficio di testimone assistito può essere assunto da persone indagate in procedimento connesso o collegato, anche se sia stata disposta nei loro confronti l’archiviazione, per i fatti riguardanti la responsabilità di altri, a patto che la persona sia stata avvertita ai sensi dell’art. 64 comma 3, lett. c) c.p.p., e non abbia inteso avvalersi della facoltà di non rispondere[47].
Questa interpretazione, già avanzata dai giudici della Suprema Corte nel 2007[48], sembra la più corretta, in quanto si fonda su una rigorosa interpretazione letterale delle norme che disciplinano la testimonianza assistita, nonché sulla logica dell’istituto, il quale mira ad evitare che il testimone, obbligato a dire la verità, sia costretto a rilasciare dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione processuale.
La Corte, infatti, non ritiene sussista una valida motivazione per la quale il testimone non possa ricoprire il suo ufficio, se la sua deposizione dovrebbe vertere su fatti concernenti la responsabilità penale di terzi. Non è dato motivo di credere che dalla stessa testimonianza sopraggiunga un pregiudizio per la posizione processuale del testimone. In tali casi è giusto che lo stesso soggetto sia chiamato a testimoniare, anche se esclusivamente su quei fatti oggetto delle sue dichiarazioni.
La prospettazione in esame ebbe un discreto seguito in dottrina. È stato fatto notare che non a caso il legislatore abbia “dimenticato” di indicare tra le eccezioni alla incompatibilità il provvedimento di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere. Viceversa, le predette ipotesi sono state volutamente lasciate nell’area dell’incompatibilità. Ebbene, la norma stabilisce che a tali soggetti non possono essere rivolte domande sui “fatti per i quali si procede o si è proceduto nei loro confronti”. La clausola “si è proceduto” fa riferimento a tutte le ipotesi nelle quali sia intervenuto un provvedimento in grado di porre fine al procedimento diverso dalla sentenza irrevocabile di proscioglimento, condanna o patteggiamento e che fa cadere in toto l’incompatibilità a testimoniare.
Una simile opzione interpretativa è stata anche confermata dalla giurisprudenza costituzionale. L’ordinanza n. 76 del 2003 della Consulta aveva avuto luogo a seguito della remissione da parte di un giudice che si era trovato di fronte al caso dell’imputato di detenzione di sostanze stupefacenti. La posizione di questi era stata archiviata per la destinazione della sostanza all’uso personale. Nell’impossibilità di sentire tale soggetto come testimone assistito, era stata sollevata la questione di costituzionalità, ritenendo che in questo caso il decreto di archiviazione avesse un carattere di definitività che tutelava adeguatamente il dichiarante.
La Corte supera questa argomentazione, osservando che la scelta del legislatore è stata fatta considerando il regime processuale di stabilità della sentenza irrevocabile. Il decreto di archiviazione, è, al contrario, connotato, dalla possibilità di essere superato da un semplice provvedimento di riapertura delle indagini basato sulla sopravvenienza di altri elementi, o anche su una semplice rivalutazione di quelli esistenti.
La pronuncia della Corte non si limita a specificare la ratio della norma, ma continua nella sua opera chiarificatrice. Essa sottolinea che esistono situazioni che sono ontologicamente diverse in ragione dello stato del procedimento. Secondo il Giudice delle leggi il legislatore opererebbe delle distinzioni all’interno della struttura del procedimento di archiviazione data la diversa forza di resistenza delle singole definizioni rispetto alla prospettiva di riapertura delle indagini[49], differenziando in via consequenziale le diverse figure dichiaranti, allargando e restringendo per ciascuna situazione soggettiva l’area del diritto al silenzio.
Quella accolta da una buona parte dei giudici di merito è invece una lettura decisamente più vincolata al dato formale[50]. Si predilige un’interpretazione del precetto contenuto nell’art. 197 quasi letterale, aderente al canone interpretativo secondo cui ubi lex voluit dixit: le ipotesi di incompatibilità, e quindi di testimonianza assistita, sono limitate ai tipi previsti dalla legge. Di conseguenza, i soggetti “archiviati” o prosciolti per sentenza di non luogo a procedere debbono essere considerati a tutti gli effetti come persone soggette alla disciplina della testimonianza comune.
In tal senso può risultare chiarificatrice la motivazione della sentenza resa dal Tribunale di Foggia[51] in data 8 febbraio 2002. Il giudice di merito, nel giustificare la propria decisione, afferma che l'estensione analogica del diritto al silenzio oltre i casi espressamente previsti dagli artt. 197 e 210 c.p.p. non sarebbe ammissibile in virtù dell’eccezionalità delle norme in esse contenute.
L’interpretazione dei menzionati articoli deve essere strettamente legata al significato del contenuto letterale, tale da non consentire esclusioni che si pongono eventualmente in contrasto con il testo della norma. La persona per la quale sia stata disposta l’archiviazione non può più essere definita come indagato e men che mai come imputato. Sicché non rientra nelle categorie per le quali l’art. 197 c.p.p. prevede l’incompatibilità a testimoniare.
Tale impostazione, che parrebbe quella dettata anche dal comune buon senso, non appare, allo stato, praticabile. È evidente che la questione deve essere trattata considerando anche esigenze di carattere sistemico. L’art. 197 bis c.p.p. stabilisce che garanzie e limiti probatori dalla stessa si applicano, tra gli altri, anche ai soggetti prosciolti con sentenza irrevocabile (quindi anche a quelli assolti con la formula più ampia). Confrontando le posizioni dei soggetti “protetti” dal giudicato con quelle “precarie” dell’archiviato e del destinatario di sentenza ex art. 425 c.p.p., sarebbe complicato asserire la non applicabilità a questi ultimi di garanzie attribuite a quei soggetti nei cui confronti le stesse appaiono ben meno giustificabili, data l’intangibilità della relativa posizione.
Una interpretazione più sofisticata del tema è stata data dalla stessa Corte di Cassazione[52]. Tale interpretazione, denominata in dottrina “teoria della irrevocabilità sostanziale”, presupponeva una differenziazione tra i diversi tipi di sentenza di non luogo a procedere. I giudici della Suprema Corte rimarcavano la differenza tra i casi in cui la sentenza di non luogo a procedere fosse stata pronunciata per ragioni che lasciavano presupporre la sua irrevocabilità e sentenze di proscioglimento che, al contrario, non escludevano una riapertura del procedimento a carico del prosciolto.
Il rilievo della Corte è chiaramente fondato. Essa è sicuramente consapevole del fatto che una pronuncia di non luogo a procedere non è efficace quanto un provvedimento giudiziale in grado di formare un giudicato sulla questione. Tuttavia la Corte di cassazione non manca di sottolineare la portata preclusiva di una sentenza di proscioglimento motivata dal fatto che il reato si sia estinto. Tale pronuncia è in sostanza preclusiva di un secondo giudizio, impedendo ugualmente l'esercizio dell’azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona. Tale profilo di irrevocabilità determina, almeno astrattamente, la potenziale assunzione della prova ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., con ciò che ne deriva in termini di peso probatorio delle dichiarazioni rese.
La sentenza di proscioglimento per estinzione del reato è munita di un carattere irrevocabile che la rende assimilabile ai provvedimenti di proscioglimento, condanna e applicazione della pena su richiesta delle parti. Tale carattere consente l’attribuzione della qualifica di testimone assistito al soggetto connesso o collegato che ha visto il proprio reato estinguersi.
L’indirizzo interpretativo appena illustrato sembra in grado di cogliere le differenze sussistenti tra provvedimenti, nella sostanza, tra loro molto diversi, seppur formalmente omogenei, quali possono essere le sentenze di non luogo a procedere. L’eventuale accoglimento della teoria dell’irrevocabilità sostanziale configurerebbe una incompatibilità a testimoniare “a fisarmonica”. Resta essenziale specificare però che la disciplina delineata dal legislatore non determina alcuna distinzione tra gli effetti delle stesse. Nel disegno codicistico, una sentenza di non luogo a procedere non ha attitudine al giudicato, non è in grado di stabilizzarsi definitivamente e per questo non può attribuirsi ad essa effetti di cui non è dotata. Questa, per sommi capi, è la critica avanzata all’impostazione dell’irrevocabilità sostanziale avanzata dalla Sezione Prima penale della Corte di Cassazione[53] in merito.
Pone fine al contrasto giurisprudenziale la sentenza[54] pronunciata a Sezioni Unite dalla Corte di cassazione. Le Sezioni Unite hanno rilevato, in primo luogo, come il cardine del nuovo impianto normativo sia costituito dalla tutela del sacrosanto diritto al silenzio: l’apparato di garanzie in relazione a soggetti la cui posizione processuale sia idonea a determinare esigenze difensive. È proprio sotto tale profilo che quella dell’indagato “archiviato” è stata differenziata da tutte le categorie soggettive previste dall'art. 197 c.p.p. Secondo le Sezioni unite il diritto di difesa presuppone un’accusa contenuta nell’imputazione. Questa consegue necessariamente all’esercizio dell’azione penale. Pur concedendo che anche chi è sottoposto alle indagini preliminari versa in una situazione che determina esigenze difensive, la Corte ha concluso che una volta terminate le indagini, tali esigenze vengono meno. Il provvedimento di archiviazione è definito dalla Corte come “antitetico” rispetto all’esercizio dell’azione penale, ancora di più se l’archiviazione segue, come spesso accade, ad un obbligo burocratico. Per la Corte, la riapertura costituisce una eventualità «assimilabile, e anzi probabilisticamente inferiore, a quella della possibile ‘apertura’ nei confronti di qualsiasi soggetto»[55]. A fronte di questa equiparazione[56] sarebbe sufficiente riconoscere che il destinatario del provvedimento di archiviazione merita le stesse garanzie che spettano a un qualunque testimone, ossia il privilegio contro l’autoincriminazione e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti[57]. L’esito a cui giunge la Corte è quindi quello di parificare la posizione dell’archiviato con quella del teste comune.
Tuttavia, è proprio il richiamo al principio di graduazione che presta il fianco alle critiche di questa argomentazione. L’archiviazione costituisce l’epilogo del procedimento che, rispetto agli altri, è meno in grado di spezzare il vincolo tra soggetto destinatario del provvedimento e fatti di causa. Tale debolezza intrinseca dell’archiviazione è evidenziata dalla continuazione del procedimento connesso o collegato. Da questo è probabile che emergano risultanze probatorie in grado di sorreggere l’esercizio dell’azione penale nei confronti di chi aveva visto chiudere il procedimento a suo carico, determinandone la riapertura.
In questa sentenza viene per la prima volta delineata una distinzione tra soggetto archiviato e soggetto e soggetto destinatario di una sentenza di non luogo a procedere con il corollario che per quest’ultimo ricorra invece l’applicabilità della disciplina sulla incompatibilità a testimoniare. Pur senza un particolare approfondimento sul punto la stessa pronuncia lascia desumere che la persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere rientra nell’ambito della incompatibilità a testimoniare.
Le Sezioni Unite sottolineano che la clausola “si è proceduto” prevista dall’art. 197 bis comma 4 secondo periodo c.p.p. - norma che disciplina la facoltà di non rispondere spettante al testimone assistito che ha reso dichiarazioni erga alios - si riferisce espressamente ad ipotesi diverse da quella in cui sia intervenuta una sentenza irrevocabile. Proprio perché l’archiviato fuoriesce dall’ambito applicativo degli artt. 197 e 197 bis c.p.p., l’espressione “si è proceduto”, nel ragionamento della Corte, può attenere al solo imputato in relazione al quale sia stata emessa una sentenza di non luogo a procedere. Se la pubblica accusa abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona, questa risulta meritevole di tutela attraverso la disciplina dell'incompatibilità a testimoniare, e non può considerarsi in alcun modo assimilabile a quella di chi, iscritto per dovere d’ufficio nel registro degli indagati, abbia visto chiusa la vicenda a proprio carico con l’archiviazione.
3.5 Il testimone – soggetto “indagato"
Da una lettura sistematica degli artt. 197 bis, 351 e 362 c.p.p., è possibile dedurre che anche la persona sottoposta a indagini preliminari, che è soggetta alla connexitatis causae data dagli art. 12 comma 1 lettera c) e 371 comma 2 lettera b) c.p.p., potrà essere sentita come “futuro testimone assistito” nel corso delle indagini. La precisazione circa il tipo di connessione che consente l’ascolto del testimone è essenziale, dato che l’eventuale sussistenza di un legame più intenso tra i fatti di causa imporrebbe di attendere l’irrevocabilità della sentenza che definisce la posizione del testimone, in forza del comma 1 dell’art. 197 bis del codice di rito.
Gli artt. 352 e 361 c.p.p., ossia le norme che disciplinano l’acquisizione di informazioni da parte della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 63/2001, rinviano espressamente alla disciplina della testimonianza assistita. Ciò significa che la compatibilità con la qualifica di teste assistito può aversi prima ancora dell’esercizio dell’azione penale, e quindi prima dell’inizio del processo vero e proprio, a patto che l’organo inquirente renda l’avviso ex art. 64 comma 3 lettera c).
La qualifica di teste assistito scatta dal momento in cui l’indagato sentito dagli inquirenti renda, previo rituale avviso, delle dichiarazioni sulla responsabilità di imputati connessi teleologicamente o collegati.
La dottrina si divide sulle modalità che l’inquirente dovrà seguire al momento dell’acquisizione delle dichiarazioni provenienti da questo soggetto. Secondo alcuni[58], il pubblico ministero sarà tenuto a chiudere immediatamente l’interrogatorio o l’assunzione di informazioni. Secondo altra parte della dottrina, occorre che l’interrogatorio volga al termine prima di sentire il soggetto come persona informata sui fatti[59]. In ogni caso pubblico ministero potrà sentire l’imputato connesso teleologicamente o collegato come futuro teste assistito.
Una tale disciplina può determinare dei rischi che non possono essere ignorati. Risulta evidente che nel corso delle indagini, come già evidenziato prima, le protezioni e le tutele predisposte per l’interrogato sono sicuramente inferiori rispetto all’imputato. Nonostante l’avviso, che costituisce una garanzia prettamente formale, il pericolo a cui va incontro l’indagato è quello di subire delle coartazioni nella scelta di rendere o meno dichiarazioni sul fatto altrui. Rischio che è solo parzialmente e successivamente scongiurato dal fatto che, la deposizione sia accompagnata dalle tutele e dai privilegi previsti dalle regole della testimonianza assistita quali l’assistenza del difensore, dato che questa avrà luogo su fatti e circostanze decise quando il difensore non aveva avuto modo di intervenire.
L’art. 197 bis c.p.p. rappresenta la risposta del legislatore a delle questioni quanto mai attuali, ovvero l’attuazione nel processo penale delle indicazioni costituzionali su diritto di difesa e diritto al contraddittorio. Nonostante sia stata fortemente ristretta l’area del diritto al silenzio, sono state approntate delle soluzioni in grado di riequilibrare la disciplina. Al soggetto che ne abbia necessità sono infatti attribuite una serie di protezioni preventive e successive alla deposizione stessa.
È da far notare il fatto che risulta necessaria una grande cautela nel porre mano a qualsiasi intervento attraverso cui si intenda ridisegnare i profili del contributo probatorio dell’imputato sulla responsabilità di altri. La materia della prova è dominata dalla esigenza di coniugare regole logiche e principi garantistici. Per questo motivo solo una valutazione rigorosa degli interessi in gioco, oltre che la minuziosa ricognizione delle diverse aree coinvolte dalla regolamentazione, consente di assicurare, ad un tempo, la giustizia sostanziale e l’efficienza della macchina processuale.
Al netto dell'analisi proposta, può pacificamente affermarsi che sarebbe stata più corretta una categorizzazione soggettiva meno frammentaria e più unitaria. Le tipologie soggettive determinano un’inevitabile difficoltà al momento dell’applicazione. Discipline differenziate per ciascun dichiarante, o per la diversa caratterizzazione che lo stesso dichiarante assume al momento della deposizione, rendono complicata l’escussione del testimone assistito.
[1] C. CONTI, sub art. 197 bis, in Comm. c.p.p, Giarda - Spangher, V, Milano, IPSOA, 2017, 2043.
[2] R. A. RUGGIERO, Cronaca di una incostituzionalità annunciata, in Diritto Penale Contemporaneo (web), 2017, 2, 238.
[3] Corte Cost., ord. 12 novembre 2002, n. 451: «è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197 comma 1 lett. b e 197 bis comma 1 c.p.p., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., nella parte in cui prevedono che il soggetto, già imputato di un reato probatoriamente collegato a norma dell’art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p. possa essere sentito come testimone soltanto dopo che nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena, e non anche quando nei suoi confronti è stata pronunciata in udienza preliminare sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela».
[4] Corte Cost., ord. 22 luglio 2004, n. 265.
[5] Ibidem.
[6] Corte Cost., sent. 21 novembre 2006, n. 361.
[7] A. SCALFATI et al., ivi, 637: «l’assoluzione è assistita da una serie di formule (..) tra cui ‘il fatto non sussiste’ o ‘l’imputato non ha commesso il fatto’ attraverso le quali si nega la relazione storica dell’imputato con il fatto addebitato (..)».
[8] L. CORDÌ, Il regime delle dichiarazioni testimoniali rese dall’imputato in procedimento connesso o per reato collegato assolto per non aver commesso il fatto, in Foro Italiano, 2007, 7/8, 2024.
[9] O. MAZZA, L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento, Milano, Giuffrè, 2004, 53: “il riconoscimento della facoltà di non rispondere a domande vertenti sulla responsabilità per il fatto proprio già giudicato o ancora sub iudice (art. 197 bis comma 4 c.p.p.) è il portato della particolare posizione di chi, imputato o già giudicato in via definitiva, sia chiamato a testimoniare sul fatto altrui connesso o collegato a quello che gli è stato addebitato”.
[10] M. BONTEMPELLI, L’efficacia della sentenza di assoluzione irrevocabile tra garanzie di autodifesa e terzietà del testimone, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 2/3, 801.
[11] M. BONTEMPELLI, ivi, 810.
[12] M. L. DI BITONTO, La Corte Costituzionale riapre il dibattito sulla testimonianza assistita, in Cass. pen., 2007, 2, p. 496: «In conclusione, asserire che nei confronti del destinatario di una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto l'ordinamento abbia attestato in maniera incontrovertibile l'estraneità di tale persona ai fatti contestati appare un'affermazione scorretta, contrastante con i peculiari caratteri dell'accertamento penale».
[13] C. CONTI, Imputato assolto per non aver commesso il fatto deve essere equiparato al testimone comune, Dir. pen. proc., 2007, 3, 316.
[14] C. CONTI, sub art. 197 bis, in Comm. c.p.p, Giarda - Spangher, V, Milano, IPSOA, 2017, 2043.
[15] Corte Cost., sent. 26 gennaio 2017, n. 21.
[16] O. MAZZA, La testimonianza dell’imputato assolto fra verità processuale e autodifesa dell’onore, in Giur. Cost., 2017, 1, 150
[17] Ibidem.
[18] G. GIOSTRA, Sull’incompatibilità a testimoniare anche dopo il provvedimento di archiviazione, in Giur. Cost., 1992, 991.
[19] Trib. Genova, 14 ottobre 1997, in Cass. pen., 1998, p. 3419: «non è punibile per il delitto di falsa testimonianza, ai sensi dell’art. 384 c.p., la persona chiamata a testimoniare sulla propria corresponsabilità per un delitto dal quale era stata assolta con sentenza passata in giudicato: deve infatti ritenersi che in tale caso ricorra una situazione di necessità, costituita da un evento di danno, e non di pericolo, per l’effettivo nocumento all’onore – restituito alla persona dalla sentenza assolutoria passata in giudicato – evitabile solo con la commissione del reato di falsa testimonianza; nocumento concreto e reale, e non soltanto possibile od opinabile».
[20] Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2007, n. 28631.
[21] C. CONTI, Profili penalistici della testimonianza assistita: l’esimente dell’art. 384 c.p. tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 3, 842.
[22] C. CONTI, ivi, 859.
[23] Definizione riportata da C. CONTI, Illegittimità costituzionale dell’art. 197 bis commi 3 e 6 c.p.p., con riferimento all’assolto “perché il fatto non sussiste”, in www.ilpenalista.it, 2017, 1, 4:
[24] C. CONTI, ivi, p. 5: «L'assolto irrevocabile perché il fatto non sussiste è, dunque, un testimone garantito che rende dichiarazioni non soggette all'obbligo dei riscontri, in assenza del difensore, con il beneficio dell'inutilizzabilità contra se e senza alcuna possibilità di tacere sui fatti oggetto del giudicato».
[25] Corte Cost., sent. 14 luglio 1971, n. 175.
[26] D. PERNA, sub art. 530, in Comm. c.p.p., S. BELTRANI, Milano, Giuffrè, 2019, 1955.
[27] D. PERNA, ivi, 1958.
[28] In tal senso Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 2009, n. 10346; Cass. pen., sez. VI, 7 maggio 2003, n. 24075; Cass. pen., sez. I, 9 maggio 2006, n. 29421; Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2006, n. 5781.
[29] Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 2009, n. 10346.
[30] Cass. pen., sez. VI, 6 novembre 2006, n. 5781: «all'imputato in un procedimento connesso o collegato deve essere riconosciuta una piena capacità di testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti».
[31] Cass. pen., sez. I, 18 ottobre 2005, n. 40203.
[32] A. SCALFATI et al., ivi, 673.
[33] Corte Cost., ord. 15 gennaio 2003, n. 32: «il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi».
[34] Dal testo della relazione di R. DIES, Decreto penale di condanna: presupposti, effetti, sanzioni sostitutive e regole di giudizio, svoltasi al corso di preparazione “Il punto sui riti alternativi”, tenuto presso la Scuola Superiore della Magistratura a Lecce dal 21 al 23 marzo 2018.
[35] F. CORDERO, Procedura Penale, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1082: «Lo storicamente certo scade a probabile: il giudice condanna su premesse in base a cui assolverebbe, secondo l’art. 530, comma 1 c.p.p.; al sommariamente condannato spetta un contraddittorio successivo, se lo chiede».
[36] si veda la nota n. 157 di A. FURGIUELE, La prova per il giudizio nel processo penale, Torino, Giappichelli, 2007, 166.
[37] E. AMODIO, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato dell’imputato sul fatto altrui, in Cass. pen., 2001, 12, p. 3598: «Il legislatore tentenna ed esita a mettere in ordine i tre diversi piani del discorso legislativo: avvertimento, dichiarazioni eteroaccusatorie, dovere di testimoniare. L'avviso prospetta l'eventuale e futura assunzione dell'ufficio di testimone ad un indagato che non ha ancora reso alcuna dichiarazione e che ignora, comunque, in quale momento subirà la perdita del suo diritto al silenzio sulla responsabilità di altri».
[38] definizione di F. CORDERO, ivi, 693-695.
[39] A. FURGIUELE, ivi, 167.
[40] C. CONTI, sub art. 197 bis, in Comm. c.p.p, Giarda - Spangher, V, Milano, IPSOA, 2017, 2044.
[41] M. CERESA GASTALDO, Premesse allo studio delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 2, 549.
[42] C. CONTI, Profili penalistici della testimonianza assistita: l’esimente dell’art. 384 c.p. tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 3, 854.
[43] In questi termini C. CONTI, ivi, 856: «L'obbligo di deporre non scatta a seguito di una libera scelta del soggetto, bensì a seguito di una qualificazione rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità inquirente (pubblico ministero o polizia) o del giudice».
[44] C. CONTI, Le sezioni unite ed il silenzio della sfinge: dopo l’archiviazione l’ex indagato è testimone comune, in Cass. pen., 2010, 7/8, 2599.
[45] Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2007, n. 31945.
[46] G.L. FANULI, A. LAURINO, Incompatibilità a testimoniare e archiviazione dopo la legge sul c.d. giusto processo: un nodo apparentemente irrisolto, in Cass. pen., 2002, 12, 3955: «Lo stesso legislatore afferma che, nel caso di sentenza di non luogo a procedere, il dichiarante deve essere sentito come testimone assistito: si ricordi infatti il tenore letterale del secondo periodo in esame, in base al quale ‘nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre (...)’».
[47] Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2008, n. 34843.
[48] Cass. pen., sez. V, 15 marzo 2007, n. 15804.
[49] C. RIVIEZZO, La verità processuale e il divieto delle dichiarazioni contra se. Così la Consulta ha conciliato due contrastanti esigenze, in DeG – Dir. e Giust., 2003, 18, 74.
[50] secondo la ricostruzione di C. CONTI, sub art. 197 bis, in Comm. c.p.p, Giarda - Spangher, V, Milano, IPSOA, 2017, 2046.
[51] Trib. Foggia, 8 febbraio 2002, in Giur. mer., 2002: «come ognuno può notare, la persona, la cui posizione sia stata archiviata, ha cessato di avere la qualifica di indagato e non ha mai avuto quella di imputato: sicché non rientra nelle categorie per le quali l'art. 197 c.p.p. prevede un'incompatibilità a testimoniare».
[52] Cass. pen., sez. VI, 3 agosto 2007, n. 31945.
[53] Cass. pen., sez. I, 17 novembre 2004, n. 46966: «Priva di fondamento sul punto appare l'argomentazione della difesa che dovrebbe in tal caso ravvisarsi una irrevocabilità, non formale perché non prevista, ma sostanziale, trattandosi di istituto non previsto dall'ordinamento».
[54] Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2010, n. 12067.
[55] Ibidem.
[56] C. CONTI, ivi, 2604-2605: «Questa soluzione si fonda sul presupposto secondo cui è solo dopo la formulazione della imputazione che il principio di graduazione, già elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, può essere invocato. Prima di essa, non c'è azione penale. L’archiviazione mette fine alla vicenda ripristinando uno status immacolato come quello del testimone comune».
[57] C. CONTI, ivi, 2602.
[58] C. CONTI, L’imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità, Padova, CEDAM, 2003, 234.
[59] P. GAETA, Le modifiche alla disciplina delle informazioni assunte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (artt. 351 e 362 c.p.p.), in P. TONINI, Il giusto processo, Bologna, Zanichelli, 2012, 443.
Bibliografia
AMODIO E., Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato dell’imputato sul fatto altrui, in Cass. pen., 2001, 12, 3598:
BONTEMPELLI M., L’efficacia della sentenza di assoluzione irrevocabile tra garanzie di autodifesa e terzietà del testimone, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 2/3, 801.
CERESA GASTALDO M., Premesse allo studio delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 2, 549.
CONTI C., sub art. 197 bis, in Comm. c.p.p, Giarda - Spangher, V, Milano, IPSOA, 2017, 2043.
CONTI C., Imputato assolto per non aver commesso il fatto deve essere equiparato al testimone comune, Dir. pen. proc., 2007, 3, 316.
CONTI C., Illegittimità costituzionale dell’art. 197 bis commi 3 e 6 c.p.p., con riferimento all’assolto “perché il fatto non sussiste”, in www.ilpenalista.it, 2017, 1, 4:
CONTI C., Profili penalistici della testimonianza assistita: l’esimente dell’art. 384 c.p. tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 3, 842.
CONTI C., L’imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e obbligo di verità, Padova, CEDAM, 2003, 234.
CONTI C., Profili penalistici della testimonianza assistita: l’esimente dell’art. 384 c.p. tra diritto al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 3, 854.
CONTI C., Le sezioni unite ed il silenzio della sfinge: dopo l’archiviazione l’ex indagato è testimone comune, in Cass. pen., 2010, 7/8, 2599.
CORDERO F., Procedura Penale, Milano, Giuffrè, 2006, 1082.
CORDÌ L., Il regime delle dichiarazioni testimoniali rese dall’imputato in procedimento connesso o per reato collegato assolto per non aver commesso il fatto, in Foro Italiano, 2007, 7/8, 2024.
DI BITONTO M. L., La Corte Costituzionale riapre il dibattito sulla testimonianza assistita, in Cass. pen., 2007, 2, 496.
FANULI G.L., LAURINO A., Incompatibilità a testimoniare e archiviazione dopo la legge sul c.d. giusto processo: un nodo apparentemente irrisolto, in Cass. pen., 2002, 12, 3955.
FURGIUELE A., La prova per il giudizio nel processo penale, Torino, Giappichelli, 2007, 166.
GAETA P., Le modifiche alla disciplina delle informazioni assunte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria (artt. 351 e 362 c.p.p.), in P. TONINI, Il giusto processo, Bologna, Zanichelli, 2012, 443.
GIOSTRA G., Sull’incompatibilità a testimoniare anche dopo il provvedimento di archiviazione, in Giur. Cost., 1992, 991.
MAZZA O., L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nel suo procedimento, Milano, Giuffrè, 2004, 53.
MAZZA O., La testimonianza dell’imputato assolto fra verità processuale e autodifesa dell’onore, in Giur. Cost., 2017, 1, 150
PERNA D., sub art. 530, in Comm. c.p.p., S. BELTRANI, Milano, Giuffrè, 2019, 1955.
RIVIEZZO C., La verità processuale e il divieto delle dichiarazioni contra se. Così la Consulta ha conciliato due contrastanti esigenze, in DeG – Dir. e Giust., 2003, 18, 74.
RUGGIERO R.A., Cronaca di una incostituzionalità annunciata, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017, 2, 238.

