Pubbl. Mer, 5 Nov 2025
L´ascesa, l´evoluzione e le contraddizioni del potere di ordinanza sindacale
Mario Tocci
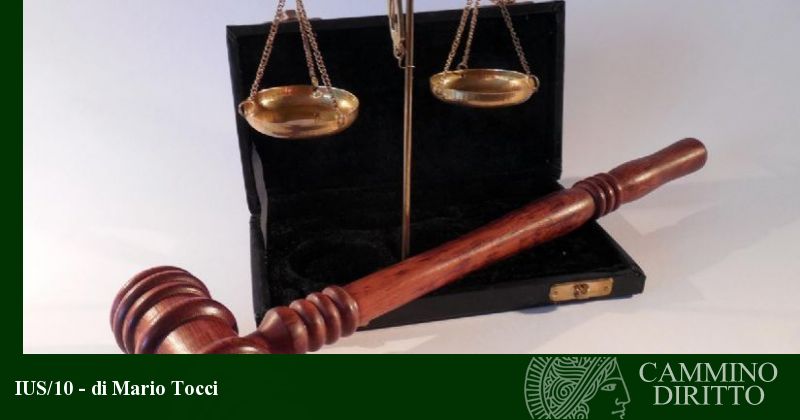
Il presente lavoro analizza l’evoluzione storica, normativa e giurisprudenziale del potere di ordinanza sindacale, con particolare attenzione al suo uso in contesti emergenziali e ambientali. Lo studio ricostruisce le principali tappe che hanno segnato la trasformazione di questo strumento da rimedio eccezionale a pratica amministrativa diffusa, evidenziandone i profili di criticità sotto il profilo della legalità costituzionale, della separazione dei poteri e della tutela dei diritti fondamentali. Attraverso l’esame di legislazione, dottrina e giurisprudenza, il saggio mette in luce le tensioni tra efficienza decisionale e garanzie democratiche, ponendo l’accento sulla necessità di una riforma che restituisca al potere di ordinanza il suo carattere straordinario e residuale.
Sommario: 1. L’ordinanza sindacale come paradigma di governo locale in fase emergenziale; 2. Le origini storico-normative del potere di ordinanza: dagli anni pre-unitari ai primordi del XX secolo; 3. L’ordinanza sindacale dopo la nascita della Repubblica Italiana: dalla Costituzione al Testo Unico degli Enti Locali; 4. La nuova stagione della sicurezza urbana: dal “Pacchetto Sicurezza” al decreto “Minniti-Orlando”; 5. Il potere di ordinanza durante la pandemia del Covid-19; 6. Il potere di ordinanza sindacale in materia ambientale; 7. Conclusioni – Verso un nuovo equilibrio tra potere di ordinanza, legalità e governo locale.
Summary: 1. The mayoral ordinance as a paradigm of local government in times of emergency; 2. The historical and normative origins of the ordinance power: from the pre-unification period to the early 20th century; 3. The mayoral ordinance after the birth of the Italian Republic: from the Constitution to the Consolidated Law on Local Authorities; 4. The new season of urban security: from the “Security Package” to the “Minniti-Orlando” decree; 5. The ordinance power during the Covid-19 pandemic; 6. The mayoral ordinance power in environmental matters; 7. Conclusions – Towards a new balance between ordinance power, legality, and local government.
1. L’ordinanza sindacale come paradigma di governo locale in fase emergenziale
L’analisi dell’evoluzione del potere di ordinanza riconosciuto ai sindaci, e in particolare delle ordinanze contingibili e urgenti (1), si rivela imprescindibile per comprendere le profonde trasformazioni che hanno interessato il modello di governance locale in Italia, soprattutto a partire dagli anni ’90 del Novecento e con un’accelerazione netta nei decenni successivi.
Dal punto di vista classificatorio, la dottrina ha sempre operato una pressoché condivisa distinzione tra “ordinanze” ordinarie e ordinanze “straordinarie”, facendo afferire queste ultime – vieppiù indifferentemente definite “contingibili e urgenti” oppure “ordinanze sindacali d’urgenza” oppure “provvedimenti di urgenza del sindaco” ovvero “del prefetto” oppure “ordinanze di necessità e urgenza” oppure “ordinanze anche in deroga alla legislazione vigente” (2) – alla species degli atti adottati extra ordinem, ossia in via derogatoria rispetto alla vigente normativa, onde far fronte a fattispecie emergenziali (3).
Di per sé, come chiarito dal giudice delle leggi, l’ordinanza non ha un contenuto… prestabilito dalla legge, ma da questa rimesso alla scelta discrezionale dell'organo agente, secondo richiesto dalle circostanze, diverse da caso a caso, che ne impongono l'emanazione, laddove dette circostanze non sono, a loro volta, previste – né, di regola, sono prevedibili in astratto – da specifiche disposizioni di legge (4).
L’emergere sempre più frequente di situazioni di crisi – in ambito ambientale, sanitario, urbanistico o legato alla sicurezza urbana – ha spinto le istituzioni locali a ricorrere con crescente disinvoltura a strumenti giuridici eccezionali, capaci di “bypassare” i procedimenti amministrativi ordinari, facendo leva su un principio di urgenza tale da giustificare, almeno formalmente, deroghe alla legalità sostanziale (5).
Le deroghe, però, secondo la giurisprudenza costituzionale, devono avere un intervallo temporale di riferimento e un nesso strumentale diretto alle problematiche impellenti alla cui risoluzione siano finalizzate (6) nonché sottendere una, pur elastica, copertura legislativa (7).
Questa progressiva espansione del potere di ordinanza non si è verificata in modo neutro o silente: essa ha provocato accesi dibattiti dottrinari, tensioni giurisprudenziali e non pochi conflitti istituzionali. È noto, infatti, che lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente si pone ai confini tra amministrazione e normazione, tra legalità e discrezionalità, tra garanzia dei diritti fondamentali e tutela dell’ordine pubblico e dell’interesse collettivo.
Siffatta garanzia, essa stessa di mantenimento dell’unità di indirizzo dell’ordinamento, si sostanzia pure nella potestà del prefetto – ex art. 13 della l. 1 aprile 1981, n. 121 – di annullamento d’ufficio degli atti adottati dal sindaco quale ufficiale di governo, che risultano essere illegittimi o che comunque minano la summenzionata unità di indirizzo (8).
La pandemia da Covid-19, come evento spartiacque, ha poi rappresentato un caso emblematico e drammatico di siffatta tendenza, mostrando plasticamente le criticità e le potenzialità connesse all’uso – e talvolta all’abuso – di poteri sindacali eccezionali (9). In quel frangente, la pressione dell’opinione pubblica, l’urgenza sanitaria e la lentezza delle risposte centrali hanno creato un contesto in cui molti sindaci hanno assunto decisioni di grande impatto, anche a costo di sollevare interrogativi in ordine a competenza, legittimazione e coerenza con i principi costituzionali.
La centralità del tema è confermata dal fatto che il potere di ordinanza ha smesso di essere uno strumento episodico, residuale, per diventare, in alcune amministrazioni locali, una modalità di governo abituale, spesso favorita da assetti istituzionali fortemente verticalizzati. Ciò impone una riflessione strutturale, non solo sull’apparato normativo che disciplina l’ordinanza, ma anche sulla cultura amministrativa che ne sostiene l’impiego, sull’evoluzione del ruolo del sindaco e, più in generale, sulla trasformazione del rapporto tra potere locale e garanzie costituzionali.
È dunque emersa l’esigenza di ricostruire genealogicamente e criticamente il percorso normativo, storico e giurisprudenziale del potere di ordinanza, con un’attenzione specifica al suo impiego in fase emergenziale, ambito in cui emergono con particolare forza le tensioni tra tutela del bene collettivo, principio di legalità, partecipazione democratica e responsabilità amministrativa.
2. Le origini storico-normative del potere di ordinanza: dagli anni pre-unitari ai primordi del XX secolo
Per comprendere appieno la fisionomia contemporanea del potere di ordinanza sindacale è necessario ripercorrere le sue radici storiche, che affondano nel periodo preunitario e che si consolidano con la costruzione del primo Stato amministrativo italiano, a partire dal 1861 (10).
Già negli ordinamenti preunitari – Regno di Sardegna, Regno delle Due Sicilie, Granducato di Toscana, Stato Pontificio – si rinvengono forme embrionali di potere emergenziale affidato alle autorità municipali, soprattutto in materia di polizia urbana, igiene pubblica e controllo degli alimenti.
Tali poteri erano spesso esercitati da magistrati locali o podestà, con un elevato grado di discrezionalità e senza vincoli procedimentali strutturati, in coerenza con un’idea di amministrazione come braccio operativo del sovrano piuttosto che come articolazione di un sistema giuridico normato e garantito.
Con l’unificazione nazionale e la conseguente necessità di omogeneizzare gli apparati amministrativi, il legislatore avviò un processo di codificazione e sistematizzazione delle competenze degli enti locali.
In tale cornice si inserisce la legge 20 marzo 1865, n. 2248, che rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’architettura amministrativa post-unitaria. Essa, articolata in vari allegati, prevedeva specificamente, all’interno dell’allegato “C” dedicato alla sanità pubblica, una serie di disposizioni volte a conferire ai sindaci il potere di adottare provvedimenti urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo sanitario. In particolare, gli artt. 1 e 29 riconoscevano ai sindaci un ruolo di primo piano nella tutela della salute collettiva, autorizzandoli a disporre misure dirette alla rimozione delle cause di insalubrità.
Tali norme, oltre a indicare un primato della funzione sanitaria all’interno della missione istituzionale municipale, prefiguravano un’idea di potere sindacale fortemente improntata all’intervento diretto e tempestivo, quasi in una forma para-giudiziaria, dove l’urgenza sostituiva la procedura, e la responsabilità amministrativa si faceva carico dell’interesse collettivo in assenza di strumenti ordinari efficaci.
Non meno rilevante, sotto il profilo giuridico, era il contenuto dell’allegato “E” della medesima legge, relativo al contenzioso amministrativo: esso consentiva, in presenza di esigenze gravi e indifferibili, l’adozione di decreti motivati da parte dell’amministrazione, anche in deroga a procedimenti pendenti.
Si tratta di uno dei primi riconoscimenti normativi della possibilità per il potere amministrativo di agire in deroga alla legalità formale in virtù del principio di necessità.
Nei decenni successivi, il legislatore intervenne più volte per ampliare e rafforzare il potere di ordinanza dei sindaci, nella consapevolezza che l’unità amministrativa del Paese richiedeva non solo una struttura burocratica efficiente, ma anche la capacità di reagire rapidamente a fenomeni dirompenti e imprevisti, soprattutto a livello locale. In questo senso, la legge 25 giugno 1865, n. 2539 rappresentò un ulteriore passo verso la normazione dell’emergenza: essa prevedeva esplicitamente la possibilità per le autorità locali di disporre l’occupazione temporanea di beni privati in caso di gravi emergenze, come frane, alluvioni o eventi catastrofici. Il sindaco diventava, così, un soggetto legittimato ad agire anche in deroga al diritto di proprietà, in nome della sicurezza collettiva, configurandosi come garante non solo dell’ordine pubblico, ma anche della continuità amministrativa in presenza di eventi destabilizzanti.
Tale visione si consolidò ulteriormente nel XX secolo, in particolare con il r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, che formalizzava il potere dei sindaci di emanare ordinanze urgenti per la tutela della pubblica sicurezza e della sanità. Questo provvedimento, varato alla vigilia della prima guerra mondiale, si inseriva in un contesto in cui l’urgenza bellica imponeva una maggiore reattività da parte dello Stato e dei suoi articolati locali. I sindaci, pertanto, vennero dotati di un potere quasi prefettizio, chiamati a intervenire non solo in funzione amministrativa ma anche con capacità dispositiva, in grado di incidere direttamente sui diritti dei cittadini.
Il culmine di questa evoluzione si registrò durante il ventennio fascista, quando la figura del sindaco venne soppressa e sostituita da quella del podestà, nominato dal prefetto su delega del Ministero dell’Interno.
Il r.d 3 marzo 1934, n. 383, che riformò l’ordinamento comunale, sancì il pieno accentramento delle funzioni amministrative locali, attribuendo al podestà non solo i poteri deliberativi ma anche quelli esecutivi, compreso il potere di ordinanza emergenziale. L’art. 55 di esso, unitamente all’art. 217 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), consolidava una concezione autoritaria e monocratica del governo locale, nella quale l’eccezione diventava regola e il principio di legalità era piegato alle esigenze di ordine e disciplina imposte dal regime.
3. L’ordinanza sindacale dopo la nascita della Repubblica Italiana: dalla Costituzione al Testo Unico degli Enti Locali
L’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana l’1gennaio 1948 ha segnato uno spartiacque istituzionale e culturale nella storia giuridica del Paese. Il nuovo assetto costituzionale, ispirato a principi democratici e garantisti, ha imposto una revisione critica del rapporto tra pubblici poteri e diritti fondamentali. In questo contesto, il potere di ordinanza, in quanto forma di esercizio monocratico e straordinario dell’autorità amministrativa, è apparso fin da subito problematico, soprattutto per la sua potenziale frizione con i valori supremi dell’ordinamento, in primis il principio di legalità, il principio di uguaglianza e quello del giusto procedimento.
Nonostante il cambiamento di paradigma costituzionale, molte delle norme di epoca monarchica continuarono a produrre effetti nell’ordinamento repubblicano.
Tra queste, l’art. 153 del regio decreto 148/1915, che ancora attribuiva al sindaco – quale autorità sanitaria locale – il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti. Tale norma restò in vigore fino all’approvazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, segnando un paradosso normativo che la dottrina non mancò di sottolineare: un potere straordinario di matrice pre-fascista continuava a operare in un ordinamento costituzionale profondamente mutato.
Nel corso dei decenni, questa dissonanza ha dato origine a numerosi contenziosi di fronte alla Corte Costituzionale, i cui interventi si sono rivelati determinanti per circoscrivere i limiti dell’ordinanza sindacale. Il giudice delle leggi ha infatti costantemente ribadito che l’adozione di ordinanze extra ordinem da parte dei sindaci è legittima soltanto ove sorretta da una base legislativa esplicita, che preveda in modo chiaro e tassativo la possibilità di derogare a norme di rango primario, in presenza di situazioni straordinarie e delimitate nel tempo. Tali condizioni – autorizzazione legislativa espressa, contenuto tipizzato e durata limitata – sono state individuate come presidi minimi per evitare derive autoritarie e garantire la compatibilità delle ordinanze con l’architettura costituzionale.
Un passaggio cruciale nell’evoluzione del potere di ordinanza sindacale è rappresentato dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, in acronimo SSN, avvenuta con la legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Essa non solo ridisegnava l’assetto istituzionale della sanità pubblica italiana, spostandone la gestione verso le Regioni e le unità sanitarie locali, ma confermava e rafforzava il ruolo del sindaco come autorità sanitaria locale. In particolare, veniva riconosciuta la possibilità, per il “primo cittadino”, di adottare, ex art. 32, provvedimenti urgenti e contingibili in caso di pericolo per l’igiene o la salute pubblica nel proprio territorio.
L’elemento di continuità rispetto alla tradizione preesistente era evidente, ma assumeva ora un nuovo significato alla luce della responsabilizzazione crescente degli enti locali nella gestione delle politiche sanitarie e ambientali. Si delineava un modello di sindaco “garante della salute pubblica”, che affiancava al ruolo di amministratore politico quello di presidio tecnico-operativo in caso di crisi. Il potere di ordinanza diventava, quindi, strumento di raccordo tra il livello locale e quello regionale, in un sistema policentrico in cui il sindaco assumeva funzioni di vigilanza, intervento e coordinamento, pur permanendo un’ambiguità tra il suo ruolo di rappresentante della comunità e quello di ufficiale di governo.
Con la legge 8 giugno 1990, n. 142, che costituisce una vera pietra miliare nella disciplina degli enti locali, il legislatore tentò di sistematizzare e razionalizzare il potere di ordinanza, definendo per la prima volta una cornice organica entro cui il sindaco poteva esercitare i propri poteri straordinari.
All’art. 38, per vero, la legge n. 142/1990 riconosceva al sindaco, in qualità di ufficiale del governo, la facoltà di emanare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, purché motivate e adottate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Questo riconoscimento esplicito confermava il permanere della natura bifronte del sindaco – al contempo autorità locale e statale – ma cercava di ancorare l’uso delle ordinanze a requisiti di legalità sostanziale, imponendo un vincolo motivazionale e una finalità preventiva ben precisa: eliminare situazioni di grave rischio per l’incolumità pubblica. L’importanza della norma non risiedeva solo nel suo contenuto, ma anche nel suo significato simbolico e sistematico: per la prima volta, il potere di ordinanza entrava a far parte della legislazione sugli enti locali, abbandonando la marginalità e assumendo un rilievo strutturale.
Con l’approvazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, il processo di decentramento istituzionale ricevette un’accelerazione significativa. L’art. 117 di tale decreto attribuiva ai sindaci, in caso di emergenze sanitarie o igienico-pubbliche di carattere esclusivamente locale, la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti, nella veste di rappresentanti della comunità locale.
Questa formulazione rappresentava una novità rilevante, poiché distingueva con maggiore nettezza tra il sindaco in qualità di ufficiale di governo – cioè soggetto che agisce per conto dello Stato – e il sindaco come rappresentante della comunità amministrata. Siffatta distinzione rifletteva l’evoluzione dell’autonomia locale, intesa non più solo come delega funzionale dello Stato centrale, ma come espressione diretta della sovranità popolare, esercitata mediante il voto e la legittimazione democratica dell’organo elettivo.
L’affidamento al sindaco della gestione emergenziale locale, con poteri propri e diretti, evidenziava una progressiva “municipalizzazione” della risposta alle crisi, in linea con il principio di sussidiarietà e con l’idea che le situazioni di rischio dovessero essere affrontate, in prima istanza, da chi conosce più da vicino il territorio. Tuttavia, simile visione non era priva di rischi: in assenza di strumenti adeguati di controllo, la frammentazione decisionale poteva compromettere l’uniformità della risposta amministrativa, generando disparità, sovrapposizioni o conflitti di competenza.
Con l’adozione del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, meglio noto come Testo Unico degli Enti Locali o in acronimo TUEL, il legislatore italiano ha inteso compiere un’opera di sistematizzazione organica della disciplina relativa alle autonomie locali, razionalizzando l’insieme di norme stratificatesi negli anni precedenti.
Il TUEL rappresenta, a tutt’oggi, la fonte normativa principale per la regolazione della forma di governo comunale, provinciale e metropolitana, nonché per l’attribuzione delle competenze e dei poteri agli organi locali, con particolare riguardo alla figura del sindaco.
Tra i profili di maggior rilievo contenuti nel TUEL figura proprio la codificazione esplicita del potere di ordinanza del sindaco, che viene strutturata attorno a due disposizioni fondamentali: gli artt. 50 e 54. Entrambi delineano la potestà ordinatoria in due diverse prospettive: quella del sindaco come rappresentante della comunità locale e quella del sindaco come ufficiale del Governo. Tale distinzione, già emersa con le riforme precedenti, viene ora elevata a livello sistematico, sancendo la duplice natura istituzionale del primo cittadino, che assume quindi una funzione “ambivalente”, a metà tra il locale e il nazionale.
L’art. 50, comma 5, conferisce al sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie o igienico-pubbliche a carattere esclusivamente locale. Il riferimento all’ambito locale, all’urgenza e alla contingenza della misura sottolinea la natura eccezionale, temporanea e strumentale dell’ordinanza, legittimata solo dalla presenza di un pericolo grave e imminente per la salute pubblica. Il sindaco, in tale veste, agisce come espressione della sovranità popolare a livello municipale, con il compito di garantire, nel quadro dell’autonomia amministrativa, il benessere della collettività residente nel territorio comunale.
Diversamente, l’art. 54, comma 4, attribuisce al sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti urgenti e contingibili per la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana. In questo caso, il sindaco opera come longa manus dell’amministrazione statale, con l’obbligo di cooperare con il prefetto e le forze dell’ordine, assumendo un ruolo para-prefettizio nella prevenzione di pericoli per la sicurezza dei cittadini.
Questa duplice fonte di legittimazione generò, da subito, problematiche interpretative rilevanti: circa il confine tra incolumità pubblica e igiene pubblica; quanto ai limiti del potere sindacale rispetto alle garanzie costituzionali dei cittadini; relativamente alle condizioni in sussistenza delle quali un’ordinanza può derogare alla normativa ordinaria.
4. La nuova stagione della sicurezza urbana: dal “Pacchetto Sicurezza” al decreto “Minniti-Orlando”
Le predette problematiche diventeranno ancora più centrali negli anni successivi, con l’esplosione del contenzioso giurisprudenziale seguito all’ampliamento dei poteri sindacali operato dal “Pacchetto Sicurezza” di cui al d.l. 23 maggio 2008, n. 92.
Nel contesto politico e sociale dell’Italia del primo decennio del XXI secolo, caratterizzato da un’accesa attenzione pubblica alle questioni della criminalità urbana, dell’immigrazione irregolare e del degrado sociale, il Governo guidato da Silvio Berlusconi, su proposta del Ministro dell’Interno Roberto Maroni, varò il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”. Il provvedimento, noto come “Pacchetto Sicurezza”, fu convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 125 e rappresentò uno dei più incisivi interventi legislativi nel rafforzamento dei poteri locali in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Tra le numerose disposizioni contenute nel decreto, una delle più controverse fu proprio la modifica dell’articolo 54 del TUEL, in particolare del suo comma 4, che venne radicalmente riscritto per ampliare sensibilmente le competenze ordinatorie dei sindaci. La nuova formulazione prevedeva che il sindaco potesse adottare ordinanze contingibili e urgenti anche per prevenire e rimuovere gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, assumendo dunque un potere quasi repressivo, al di fuori della tradizionale area sanitaria o igienica.
Tale disposizione stabiliva anche che i sindaci dovessero assicurare la cooperazione operativa tra la polizia locale e le forze di polizia statali, sotto la direzione del Ministero dell’Interno, configurando una sorta di “delegato locale” del Viminale nella gestione della sicurezza. Il D.M. 5 agosto 2008, adottato per attuare le nuove disposizioni, specificava al disposto dell’art. 1, comma 4 bis che dovessero intendersi: per “incolumità pubblica” l’integrità fisica dei cittadini; e per “sicurezza urbana”, l’insieme delle condizioni che assicurano la pacifica convivenza civile nei contesti urbani, con particolare attenzione alla tutela dei beni pubblici e al rispetto delle regole fondamentali della vita comunitaria.
Queste definizioni, volutamente ampie e fluide, aprivano la strada a un uso estensivo e creativo del potere di ordinanza, giustificandone l’adozione non solo in caso di pericoli imminenti per la salute o l’ordine pubblico, ma anche per fenomeni sociali percepiti come devianti: accattonaggio, bivacco, vendita di alcolici in orari serali, lavavetri, commercio ambulante abusivo, prostituzione su strada, uso improprio di spazi pubblici, ecc.
L’entrata in vigore del “Pacchetto Sicurezza” segnò l’avvio di una stagione senza precedenti nell’uso dell’ordinanza sindacale: decine di sindaci, di qualsivoglia estrazione politica, emisero provvedimenti contingibili e urgenti che vietavano comportamenti ritenuti “socialmente pericolosi” o “incompatibili con la vivibilità urbana”. Spesso, tali ordinanze si traducevano in divieti generici o limitazioni preventive a condotte non penalmente rilevanti, alimentando un conflitto sistemico tra efficienza amministrativa e diritti costituzionalmente garantiti.
Si moltiplicarono i ricorsi alla giustizia amministrativa, il cui supremo consesso arrivò a esprimere principi importanti all’uopo: fu, in particolare, sostenuto che la potestà del Sindaco di adottare provvedimenti cosiddetti “contingibili ed urgenti'” potesse essere esercitata al solo fine di affrontare situazioni a carattere straordinario ed imprevedibile, in rapporto alle quali non fosse possibile utilizzare gli ordinari strumenti approntati dall'ordinamento giuridico (11).
La stessa Consulta, investita di apposita questione dal TAR Veneto, dichiarò parzialmente incostituzionale, con la sentenza n. 115/2011 (12), l’art. 54, comma 4, TUEL.
Secondo il giudice delle leggi, per vero, sussisteva violazione del principio della riserva di legge sancito dall’art. 23 Cost. atteso che tale disposizione normativa permetteva ai sindaci di derogare, anche in assenza di situazioni di emergenza, a disposizioni legislative per motivi di sicurezza pubblica e incolumità urbana, senza che tali motivazioni fossero definite dalla legge e delegava, entro certi limiti, la questione a un decreto ministeriale, insufficiente a garantire il rispetto del ridetto principio di legalità. Il che comportava un’insufficiente delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito incidente sulla sfera di libertà dei cittadini, chiamati, secondo un principio fondamentale dello stato di diritto, ad attenersi unicamente agli obblighi generali stabiliti dalla legge. La Corte riscontrò anche un contrasto con gli artt. 97 e 3 Cost., asserendo che la disposizione in parola rispettivamente non garantisse l’imparzialità della Pubblica Amministrazione e non assicurasse il principio di uguaglianza tra i cittadini.
Nel 2017, recependo i pregressi moniti della Corte costituzionale, il legislatore italiano è tornato a occuparsi in maniera incisiva del potere di ordinanza sindacale attraverso il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, noto come “Decreto Minniti-Orlando”, convertito poi nella l. 18 aprile 2017, n. 48.
Questo intervento normativo si colloca in un quadro di crescente pressione sociale su tematiche come il degrado urbano, l’insicurezza percepita e i fenomeni di illegalità diffusa. Proponendosi di rafforzare la capacità reattiva delle autorità locali, in particolare dei sindaci, inquadrati come rappresentanti della comunità locale (13), mediante il conferimento ad essi di strumenti più incisivi e specifici per affrontare problemi di ordine pubblico e vivibilità cittadina.
Il “Minniti-Orlando” intervenne direttamente sugli artt. 50 e 54 del TUEL, apportando modifiche significative.
Da notare, anzitutto, l’introduzione del comma 4 bis dell’art. 54, che forniva una definizione normativa di “incolumità pubblica” e di “sicurezza urbana”, due concetti fino a quel momento rimasti volutamente indeterminati (14). Secondo la nuova formulazione, incolumità pubblica significava “tutela dell’integrità fisica delle persone”, mentre per sicurezza urbana si intendeva la prevenzione e il contrasto “di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della
prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili” o ci si riferiva a “fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.
L’intervento del legislatore mirava quindi a legittimare sul piano formale quelle ordinanze “di sicurezza” che erano state messe in discussione dalla giurisprudenza costituzionale dopo il 2008. L’idea di fondo era quella di tipizzare meglio le aree di intervento, circoscrivendo il potere ordinatorio entro un perimetro di legalità più chiaro, ma al contempo confermando la centralità del sindaco come figura di governo locale con competenze anche in materia di prevenzione della criminalità urbana.
Dipoi, con le modifiche al comma 7 dell’art. 50 TUEL, furono ampliati i poteri del sindaco anche in relazione alla tutela del decoro dei centri storici e della tranquillità pubblica, con l’attribuzione dela potestà di adozione di ordinanze riguardanti orari di somministrazione di alcolici, limiti di circolazione in determinate aree, e interventi per il contrasto del degrado ambientale e urbanistico. In particolare, venne rafforzata la possibilità di coordinare azioni di prevenzione contro fenomeni come lo spaccio di stupefacenti, l’accattonaggio molesto, la prostituzione su strada e altre condotte percepite come destabilizzanti per la sicurezza urbana.
Il decreto Minniti-Orlando cercava di risolvere una delle criticità principali emerse con il “Pacchetto Sicurezza”: l’assenza di una base legislativa esplicita per molti degli interventi sindacali. Elevando a rango primario alcune delle definizioni e degli ambiti già introdotti con il D.M. 5 agosto 2008, il legislatore intendeva “blindare” le ordinanze comunali sotto il profilo della legittimità costituzionale, evitando nuove censure da parte del giudice delle leggi.
Tuttavia, a parere dello scrivente, il decreto “Minniti-Orlando”, pur formalmente più coerente, mantenne una filosofia repressiva e securitaria, centrata sull’idea che il sindaco potesse assumere un ruolo quasi “sostitutivo” di quello prefettizio in determinate circostanze, senza che fossero sempre garantiti adeguati contrappesi o forme di controllo democratico.
E, inoltre, la definizione degli obiettivi per cui il potere di ordinanza potesse essere esercitato risultava eccessivamente vaga e generalizzata, il che avrebbe potuto comportare la violazione del principio di chiara delimitazione delle aree di esercizio del potere medesimo (15).
Vieppiù non v’è chi non veda la sovrapposizione tra ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL e ordinanze ordinarie in materia di decoro urbano ex art. 50 TUEL. Sebbene il legislatore avesse formalmente distinto i due strumenti, nella prassi amministrativa molti sindaci continuarono ad adottare ordinanze “ibride”, che univano finalità di sicurezza urbana e motivazioni igienico-sanitarie, così favorendo la creazione di zone grigie interpretative e creando il rischio di vanificare il tentativo di delimitare rigorosamente le competenze.
5. Il potere di ordinanza durante la pandemia del Covid-19
La vicenda pandemica che ha colpito l’Italia a partire dai primi mesi del 2020 ha rappresentato un banco di prova senza precedenti per la tenuta del sistema costituzionale e amministrativo.
In tale contesto, le ordinanze sindacali hanno costituito uno degli strumenti più discussi e controversi, oscillando tra l’esigenza di garantire la coerenza dell’azione statale e la necessità di rispondere con tempestività a situazioni locali specifiche e diversificate.
La ricostruzione delle varie fasi dell’emergenza consente di osservare come l’ampiezza del potere di ordinanza attribuito ai sindaci si sia progressivamente rimodulata, seguendo un andamento “a fisarmonica” in due fasi: da un’iniziale espansione a un’intermedia seguente contrazione nella prima fino a una parziale riespansione nella seconda.
Nelle primissime settimane di diffusione del contagio, quando ancora l’epidemia appariva circoscritta a determinati focolai territoriali, il legislatore nazionale, con il d. l. 23 febbraio 2020, n. 6, lasciò uno spazio significativo all’iniziativa dei sindaci. L’art. 3, comma 2, di tale decreto riconosceva infatti la possibilità, “nelle more” dell’adozione dei dd.p.c.m., di emanare misure urgenti – sia tipiche, sia atipiche – di contenimento anche mediante il ricorso all’art. 50 TUEL. Tale impostazione era giustificata dall’urgenza di reagire in tempi rapidissimi a scenari epidemiologici in continua evoluzione, e dalla considerazione che i sindaci, in quanto autorità più vicine alle comunità, potessero meglio calibrare le risposte sulla base delle specificità locali.
Si trattava di una forma di sussidiarietà esplicita, che attribuiva agli enti comunali un ruolo non marginale, ma complementare rispetto a quello dello Stato.
Il legislatore riconosceva, in sostanza, che il livello centrale non fosse in grado, da solo, di governare con efficienza una crisi caratterizzata da forte territorialità.
Con l’espandersi del contagio e la necessità di adottare misure uniformi sull’intero territorio nazionale, lo spazio lasciato ai sindaci venne drasticamente ridimensionato.
Già il d. l. 2 marzo 2020, n. 9 pose i primi limiti, introducendo l’inefficacia delle ordinanze comunali e regionali che contrastassero con le misure statali (16). Di talché, a parere della dottrina (17), le ordinanze emesse al di fuori di tali limiti si sarebbero dovute ritenere affette dal vizio dell’incompetenza.
Il successivo d. l. 25 marzo 2020, n. 19 (18), consolidò questo orientamento, vieppiù abbracciato in giurisprudenza (19), allorché fu contemplato un divieto espresso per le autorità locali di adottare ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le prescrizioni centrali.
L’accentramento statale era giustificato dalla necessità di assicurare uniformità di trattamento, evitando che la frammentazione normativa potesse compromettere l’efficacia delle misure di contenimento, onde rispettare il principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost., tale da esigere regole uniformi a tutela di diritti fondamentali, come la salute ex art. 32 Cost.
Tuttavia, questa fase mise in luce una tensione irrisolta tra uniformità e differenziazione: se da un lato lo Stato doveva garantire coerenza, dall’altro i territori mostravano andamenti epidemiologici disomogenei, che avrebbero richiesto soluzioni flessibili.
Con l’avvio della cosiddetta “fase due”, mercé d. l. 16 maggio 2020, n. 33, si assistette a una parziale riespansione del ruolo dei sindaci. Venne infatti riconosciuta la possibilità di adottare ordinanze relative alla chiusura temporanea di spazi pubblici o aperti al pubblico, laddove risultasse impossibile garantire il distanziamento interpersonale.
Per vero, la legge di conversione – nota come legge 22 maggio 2020, n. 35 – ha apportato delle modifiche significative al comma 2 dell’art. 35; segnatamente stabilendo l'obbligo di allineamento delle ordinanze sindacali non solo alle disposizioni emanate a livello nazionale, ma anche a quelle stabilite a livello regionale.
Si trattava, quindi e tuttavia, di una competenza confinata e residuale, esercitabile solo in senso restrittivo (20). La discrezionalità dei sindaci si traduceva, quindi, non in un potere generalizzato di regolamentare l’emergenza, ma in un compito tecnico di adattamento delle misure statali alle peculiarità territoriali.
Questo assetto confermava l’impostazione del legislatore nazionale, orientata a una centralizzazione delle decisioni fondamentali, ma disponibile a riconoscere agli enti locali spazi di integrazione operativa, al fine di soddisfare la necessità di proteggere il ruolo di garanzia dello Stato quale tutore dei livelli fondamentali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali indicati nell'art. 117, comma 2, lett. m, Cost. (21).
Siffatto cambiamento ha sortito l'effetto di incanalare l'esercizio del potere di ordinanza comunale all'interno dei confini definiti dalle normative superiori, quantunque precarizzando le fonti e impattando negativamente sui consociati dell’ordinamento (22).
Si può osservare come questa integrazione e uniformazione delle misure adottate a livello locale fosse già stata realizzata in maniera autonoma dai sindaci, i quali sovente si erano già impegnati a garantire coerenza con i provvedimenti superiori (23).
6. Il potere di ordinanza sindacale in materia ambientale
Nel panorama contemporaneo delle autonomie locali, l’ambito ambientale costituisce una delle aree in cui il potere di ordinanza dei sindaci ha assunto maggiore rilievo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. In un contesto segnato da emergenze ecologiche ricorrenti, da fenomeni di inquinamento cronico, e da eventi climatici estremi sempre più frequenti, la possibilità per il primo cittadino di adottare provvedimenti urgenti e contingibili si è rivelata uno strumento decisivo per garantire interventi rapidi, capaci di rispondere a situazioni di pericolo imminente per la salute pubblica, la qualità dell’ambiente, e la salvaguardia del territorio.
Negli ultimi vent’anni, il legislatore ha progressivamente esteso il perimetro normativo entro cui i sindaci possono intervenire in materia ambientale, sia attraverso norme generali, sia mediante disposizioni speciali contenute nel Codice dell’Ambiente, adottato con il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Questo testo normativo rappresenta il quadro di riferimento unitario per la regolazione dei rifiuti, delle risorse idriche, dell’inquinamento atmosferico e acustico, e della gestione dei siti contaminati. Esso attribuisce ai sindaci una funzione attiva nella prevenzione, repressione e bonifica dei fenomeni inquinanti, delineando un modello di amministrazione ambientale reattiva, fondata su misure immediate, ma entro limiti normativi ben definiti.
Uno degli articoli più significativi ai fini del potere di ordinanza è l’art. 192 del d.lgs. 152/2006, dedicato al divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Questa norma, fondamentale per la tutela del territorio e dell’igiene pubblica, si articola in più commi che definiscono in modo preciso obblighi, divieti, responsabilità e poteri d’intervento. Al comma 1 viene sancito, in modo netto e generale, il divieto di abbandonare rifiuti sul suolo o nel suolo, sia in ambito urbano che extraurbano. Al comma 2 si estende il divieto all’abbandono e all’immissione di rifiuti solidi o liquidi nelle acque superficiali e sotterranee, ponendo l’accento sulla tutela degli ecosistemi idrici. Al comma 3, si introduce una delle disposizioni centrali per l’operatività dei sindaci: in caso di violazione del divieto, i responsabili dell’abbandono sono tenuti a procedere alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. L’autorità comunale può, in tal senso, adottare un’ordinanza specifica che impone agli obbligati di attuare entro un termine stabilito le operazioni di bonifica, con la possibilità di intervento sostitutivo d’ufficio e rivalsa economica in caso di inadempimento.
Si delinea così una forma di ordinanza non più solo “contingibile e urgente”, ma tipizzata dalla legge, fondata su presupposti precisi e su una struttura procedimentale codificata. Il sindaco agisce quindi non in via straordinaria o discrezionale, ma nell’ambito di un potere vincolato dalla legge, volto ad attuare il principio di responsabilità ambientale e di precauzione.
Un aspetto delicato riguarda il rapporto tra l’art. 192 del Codice dell’ambiente, che attribuisce al sindaco un potere normato e circoscritto, e il potere di ordinanza extra ordinem, contingibile e urgente, ex artt. 50 e 54 TUEL. In più occasioni, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che l’esistenza di una normativa puntuale ed esaustiva in materia ambientale, come nel caso dell’art. 192 del Codice dell’ambiente, esclude in via generale il ricorso a ordinanze extra ordinem. Questo principio discende dal rispetto del principio di legalità, in base al quale le pubbliche amministrazioni non possono adottare misure straordinarie quando esistono strumenti normativi ordinari già idonei a fronteggiare la situazione (24). Tuttavia, la stessa giurisprudenza ha ammesso che in casi di emergenza ambientale effettiva e grave, che comportino un pericolo attuale per la salute pubblica, il sindaco può adottare provvedimenti contingibili e urgenti, anche in assenza di un’accertata responsabilità soggettiva per l’abbandono dei rifiuti (25); in tali ipotesi, l’obiettivo prioritario è neutralizzare il pericolo e tutelare la collettività, rinviandosi a un momento successivo la determinazione delle responsabilità e delle eventuali azioni risarcitorie e, pertanto, non configurandosi alcuna illegittimità dell’ordinanza per l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale (26).
Indi l’urgenza può giustificare l’intervento immediato, ma non deve mai diventare un alibi per derogare in via generalizzata alla normativa ordinaria. È sempre necessario motivare puntualmente le condizioni di pericolo, l’impossibilità di ricorrere agli strumenti normativi ordinari e la proporzionalità della misura adottata.
Un ulteriore tema di particolare rilevanza riguarda la responsabilità nella rimozione dei rifiuti: l’art. 192, comma 3, dispone che la rimozione sia a carico del soggetto responsabile dell’abbandono, ma consente di estendere tale obbligo anche al proprietario o al titolare di diritti reali sull’area, in forma solidale. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che questa responsabilità solidale non può essere automatica, ma deve essere fondata sull’imputabilità soggettiva della violazione, per dolo o colpa (27).
Ne consegue che il proprietario non è automaticamente obbligato alla bonifica se non viene dimostrata una sua negligenza, tolleranza o connivenza nell’abbandono dei rifiuti. Questo orientamento tutela il diritto di proprietà e impedisce che il potere di ordinanza venga usato in modo arbitrario o punitivo, scaricando oneri pubblici su soggetti privi di colpa.
Oltre all’art. 192, anche l’art. 278 del d.lgs. 152/2006 riveste un’importanza strategica. Esso attribuisce all’autorità competente – che può essere anche il sindaco, nei limiti delle deleghe – il potere di intervenire con diffide, sospensioni o revoche delle autorizzazioni in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera. In tal caso, l’intervento non ha natura contingibile e urgente, ma si configura come attuazione di un potere amministrativo ordinario, fondato su accertamenti tecnici e istruttorie formali (28).
La giurisprudenza ha sottolineato che, in presenza di violazioni documentate, l’adozione del provvedimento sanzionatorio è doverosa piuttosto che discrezionale (29).
L’inerzia dell’amministrazione configura quindi una responsabilità omissiva, sanzionabile in sede di giurisdizione amministrativa o contabile. Il che rafforza l’idea di una amministrazione ambientale responsabile, che non può limitarsi a registrare l’inquinamento, ma deve agire con tempestività e coerenza normativa.
Infine, va segnalato il ruolo dell’art. 191 del Codice dell’ambiente, che consente l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza rifiuti da parte non solo del sindaco ma anche del Presidente della Regione o del Consiglio dei Ministri. Si tratta di un potere extra ordinem “tipizzato”, utilizzabile solo in presenza di eventi straordinari, come blocco del ciclo dei rifiuti, scioperi, incendi in discarica o emergenze sanitarie. Tale disposto riprende e aggiorna la precedente normativa contenuta nell’art. 13 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che regolava un simile potere di ordinanza. Entrambe le divisate disposizioni presentano affinità riguardo al contenuto e ai presupposti per l'esercizio di tale potere, oltre alle garanzie previste. Tuttavia, emergono differenze significative: da un lato, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 3 bis, comma 2, del Codice dell'ambiente implica che tali provvedimenti debbano essere adottati nel rispetto di principi quali l'azione ambientale, lo sviluppo sostenibile, la sussidiarietà, la leale collaborazione, l’accessibilità alle informazioni e la partecipazione al procedimento (30); d’altronde, l'inserimento, alla fine del comma 1 dell'art. 191, dell'obbligo di comunicare questi provvedimenti anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, garantirebbe un controllo più ampio e incisivo da parte dello Stato (31)
Salvo resta che il citato art. 191 del Codice dell’ambiente non preclude l’attivazione ad hoc di specifici poteri extra ordinem (32)
Un'altra forma peculiare di ordinanza, di cui è responsabile anche il sindaco, è quella prevista dall'art. 9 della l. 26 ottobre 1995, n. 447, nota come "Legge quadro sull’inquinamento acustico". Questa norma consente all’Amministrazione di adottare provvedimenti motivati al fine di imporre temporaneamente misure speciali per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore.
Appare evidente il legame col disposto dell'art. 54, comma 6, del TUEL.
Difatti, esse non sottendono necessariamente un rischio che interessi l'intera comunità, essendo sufficiente che esso riguardi anche solo una famiglia o un singolo individuo (33), vieppiù senza richiedersi un bilanciamento tra il diritto alla salute e altre libertà, come quella di impresa (34).
Inoltre, il loro elemento caratteristico è l'idoneità di ciascuna recata misura a gestire i correlati eventi straordinari, il che richiede una valutazione concreta della soluzione adottata in relazione al tipo di rischio da affrontare ed esclude la fissazione astratta di un rigido parametro di valutazione (35).
E, ancora, sono escluse dalle garanzie di partecipazione, in quanto si tratta di atti di accertamento svolti “a sorpresa”, siccome necessari per garantire l'efficacia dei controlli (36), a tutela della quiete pubblica da intendersi come bene collettivo (37).
Inspiegabilmente, però, la giurisprudenza non è incline a qualificare tali ordinanze alla stregua di provvedimenti contingibili e urgenti (38).
7. Conclusioni – Verso un nuovo equilibrio tra potere di ordinanza, legalità e governo locale.
Il lungo percorso evolutivo del potere di ordinanza sindacale, così come delineato attraverso le fonti normative, la prassi amministrativa e gli interventi giurisprudenziali, evidenzia una realtà dinamica e contraddittoria, segnata da oscillazioni continue tra espansione e contenimento, centralizzazione e autonomia, urgenza e legalità. Nato come strumento eccezionale per affrontare situazioni imprevedibili e pericolose, tale potere si è progressivamente trasformato in una componente strutturale dell’amministrazione locale, spesso utilizzato anche in contesti non propriamente emergenziali.
A partire dagli anni ’90, e in modo particolare con il “Pacchetto Sicurezza” del 2008 e il Decreto Minniti-Orlando del 2017, il potere di ordinanza ha subito una decisa inflazione applicativa, divenendo un mezzo ordinario di gestione delle complessità urbane: dalla sicurezza pubblica al decoro cittadino, dalla sanità all’ambiente, i sindaci hanno sempre più agito come “regolatori dell’eccezione”, capaci di incidere profondamente su diritti, libertà e comportamenti sociali.
Questa espansione, tuttavia, non si è accompagnata a un corrispondente rafforzamento dei meccanismi di controllo e dei presidi di legalità. Al contrario, molti degli strumenti adottati hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale, hanno generato un contenzioso diffuso, e hanno posto in evidenza i rischi insiti in una gestione dell’amministrazione pubblica fondata sulla logica dell’urgenza piuttosto che su quella della programmazione.
L’uso sempre più pervasivo delle ordinanze da parte dei sindaci può essere interpretato come la manifestazione evidente di una crisi strutturale del sistema di governo locale. La crescente difficoltà nel ricorrere agli strumenti ordinari di pianificazione e gestione – spesso ostacolati da vincoli burocratici, mancanza di risorse, incertezza normativa – ha indotto le amministrazioni comunali a cercare scorciatoie decisionali nella forma dell’ordinanza.
Questa deriva non è solo giuridica, ma anche politica e istituzionale: la verticalizzazione della forma di governo locale, la marginalizzazione dei consigli comunali, l’indebolimento dei corpi intermedi e l’impoverimento del dibattito pubblico hanno reso il sindaco una figura monocratica accentratissima, investita di una legittimazione diretta ma spesso priva di contrappesi effettivi. Il potere di ordinanza, in questo contesto, diventa il simbolo di un’azione amministrativa solitaria, fondata su urgenze presunte più che su progettualità condivise.
Ciò è particolarmente visibile nel settore ambientale, dove la complessità delle problematiche – smaltimento dei rifiuti, bonifiche, inquinamento – richiederebbe interventi sistemici e concertati, ma dove invece prevale la logica dell’intervento d’urgenza, dell’atto contingibile e della risposta immediata. Si crea così una dipendenza da strumenti emergenziali, che rischia di diventare strutturale e di erodere la capacità dell’ente locale di governare in modo ordinato e prevedibile.
Nel tentativo di tenere insieme efficienza amministrativa e tutela dei diritti costituzionali, il potere di ordinanza si pone in una posizione ambigua: da un lato, rappresenta uno strumento insostituibile per far fronte a situazioni di urgenza effettiva; dall’altro, quando mal utilizzato o abusato, rischia di trasformarsi in un meccanismo autoritativo che comprime le garanzie fondamentali dei cittadini.
La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha provato a costruire un equilibrio, stabilendo criteri rigorosi per la legittimità delle ordinanze: devono essere adeguatamente motivate, devono intervenire solo in assenza di strumenti ordinari idonei, devono avere una durata limitata nel tempo, e devono essere proporzionate e coerenti con le finalità perseguite. Tuttavia, la concreta applicazione di questi criteri è tutt’altro che scontata, e richiede un rafforzamento della cultura amministrativa, oltre che un miglioramento delle tecniche normative.
Alla luce delle criticità evidenziate, appare evidente la necessità di avviare una riforma complessiva del sistema delle ordinanze, che consenta di restituire a questo strumento il suo carattere eccezionale e residuale, evitando che venga utilizzato come forma alternativa di amministrazione.
Tra le proposte emerse nel dibattito dottrinale e istituzionale si segnalano:
- l’introduzione di criteri uniformi e tipizzati per l’adozione delle ordinanze, con riferimento specifico ai presupposti di fatto e di diritto;
- la previsione di un termine massimo di efficacia e di un obbligo di valutazione ex post degli effetti delle ordinanze;
- il rafforzamento dei meccanismi di controllo prefettizio e giurisdizionale, con tempi rapidi e strumenti agili per verificare la legalità degli atti;
- la promozione di forme di coordinamento intercomunale, soprattutto in materia ambientale, per evitare frammentazioni e disomogeneità;
- l’obbligo di motivazione rafforzata per le ordinanze che incidano su libertà costituzionalmente protette;
- la creazione di banche dati pubbliche e consultabili che raccolgano le ordinanze emanate, in funzione di trasparenza, confronto e accountability.
Solo attraverso interventi mirati e strutturati sarà possibile riconsegnare all’ordinanza la sua giusta funzione, valorizzandone l’utilità nei casi di emergenza reale, ma al tempo stesso evitandone l’abuso, che rischia di delegittimare l’azione amministrativa e minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
1. La letteratura in materia di potere di ordinanza è vastissima. Con particolare riguardo all’inquadramento generale: E. C. Raffiotta, Norme d’ordinanza. Contributo a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2020; C. Meoli, Il potere di ordinanza del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in Giorn. dir. amm., 6/2009, pp. 682 ss.; A. Morrone, Le ordinanze di necessità e di urgenza, tra storia e diritto, in A. Vignudelli (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, Milano, 2009, pp. 133 ss.; R. Cavallo Perin, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità e urgenza, Milano, 1990; V. Angelini, Necessità ed emergenza nel diritto pubblico, Padova, 1986, pp. 156 ss.; F. Bartolomei, voce “Ordinanza (dir. amm.)”, in Enc. dir., XXX, Milano, 1980, pp. 970 ss.; Id., Potere di ordinanza e ordinanze di necessità, Milano, 1979; G. U. Rescigno, voce “Ordinanza e provvedimenti di necessità e urgenza (diritto costituzionale e amministrativo)”, in Noviss. Dig. it., XII, 1965, pp. 89 ss.; G. Treves, La costituzionalità dei provvedimenti amministrativi di necessità e urgenza, in Giur. cost., 1956, pp. 994 ss.
2. R. Cavallo Perin, op. cit., p. 4.
3. G. Marazzita, L’emergenza costituzionale, Milano, 2003, pp. 423 ss.
4. Corte cost., 4 gennaio 1977, n. 4. In dottrina: M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2015, pp. 79 ss.
5. G. Serges, La dimensione costituzionale dell'urgenza. Studio su di una nozione, Napoli, 2020.
6. Corte cost., 2 luglio 1956, n. 8; Corte cost., 23 maggio 1961, n. 26; Corte cost., 4 gennaio 1977, n. 4; Corte cost., 3 maggio 1987, n. 201; Corte cost., 14 aprile 1995, n. 127. In dottrina: G. Marazzita, L’irresistibile tentazione del potere di ordinanza, in www.osservatoriosullefonti.it, 2/2011, pp. 34 ss.
7. Corte cost., 7 aprile 2011, n. 115. In dottrina: M. Capantini, Le "ordinanze di ordinaria amministrazione" dei sindaci e il principio di legalità sostanziale, in Giorn. dir. amm., 10/2011, pp. 1093 ss.
8. Cons. St., sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076. In proposito: M. Gnes, L'annullamento prefettizio delle ordinanze del sindaco quale ufficiale del governo, in Giorn. dir. amm., 1/2009, pp. 44 ss. E con riferimento al momento della pandemia da Covid-19: A. De Siano, Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, in Federalismi, Osservatorio Emergenza Covid-19, 1/2020.
9. M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Riv. AIC, 2/2020, pp. 109 ss.
10. A. Pertici, Sul potere di ordinanza del sindaco e il suo utilizzo in tempo di pandemia: un sistema delle autonomie sempre più verticalizzato e senza «rete»?, in P. Bianchi – E. A. Ferioli – G. Martinico – C. Napoli (a cura di), Scritti in memoria di Paolo Carrozza, Pisa, 2021, vol. II, pp. 785 ss.
11. Cons. St., sez. VI, 28 giugno 2010, n. 4135.
12. V. Cerulli Irelli, Sindaco legislatore?, in Consulta Online, 2011, pp. 1600 ss.; S. Parisi, Dimenticare l’obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa nella sent. n. 115/2011, in Forum Quad. Cost., 2011.
13. G. Cavaggion, L’abuso delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, non rimediato dal d.l. Minniti, ne Il Piemonte delle Autonomie, 2/2017; F. Morganti, La sicurezza urbana nel c.d. “decreto Minniti”, in Democrazia e sicurezza, 3/2017, pp. 37 ss.; C. Ruga Riva – R. Cornelli – A. Squazzoni – P. Rondini – B. Biscotti, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore e il Prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in Dir. pen. cont., 4/2017, pp. 224 ss.; S. Pizzorno, Il potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco con uno sguardo particolare alle modifiche introdotte dal d.l. 14/2017, in Forum Quad. Cost., 18 gennaio 2018.
14. V. Antonelli, La sicurezza in città ovvero l'iperbole della sicurezza urbana, in Istituzioni del federalismo, 1/2017; A. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, applicazioni e profili critici dopo il decreto-legge n. 14 del 2017, in Federalismi, 7/2017, pp. 33 ss.
15. L. M. Di Carlo, Prime riflessioni sul cd “Daspo urbano”, in Federalismi, 17/2017; A. Manzione, Potere di ordinanza e sicurezza urbana fondamento, applicazioni e profili critici dopo il decreto legge n. 14 del 2017, in Federalismi, 17/2017.
16. M. Luciani, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Consultaonline, 11 aprile 2020; A. Ruggeri, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura prova la capacità di tenuta, in Diritti regionali, 1/2020.
17. G. Tropea, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in Federalismi, Osservatorio Emergenza Covid-19, 1/2020, p. 12; cfr. pure: V. Baldini, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in www.dirittifondamentali.it, 1/2020.
18. F. Cintioli, Sul regime del lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020), in Federalismi, Osservatorio Emergenza Covid-19, 1/2020.
19. TAR Puglia, Bari, sez. III, 22 maggio 2020, n. 733.
20. M. Borgato – D. Trabucco, Brevi note sulle ordinanze contingibili ed urgenti: tra problemi di competenza e cortocircuiti istituzionali, in www.dirittifondamentali.it, 24 marzo 2020.
21. Cons. Stato, 7 aprile 2020, parere n. 735, concernente l’annullamento, ex art. 138 TUEL, dell’ordinanza del Sindaco di Messina n. 105/2020, ove è dato leggere che, sussistendo emergenze di carattere nazionale, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di limitare le libertà costituzionali. Con il commento di N. Pignatelli, Il potere di annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo stretto di Messina, in Diritti regionali, 1/2020. Vedasi pure: G. Boggero, Le “more” dell’adozione dei dpcm sono “ghiotte” per le Regioni. Prime osservazioni sull’intreccio di poteri normativi tra stato e regioni in tema di covid-19, ivi.
22. C. Pinelli, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Astrid Rassegna, 5/2020, p. 3; E. Longo, La legge precaria. Trasformazioni della funzione legislativa nell’era dell’accelerazione, Torino, 2017, p. 302.
23. I. Forgione, La gestione locale dell’emergenza da Covid-19. Il ruolo delle ordinanze sindacali, tra sussidiarietà e autonomia, ne Il diritto dell’economia, 2/2020, pp. 92 ss.
24. TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 3 aprile 2024, n. 112. Cfr. pure: TAR Campania, Napoli, sez. V, 3 febbraio 2020, n. 494.
25. TAR Campania, Napoli, sez. V, 23 settembre 2024, n. 5065.
26. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 5 aprile 2023, n. 1139.
27. TAR Friuli Venezia Giulia, 112/2024.
28. V. Paone, Fallimento d’impresa e rimozione dei rifiuti, in Ambiente & sviluppo, 6/2024, p. 399.
29. TAR Piemonte, sez. II, 4 luglio 2024, n. 818.
30. A. Carapellucci, Le ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti: la nuova declinazione di un istituto controverso, in Ambiente Diritto, 9/2009.
31. N. D’Anza, Il potere di ordinanza dei sindaci nel processo di “verticalizzazione” della forma di governo comunale, con particolare riguardo alla materia ambientale, in Ambiente Diritto, 2/2025, p. 11.
32. Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2015, n. 2713; sez. V, 25 agosto 2008, n. 4607.
33. Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2013, n. 1372.
34. TAR Toscana, sez. II, n. 13 luglio 2015, n. 1093.
35. TAR Campania, Napoli, sez. III, 13 maggio 2016, n. 2457.
36. TAR Liguria, sez. II, 18 marzo 2021, n. 221; TAR Marche, sez. I, 17 giugno 2016, n. 380.
37. Cons. Stato, sez. I, 19 luglio 2021, n. 1045.
38. Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5068.

