Pubbl. Ven, 7 Mar 2025
Crisi e rinascita: un dualismo ingannevole. Responsabilità e riforme in tempo di crisi totale: il caso del New Deal e dell’Europa dei diritti
Daniele Colonna
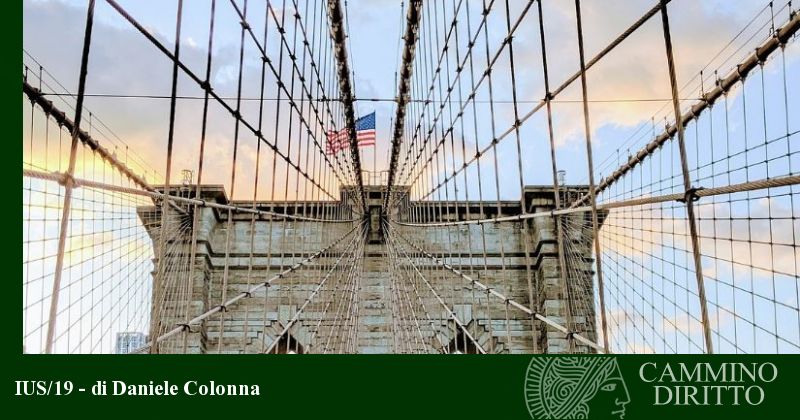
Premessa una breve riflessione circa l’influenza esercitata dal binomio crisi/rinascita sull’immaginario collettivo occidentale, il contributo si concentrerà su alcune vicende tratte dalla storia giuridica del recente passato, al fine di evidenziare le azioni di riforma che hanno permesso di superare situazioni di profonda depressione economica e sociale. Ci si soffermerà in particolare sull’epopea giuridica del New Deal, che consentì alla presidenza Roosevelt di condurre gli Stati Uniti d’America oltre la Grande Depressione, e sulla ricostruzione dell’Europa seguita al secondo conflitto mondiale.
Sommario: 1. Crisi e rinascita nell’immaginario occidentale; 2. Il New Deal di Roosevelt: la forza di una prospettiva; 3. La (ri)nascita dell’Europa dei diritti nel secondo Novecento; 4. Conclusioni..
1. Crisi e rinascita nell’immaginario occidentale
Ricorrente nel discorso pubblico odierno è l’espediente retorico che presenta la crisi quale fase prodromica, avvisaglia, della rinascita[1]. È questa una suggestione, potente, che prospera non solo grazie all’orientalismo stile Kintsugi o alla enfasi con cui oggi viene invocata la resilienza – termine tratto dal vocabolario delle scienze fisiche e psicologiche ma ormai ampiamente penetrato anche nel lessico giuridico, politico ed economico – ma che si radica profondamente nella storia dell’immaginario occidentale, conformandone molti dei momenti costitutivi. Senza pretese di sistematicità e completezza, basti ricordare alcune pietre d’angolo di questa tradizione.
Per gli antichi la grandezza di Roma era sorta sulle ceneri di Troia e sulle tribolazioni del Principe dei Dardani, come solennemente ricapitolato da Virgilio in conclusione del Proemio dell’Eneide: «Tantae molis erat Romanam condere gentem» (Virgilio, Eneide, I, 33). Il cristianesimo ribalta il comune sentire, presentando al mondo un Dio che per essere esaltato si fa a sua volta uomo sino alla suprema umiliazione della morte in croce[2]. Al 1300, secolo di carestie e peste, segue quella «découverte du monde et de l’Homme» che Jules Michelet ci insegnò a chiamare proprio Renaissance[3]. Dallo stesso ambito semantico traiamo il nome della stagione che portò all’unificazione nazionale italiana, quel Risorgimento la cui narrazione ruota proprio intorno a prospettive di riscatto e rivalsa: «Noi fummo da secoli/calpesti, derisi,/perché non siam popolo,/perché siam divisi.»[4]. Oltreoceano le giovani colonie inglesi, bisognose di miti fondativi, si rifanno all’epopea densa di disavventure dei pellegrini della Mayflower per edificare la festa nazionale del “Ringraziamento”[5]. Il Novecento tutto siamo tentati sovente di ridurlo a un mero alternarsi di morte e resurrezione, costringendolo in un andamento oscillatorio indubbiamente intuitivo ma incapace di rendere il “secolo breve” in tutta la sua complessità[6].
Davanti a tanti esempi, più o meno effettivamente radicati nella realtà, il desiderio di recuperare ancora oggi, in un contesto di crisi totale (bellica, sanitaria, ambientale, politica, economica, sociale)[7], questo binomio è comprensibilmente seducente, almeno tanto quanto quello di cedere a uno sconforto nichilista; e, rispetto a quest’ultimo, non meno pericoloso. La storia è, infatti, un divenire ben più imprevedibile di una funzione sinusoidale e le indicazioni che se ne possono trarre, su come superare momenti di depressione sociale, sono spesso contraddittorie. Con riferimento al vicino passato, e limitandosi agli aspetti più propriamente giuridici, ciò è particolarmente evidente in due grandi momenti di rinascita che hanno segnato il Novecento e che hanno dato vita a paradigmi giuridici oggi ormai ampiamente in crisi: il New Deal di Franklin Delano Roosevelt e la (ri)costruzione dell’Europa dei diritti e delle libertà a partire dal secondo dopoguerra.
2. Il New Deal di Roosevelt: la forza di una prospettiva
Quella del 1929 è stata la crisi per antonomasia[8]. Le vicende che condussero al tragico Big Crasch martedì 29 ottobre – la sovraproduzione, la speculazione finanziaria, l’indebitamento eccessivo, la sperequazione dei redditi – sono note agli storici e al grande pubblico, così come gli eventi che seguirono e in particolare il nuovo corso inaugurato dal Presidente Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), cui è tradizionalmente attribuito il merito della rinascita. Tornare a questi anni, con occhio critico, può comunque permettere riflessioni opportune, non tanto al fine di interpretare il presente, quanto per sottolineare la difficoltà di astrarre categorie generali dal passato.
Nei giorni in cui gli americani cominciarono a creare code nevrotiche davanti alle banche, le fabbriche a licenziare gli operai e gli agricoltori a rimanere con prodotti deprezzati e invenduti, alla Casa Bianca si era da poco insediato Herbert Clark Hoover (1874-1964). Il Presidente sembrava avere tutte le qualità per essere l’uomo giusto al momento giusto: ingegnere, milionario self-made, pragmatico amministratore dello sforzo bellico durante la Grande Guerra e apprezzato Secretary of Commerce dal 1921 al 1928. Con amara ironia, però, colui che all’inizio della campagna elettorale aveva profetizzato la fine della povertà – «We in America today are nearer to the final triumph over poverty than ever before in the history of any land. The poorhouse is vanishing from among us.»[9] – finì invece per vedere il proprio nome associato alle baraccopoli dei molti diseredati dalla crisi: le hooverville. Al di là delle oggettive difficoltà cui si trovò suo malgrado a dover far fronte, Hoover fu penalizzato dall’intransigente liberismo vecchia maniera dal quale non seppe divincolarsi e che relegò la sua azione politica a un’inerzia priva di frutti: «an outworn tradition» come sprezzantemente la definirà il suo successore[10].
Su questa difficoltà dei repubblicani a farsi interpreti della novità dei tempi e delle connesse rinnovate esigenze, Roosevelt costruì la sua prima elezione nel 1932. Come noto, la proposta elettorale dei democratici non era allora ben strutturata intorno a un programma di riforme organico[11]. Ciò nonostante, il nuovo Presidente mostrò di aver chiara sin da subito la prospettiva da perseguire con decisione. Pur nella sua retoricità, il discorso inaugurale pronunciato a Washington il 4 marzo 1933 compendia lucidamente la ratio che sosterrà la grande stagione riformistica in procinto di avviarsi. La crisi non viene soggiaciuta – «Only a foolish optimist can deny the dark realities of the moment.»[12] – ma è subito esorcizzata con l’individuazione di chiare e coraggiose linee programmatiche: intervento diretto dello Stato al fine di arginare la disoccupazione – «Our greatest primary task is to put people to work […] It can be accomplished in part by direct recruiting by the Government itself […]»[13] – e controllo della finanza selvaggia – «[…] there must be a strict supervision of all banking and credits and investments; there must be an end to speculation with other people’s money, and there must be provision for an adequate but sound currency.»[14].
Una ricetta innovativa che seppe coinvolgere gli americani in una narrazione persuasiva, dai toni al contempo drammatici e rassicuranti e a cui non era estranea ovviamente il “cliché” della rinascita: «This great Nation will endure as it has endured, will revive and will prosper.»[15]. Un espediente retorico, certo, cui seguirono, però, sin da subito concrete azioni di riforma.
Noto è il furore legislativo che caratterizzò i primi cento giorni di mandato e che, sebbene con gradi di intensità scostanti, perdurò sino al 1938[16]. Molte furono le misure, emergenziali e strutturali, con cui si tentò di cambiare il corso della grande depressione: il superamento del proibizionismo; la svalutazione del dollaro; l’aumento dei sussidi di disoccupazione e la concessione di prestiti agevolati; la regolamentazione del settore primario e del sistema creditizio, bancario e finanziario; il rafforzamento dei diritti dei lavoratori e la legittimazione delle attività sindacali e della contrattazione collettiva; l’istituzione di un embrionale sistema previdenziale e di sicurezza sociale[17]. Un mutamento di paradigma rispetto la tradizione politica, economica e giuridica precedente tale da porsi come «the principal watershed in twentieth-century American constitutional development.»[18].
Indubbiamente questa radicale azione di riforma contribuì a trainare gli Stati Uniti verso la ripresa. D’altronde è però necessario sottolineare che esso solo non fu né sufficiente, né esente da ambigui e multiformi chiaroscuri che ne impediscono una lettura unitaria, soprattutto qualora la si voglia ridurre ad una cronaca trionfale.
Gli ostacoli sulla strada del New Deal furono numerosi – nota su tutti è la strenua opposizione della Corte suprema – e talvolta riuscirono a porre nel nulla gli interventi legislativi più dirompenti[19]. Si collocarono effettivamente le premesse per un welfare state, ma questo rimase sempre dimidiato, incapace di ulteriori evoluzioni. Inoltre, non tutti gli americani poterono avvantaggiarsi in egual modo degli indubbi benefici delle riforme, ai margini rimasero in particolare categorie di per sé già fragili come le donne, i braccianti agricoli e gli afroamericani. Con riferimento a questi ultimi, inoltre, nessun intervento venne adottato al fine di contrastare il regime di discriminazione razziale negli stati del sud, così da non perdere l’ampio consenso tra l’elettorato bianco[20].
Da ultimo a scardinare inequivocabilmente ogni automatismo nella retorica crisi/rinascita si pone un’ulteriore considerazione: la ripresa definitiva dell’economia e dell’occupazione, preparata e incentivata dall’azione riformatrice, fu possibile solo grazie all’incremento dei ricavi legato all’industria bellica in conseguenza dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale[21]. Proprio quel conflitto che tra le molteplici cause annoverava la grande depressione che, contagiando il vecchio continente e imponendo l’interruzione del piano Dawes, favorì l’ascesa del regime hitleriano. Parabola, peraltro, non certo arrestata dall’isolazionismo che caratterizzò, almeno inizialmente, l’amministrazione democratica[22].
3. La (ri)nascita dell’Europa dei diritti nel secondo Novecento
Ulteriore vicenda che prima facie può essere agevolmente collocata nei confortanti confini dell’alternarsi di crisi e rinascita è quella del progressivo consolidarsi dell’unità europea a partire dal secondo dopoguerra. Anche questa volta, però, limitarsi a tale lettura, oltre che riduttivo, non agevolerebbe la comprensione dei molteplici fattori di crisi che oggi sembrano aver interrotto tale percorso.
Da un primo, ampio, angolo di visuale, infatti, gli antecedenti storici dell’unità Europea sono numerosi e ben più risalenti dei trattati degli anni Cinquanta del secolo scorso: Carlo Magno pater Europae[23], la Res pubblica christiana medievale, la persistenza secolare dello ius commune quale dimensione giuridica dal respiro continentale[24], il federalismo come via per il raggiungimento della concordia tra gli stati prospettato da Kant ne Per la pace perpetua (1795), l’Europa unificata dai cannoni e dal diritto dei codici vagheggiata da Napoleone[25], la rivoluzionaria Giovine Europa di Mazzini, gli Stati Uniti d’Europa preconizzati da Victor Hugo nel 1849[26], l’Europa guida intellettuale del mondo nel segno della filosofia invocata da Husserl[27]. Solo alcuni di molti esempi, tutti differenti per retroterra ideologico e obiettivi, ma accomunati dall’intenzione di descrivere in modo unitario il «continente dello spirito»[28].
I conflitti del Novecento funzionarono effettivamente da catalizzatore nel far sì che queste prospettive dalla mera idealità passassero alla concretezza della politica e dell’economia. Tale elemento però non può essere atomizzato né assolutizzato e va calato nel più vasto ed eterogeno concorso di cause favorevoli che caratterizzò lo scenario del secondo dopoguerra: un mosaico complesso dove ardenti desideri di pace e gli aiuti finanziari del piano Marshall (European Recovery Program) si inserirono all’interno delle rinnovate logiche geopolitiche ed economiche[29]. In questo panorama, per evitare gli insuccessi dei progetti di cooperazione internazionale maturati negli anni Venti – la Società delle nazioni (1919), i trattati di Locarno sulla sicurezza delle frontiere (1925), il Patto Briand-Kellog di rinuncia alla guerra (1928) – fu, inoltre, indispensabile la lungimiranza con cui la classe politica uscita vittoriosa dalla lotta contro il nazifascismo seppe individuare innovative prospettive di riforma e collaborazione interstatale[30]. Una visione mirabilmente sintetizzata in uno dei documenti più rappresentativi di questa stagione, la Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950[31]: il testo che ha posto le premesse per la nascita di quell’«ordinamento giuridico di nuovo genere  che oggi va sotto il nome di Unione Europea[32].
che oggi va sotto il nome di Unione Europea[32].
Le premesse sono espresse con lucidità: «L’Europe n’a pas été faite, nous avons eu la guerre»[33]; altrettanto consapevole è la via che si vuole tracciare: «L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble: elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait». Gli obiettivi sono al contempo ambiziosi e circostanziati, secondo quella logica pragmatica e graduale ma anche lungimirante che Jean Monnet e i suoi collaboratori instillarono in queste poche ma intense righe:
«Le gouvernement français propose de placer l’ensemble de la production franco-allemande de charbon et d’acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d’Europe. […] La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible.».
Nonostante le cautele, già in nuce sono individuate tutte le libertà economiche – circolazione di merci, persone, lavoratori, imprese e capitali – cui siamo ormai abituati e lungo le quali e proseguita per più di settant’anni la strada dell’integrazione europea:
«La mission impartie à la Haute Autorité commune sera d’assurer dans les délais les plus rapides: la modernisation de la production et l’amélioration de sa qualité, la fourniture à des conditions identiques du charbon et de l’acier sur le marché français et sur le marché allemand, ainsi que sur ceux des pays adhérents, le développement de l’exportation commune vers les autres pays, l’égalisation dans le progrès des conditions de vie de la main-d’œuvre de ces industries.».
Una lettura della società capace di prendere finalmente atto dei limiti dello stato nazione e archiviare così odi e revanscismi secolari, espressione di una maturità storica e politica quanto mai distante dai toni, miopi, che solo trent’anni prima avevano caratterizzato la conclusione della Grande Guerra, allorché le potenze vincitrici, nonostante i moniti dei più acuti protagonisti di quella stagione – su tutti il Keynes de The Economic Consequences of the Peace (1919) – vollero umiliare la Germania, pretesa unica responsabile delle tragedie belliche: «Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l’Allemagne reconnaît que l’Allemagne et ses alliés sont responsables […] de toutes les pertes et de tous les dommages»[34].
La dimensione europea eretta nel secondo Novecento è però ancora più ampia di quella dell’Unione. Sempre negli anni immediatamente seguenti alla guerra si sono andati, infatti, a definire anche altri documenti giuridici di grande rilevanza. Il 5 maggio 1949 nasceva a Londra il Consiglio d’Europa – un’esperienza dal tenore internazionalistico più classico rispetto l’avventura comunitaria, ma non per questo meno rilevante – all’interno della quale, il 14 novembre 1950, venne adottata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (C.E.D.U.)[35]. Un testo che ancora oggi, per il tramite della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, conforma assai profondamente le nostre vite garantendoci un orizzonte di giustizia sovrastatale.
Nessuna di queste esperienze sarebbe stata possibile, infine, se il vecchio continente non avesse potuto vantare una preziosa eredità: quella lunga stagione di riflessione sui temi della persona umana e dei suoi diritti che si è sviluppata senza soluzione di continuità, seppur al netto di evidenti contraddizioni, all’interno di una vicenda millenaria. Una tradizione che affonda le sue radici nella filosofia greca e nel diritto romano, ereditata e sviluppata dal medioevo cristiano, proseguita con la stagione giusnaturalista in epoca moderna, fatta proprio dall’Illuminismo Settecentesco e, superate le traversie dell’era contemporanea, confluita nelle costituzioni del secondo dopoguerra[36].
Emblematici, da questo punto di vista, sono gli approdi cui sono giunte le Carte fondamentali italiana e tedesca, quelle che, per evidenti contingenze storiche, hanno maggiormente avvertito l’urgenza di riaffermare la prospettiva personalistica[37]: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» (art. 2 Cost. italiana); «La dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla./Il popolo tedesco riconosce quindi gli inviolabili e inalienabili diritti dell’uomo come fondamento di qualsiasi comunità umana, della pace e della giustizia nel mondo» (art. 1, cc. 1 e 2 Cost. tedesca). Un’esperienza veramente europea che ci permette di discorrere oggi di “tradizioni costituzionali comuni” e che del vecchio continente rappresenta indubitabilmente uno dei lasciti più importanti[38].
4. Conclusioni
Questa breve incursione nella storia giuridica recente conferma come limitarsi a leggere l’attualità, di oggi e di ieri, dalla visuale endiadica crisi e rinascita non permetta di chiarire appieno le specificità e le particolari vocazioni di ogni tempo e articolare quindi risposte adeguate. L’adesione acritica a tale ermeneutica storicista finisce per ridurre la ricostruzione a effetto necessario e automatico della rovina, un avvicendarsi di causa ed effetto meccanicistico – dove al male succede necessariamente il bene – in cui l’agire umano rimane sullo sfondo, con conseguenze poco auspicabili: deresponsabilizzazione e autoassoluzione preventiva degli attori politici e del corpo sociale e conseguente limitazione della reazione all’individuazione di soluzioni dalla valenza solo superficiale e retorica[39].
Gli esempi qui evocati ci orientano, infatti, verso una lettura diversa, mostrandoci come alla crisi subentri la rinascita solo quando i grandi turbamenti della storia vengono affrontati, oltre che con una lucida comprensione dei tempi, tramite un’iniziativa pragmatica e organizzata che si traduca nell’individuazione e nel perseguimento di chiare ed energiche strategie di riforma. E che comunque, anche ciò spesso non è sufficiente, poiché le cause e concause sono molteplici e in gran parte non controllabili né predittibili.
Ciò è evidente con riferimento alle vicende poc’anzi ricordate: già si è detto dell’impossibilità di una lettura unitaria e consequenziale del New Deal, ugualmente può affermarsi per l’epopea dell’integrazione europea che, proprio a ragione della non linearità del suo procedere e dei molteplici e talora contrastanti fattori che ne hanno favorito l’avvio, è stata acutamente qualificata quale «esempio di scuola di eterogenesi dei fini»[40].
Con ciò non si vuole suggerire che sia necessario o finanche opportuno rinunciare a illuminare «il presente attraverso il passato»[41], al contrario è questa un’operazione oggi quanto mai necessaria. Sebbene, infatti, la storia non si ripeta mai secondo schemi prefissati, la dimensione esistenziale dell’uomo è sempre la stessa – l’arte e in particolare della letteratura ci testimoniano come in ogni vita si ripetono da millenni i medesimi schemi, bramosie, speranze, angosce ed eroismi – e, se non piegati a logiche oracolari, i modelli macroeconomici e sociologici, elaborati a partire dal perpetuarsi delle vicende umane, sono di sicura utilità per interpretare la realtà e organizzare l’azione politica e di riforma, in particolar modo in un mondo come il nostro che ha necessità di punti di riferimento cui ancorare la propria visione del futuro.
L’utilità e i limiti di tale operazione sono efficacemente tratteggiati da Antonio Trampus, proprio a partire da una riflessione circa «l’utilità della storia e del mestiere di storico davanti agli smarrimenti del nostro tempo»:
«La storia e il lavoro degli storici ci aiutano […] a comprendere queste mappe del tempo, che possono diventare anche mappe per soddisfare il perenne bisogno di ancorarci a punti di orientamento dinanzi ai tanti fenomeni che sfuggono alla nostra comprensione. Non si tratta di tornare all’abusato motto di Cicerone, secondo il quale la storia è maestra di vita (historia magistra vitae est), pensando che il semplice scorrere degli eventi offra già di per sé una spiegazione e una chiave del vissuto. La storia rimane sempre atto umano e interpretazione del tempo, soprattutto nel momento in cui ci racconta l’impegno dell’essere umano nel costruire percorsi rassicuranti che mettono al centro l’essere umano stesso.»[42].
Mappe, quindi. Strumenti utili solo se sapientemente interpretati da un attore umano. Se c’è, perciò, una “lezione” che possiamo timidamente tentare di trarre dall’osservazione del ripetersi delle fatiche dell’uomo è che nulla è già scritto e che ogni tempo deve mettere le sue migliori energie a disposizione dello sforzo, sempre nuovo, di ordinare la propria realtà. Fu così per gli Stati Uniti travolti dalla grande depressione e per l’Europa in macerie del secondo dopoguerra, dovrà essere così per il mondo di oggi chiamato a reagire alle molte sfide epocali che affollano senza requie la nostra quotidianità.
[1] Il presente contributo ripropone alcune riflessioni svolte in occasione delle Giornate di studio degli Assegnisti del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Genova del 15 dicembre 2020 Crisi, fratture, cambiamenti. Riflessi letterari, culturali e linguistici.
[2] «egli [Cristo], pur essendo nella condizione di Dio,/non ritenne un privilegio/l’essere come Dio,/ma svuotò se stesso/assumendo una condizione di servo,/diventando simile agli uomini./Dall’aspetto riconosciuto come uomo,/umiliò se stesso/facendosi obbediente fino alla morte/e a una morte di croce./Per questo Dio lo esaltò/e gli donò il nome/che è al di sopra di ogni nome» Fil. 2, 6-9.
[3] J. MICHELET, Histoire de France. Vol. 7, Renaissance, Paris, 1855. Sulla fortuna del termine “Rinascimento”: F. Chabod, G. Giovannoni, P. Toesca, Rinascimento, in Enciclopedia Italiana, 1936.
[4] G. MAMELI, Il canto degli italiani, 1847.
[5] S. LUCONI, La «nazione indispensabile». Storia degli Stati Uniti dalle origini a oggi, Firenze, 2016, 5 ss.
[6] Il riferimento è alla celebre opera di Eric Hobsbawm: E.J. HOBSBAWM, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century. 1914-1991, trad. it. Il secolo breve. 1914-1991, Milano, 2010.
[7] Uno scenario, al contempo tragico e complesso, che lo storico britannico Adam Tooze ha efficacemente definito “polycrisis”: A. TOOZE, Welcome to the World of the Polycrisis, in Financial Times, October 28, 2022.
[8] Il presente paragrafo, in una versione più ampia, cui ci si permette di rinviare per una più puntuale bibliografia sui temi della Grande depressione e del New Deal, appare anche in: D. COLONNA, Il New Deal di Roosevelt: il diritto davanti alla crisi, in Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza, a cura di Colonna, Oliveri, Zerbone, Genova, 2022, 31-46. Per un’epitome: ID., Diritto e crisi. Il caso del New Deal di Roosevelt, in UniGe.life, 28.10.2021.
[9] H. HOOVER, Address Accepting the Nomination. August 11, 1928 in Public Papers of the Presidents of the United States. Herbert Hoover. Containing the Public Messages, Speeches, and Statements of the President. March 4 to December 31, 1929. Washington, 1974, 503.
[10] F.D. ROOSEVELT, First Inaugural Address 1 Saturday, March 4, 1933 in Inaugural Addresses of the Presidents of the United States from George Washington 1789 to George Bush 1989. Washington D.C., 1989, 270.
[11] Il neopresidente e il suo gruppo eterogeneo di consiglieri, i c.d. newdealers o brain trust, elaborarono l’azione di riforma progressivamente, senza una pianificazione da subito ben definita. In un primo momento, le stesse teorie economiche di John Maynard Keynes, all’interno delle quali si è soliti ascrivere la loro azione, non erano particolarmente conosciute in questo ambiente. Anche lo slogan new deal nacque come espediente retorico improvvisato, con l’accezione di “nuovo patto”, durante la campagna elettorale del 1932, e dovette il suo successo all’imprevedibile favore con cui venne accolto dalla stampa: K.K. PATEL, The New Deal. A Global History, trad. it., Il New Deal. Una storia globale, Torino, 2018, 65.
[12] F.D. ROOSEVELT, First Inaugural Address 1 Saturday, March 4, 1933, cit., 270.
[13] Ibid., 271.
[14] Ibid., 271-272.
[15] Ibid., 269.
[16] A.J. BADGER, FDR: the first hundred days. New York, 2008; A. Testi, Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, 2008, 144. Il politico newyorkese rimase in carica come Presidente sino alla sua morte nel 1945, riconfermandosi vittorioso alle elezioni del 1932, del 1936, del 1940 e del 1944.
[17] K.K. PATEL, The New Deal, cit., 249-286.
[18] B. CUSHMAN, The Great Depression and the New Deal, in The Cambridge History of Law in America, Vol. III, The Twentieth Century and After (1920-), edited by Grossberg, Tomlins, Cambridge, 2008, 268.
[19] A. TESTI, Il secolo degli Stati Uniti, cit., 143; B. Cushman, The Great Depression and the New Deal, cit., 284-308.
[20] A.M. BANTI, L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Roma, Bari, 2010, 154-155.
[21] «La metafora della guerra usata da Roosevelt all’inizio del decennio per mobilitare le energie contro il nemico-depressione non bastò; per vincere quel nemico ci volle la guerra vera e propria» A. TESTI, Il secolo degli Stati Uniti, cit., 144.
[22] S. LUCONI, La «nazione indispensabile». Storia degli Stati Uniti dalle origini a oggi, Firenze, 2016, 145-149.
[23] L’epiteto Padre dell’Europa riferito al Re dei Franchi fu coniato da un anonimo poeta nel 799: A. BARBERO, Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Roma, Bari, 2004, 3-6.
[24] A. CAVANNA Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. Vol. 1, Milano, 1979, 21 ss.
[25] «Il [Napoleone] passait ensuite en revue ce qu’il eût proposé pour la postérité, les intérêts, la jouissance et le bien-être de l’association européenne. Il eût voulu les mêmes principes, le même système partout; un code européen, une cour de cassation européenne […] Une même monnaie sous des coins différents; les mêmes poids, les mêmes mesures, les mêmes lois, etc. etc. L’Europe, disait-il, n’eût bientôt fait de la sorte véritablement qu’un même peuple, et chacun en voyageant partout, se fût trouvé toujours, dans la patrie commune» E. DE LAS CASES, Mémorial de Sainte-Hélène, Tome deuxième, Paris, 1842, 144-145.
[26] «Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne […] Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d’un grand Sénat souverain qui sera à l’Europe ce que le parlement est à l’Angleterre, ce que la Diète est à l’Allemagne, ce que l’Assemblée législative est à la France!» V. HUGO, Congrès de la Paix du 21 août 1849, discours d’ouverture.
[27] «Per quanto le nazioni europee possano essere nemiche, tuttavia esse hanno una particolare affinità spirituale, che le accomuna e che travalica tutte le diversità nazionali.», «La crisi dell’esistenza europea ha solo due sbocchi: il tramonto dell’Europa […] oppure la rinascita dell’Europa dallo spirito della filosofia» E. HUSSERL, La crisi dell’umanità europea e la filosofia, 1939, in Crisi e rinascita della cultura europea, a cura di Cristin, Venezia, 1999, 54 e 91.
[28] A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. Vol. 2, Milano, 2005, 14.
[29] A. PADOA-SCHIOPPA, Verso la federazione europea? Tappe e svolte di un lungo cammino, Bologna, 2014.
[30] «La situazione richiedeva pertanto una proposta originale, una soluzione che rompesse con la prassi della politica tradizionale e facesse appello all’immaginazione e alla fantasia» G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia politica dell’Unione europea, (1926-2005), Roma, Bari, 2005, 50.
[31] Il documento prende il nome dal Ministro degli Esteri francese Robert Schuman (1886-1963), che pronunciò la Dichiarazione nel Salone dell’Orologio del Ministero degli Esteri a Parigi, il suo principale ideatore fu però Jean Monnet (1888-1979), politico ed economista, tra i più rilevanti fautori dell’integrazione europea: B. OLIVI, R. SANTANIELLO, Storia dell’integrazione europea. Dalla guerra fredda alla Costituzione dell’Unione, Bologna, 2005, 20-24. Il 9 maggio, proprio in ricordo di tale evento, si celebra ogni anno la festa della pace e dell’unità in Europa.
[32] La citazione è tratta dalla celebre sentenza della Corte di Giustizia Van Gend & Loos: «la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini.», Sentenza del 5 febbraio 1963, causa C 26/62, 3.
[33] La Déclaration Schuman du 9 mai 1950.
[34] Art. 231 Traité de paix, dit de Versailles, entre les puissances alliées et associées et l’Allemagne signé à Versailles le 28 juin 1919.
[35] G. MAMMARELLA, P. CACACE, Storia politica dell’Unione europea, cit., 34-40.
[36] P. COSTA, Diritti, in Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, a cura di Fioravanti, Bari, Roma, 2002, 37-58. Sul punto, per ulteriori riferimenti bibliografici, ci si permette di rinviare a D. COLONNA, Eguaglianza e giustizia: linearità e incongruenze nella storia giuridica occidentale, in Uguaglianza e giustizia, a cura di Ivaldi, Schiano di Pepe, Genova, 2002, 241-251.
[37] P. GROSSI, L’Europa del diritto, Bari, Roma, 2007, 249-257; P. COSTA, Diritti, cit., 55-58.
[38] Il riferimento è al concetto di “tradizioni costituzionali comuni agli stati membri” elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e recepito oggi all’art. 6, par. 3 del Trattato sull’Unione Europea (TUE): «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.». Nel quadro della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo a livello eurounitario, altro documento oggi di primaria rilevanza è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata ufficialmente a Nizza nel dicembre 2000 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e divenuta giuridicamente vincolante nell’UE con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dicembre 2009.
[39] Con riferimento non alla storia ma alla cronaca, esempio sintomatico del prevalere di una certa retorica della rinascita sulla concretezza dell’azione politica è stato il rapido diffondersi, nella prima fase pandemica (2020), di facili slogan cui non sempre ha fatto seguito l’adozione di soluzioni chiare e attuabili. Come dimenticare i centri vaccinali, presto abortiti, a forma di primula: «"L’italia (sic) rinasce con un fiore" […] "Io credo - spiega Arcuri - che abbiamo dato prova di un grande senso di comunità di fronte a una tragedia imprevedibile. Auspico che questa comunità possa ritrovarsi attorno a questo simbolo di rinascita.» V. GIANNOLI, Coronavirus, ecco la campagna per i vaccini. Arcuri: “Padiglioni a forma di fiore nelle piazze italiane per le punture”, in la Repubblica, 13 febbraio 2020. Ancor più recente l’invito alla responsabilità e quindi all’azione tramite riforma rivolto da Mario Draghi al Parlamento Europeo nella seduta plenaria del 18 febbraio 2025: «You can’t say no to everything. You ask me what’s best to do. I don’t know, but do something».
[40] M. BARBERIS, Europa del diritto, Bologna, 220.
[41] La citazione è di Jacques Le Goff: «il tempo della storia si basa su un doppio movimento: illuminando il presente attraverso il passato, ma anche il passato mediante il presente. Il passato, infatti, si comprende meglio alla luce di quello che è successo dopo ed alla luce delle questioni che pone lo storico guardando alla propria epoca.» Jacques Le Goff. Verso un nuovo Umanesimo.
[42] A. TRAMPUS, Mappe del tempo. La storia e le altre scienze moderne. Milano, 2021, 9-10.
Bibliografia
Badger, A.J., FDR: the first hundred days, New York, 2008.
Banti, A.M., L’età contemporanea. Dalla Grande Guerra a oggi, Roma, Bari, 2010 (2009).
Barberis, M., Europa del diritto, Bologna, 2008.
Barbero, A., Carlo Magno. Un padre dell’Europa, Roma, Bari, 2004.
Bibbia CEI 2008, ˂ https://www.bibbiaedu.it/CEI2008/˃.
Cavanna, A., Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Vol. 1, Milano, 1979.
Cavanna, A. Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Vol. 2. Milano, 2005.
Chabod, F., Giovannoni, G., Toesca, P., Rinascimento, in Enciclopedia Italiana, 1936.
Colonna, D., Diritto e crisi. Il caso del New Deal di Roosevelt, in UniGe.life, 28.10.2021.
Colonna, D., Il New Deal di Roosevelt: il diritto davanti alla crisi, in Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza, a cura di Colonna, Oliveri, Zerbone, Genova, 2022, pp. 31-46.
Colonna, D., Eguaglianza e giustizia: linearità e incongruenze nella storia giuridica occidentale, in Uguaglianza e giustizia, a cura di Ivaldi, Schiano di Pepe, Genova, 2002, 241-251.
Costa, P., Diritti, in Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto, a cura di Fioravanti, Bari, Roma, 2002, pp. 37-58.
Cushman, B., The Great Depression and the New Deal, in The Cambridge History of Law in America, Vol. III, The Twentieth Century and After (1920-), edited by Grossberg, Tomlins, Cambridge, 2008, pp. 268-318.
de Las Cases, E., Mémorial de Sainte-Hélène, Tome deuxième, Paris, Ernest Bourdin, 1842 (1822-1823).
Giannoli, V. 2020. Coronavirus, ecco la campagna per i vaccini. Arcuri: "Padiglioni a forma di fiore nelle piazze italiane per le punture", in la Repubblica, 13.12.2020.
Grossi, P., L’Europa del diritto, Bari, Roma, 2007.
Hobsbawm, E.J., The Age of Extremes: The Short Twentieth Century. 1914-1991, 1994, trad. it. Il secolo breve. 1914-1991, Milano, 2018 (2000).
Hoover, H.C., Address Accepting the Nomination. August 11, 1928, in Public Papers of the Presidents of the United States. Herbert Hoover. Containing the Public Messages, Speeches, and Statements of the President. March 4 to December 31, 1929, Washington, 1974 (1928), pp. 497-520.
Hugo, V., Congrès de la Paix du 21 août 1849, discours d’ouverture, 1849.
Husserl, E., La crisi dell’umanità europea e la filosofia in Crisi e rinascita della cultura europea, a cura di Cristin, Venezia, 1999 (1935).
Kant, I., Per la pace perpetua, Milano, 2013 (1975).
Le Goff, J., Verso un nuovo Umanesimo. Il tempo della storia, 2014, .
Keynes, J.M., The Economic Consequences of the Peace, New York, 1920 (1919).
La Déclaration Schuman du 9 mai 1950, .
Luconi, S., La «nazione indispensabile». Storia degli Stati Uniti dalle origini a oggi. Firenze, 2016.
Mammarella, G., Cacace, P., Storia politica dell’Unione europea, (1926-2005). Roma, Bari, 2005.
Michelet, J., Histoire de France. Vol. 7, Renaissance, Paris, 1855.
Olivi B., Santaniello R., Storia dell’integrazione europea. Dalla guerra fredda alla Costituzione dell’Unione, Bologna, 2005.
Padoa-Schioppa, A., Verso la federazione europea? Tappe e svolte di un lungo cammino. Bologna, 2014.
Patel, K.K., The New Deal. A Global History, 2016, trad. it. Il New Deal. Una storia globale, Torino, 2018.
Roosevelt, F.D., First Inaugural Address. Saturday, March 4, 1933, in Inaugural Addresses of the Presidents of the United States from George Washington 1789 to George Bush 1989, Washington D. C., 1989 (1933), pp. 269-273.
Testi, A., Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, 2008.
A. Tooze, Welcome to the World of the Polycrisis, in Financial Times, 28.10.2022.
Trampus, A., Mappe del tempo. La storia e le altre scienze moderne, Milano, 2021.

