Pubbl. Mar, 25 Mar 2025
Pensione di reversibilità per le coppie omoaffettive e i figli nati da maternità surrogata: le questioni sollevate dalla Corte di cassazione
Modifica pagina
Giorgia Ferraro
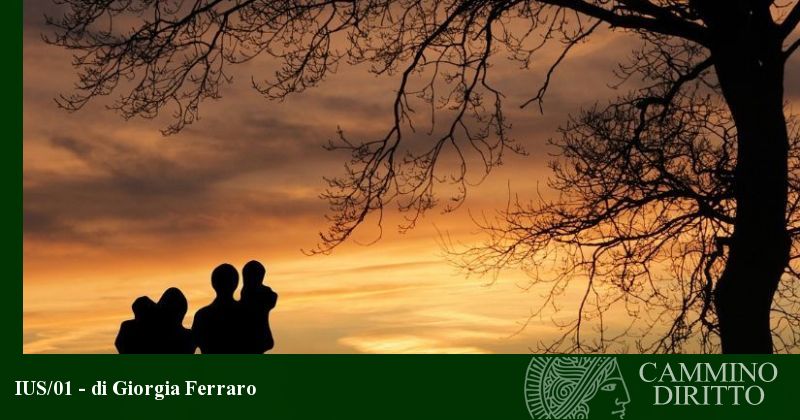
La sentenza in commento (C. di cass., Sez. lav., ord. del 21 agosto 2024, n. 22992) affronta il tema del diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di un’unione omoaffettiva, anche alla luce della legge n. 76/2016. Nonostante i progressi, persistono incertezze normative, soprattutto in relazione alla retroattività della norma e al riconoscimento dei diritti per situazioni preesistenti, sollevando rilevanti questioni giuridiche. Di conseguenza, la Sezione lavoro ha disposto la trasmissione della sentenza alla Prima Presidenza, affinché la questione venga assegnata alle Sezioni Unite per una sua definitiva risoluzione.
 ENG
ENG
The Reversibility Pension for Homosexual Couples and Children Born from Surrogacy: The Questions Raised by the Court of Cassation
The sentence in question (C. di Cass., Sez. Lav., order of 21 August 2024, n. 22992) addresses the issue of the right to a reversibility pension for the surviving partner of a homoemotional union, also in light of the law n.76/2016. Despite progress, regulatory uncertainties persist, especially in relation to the retroactivity of the law and the recognition of rights for pre-existing situations, especially relevant legal issues. Accordingly, the Labor Section has directed that the ruling be forwarded to the First Presidency so that the matter can be assigned to all United Sections for final resolution.Sommario: 1. Il diritto alla pensione indiretta per il partner superstite di un'unione omoaffettiva; 2. La tutela del figlio minore nato da maternità surrogata; 3. Il rifiuto dell’INPS e la questione discriminatoria; 4. Conclusioni.
1. Il diritto alla pensione indiretta per il partner superstite di un'unione omoaffettiva
La legge n. 76 del 2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha rappresentato un passo fondamentale per la tutela dei diritti delle coppie omosessuali in Italia. In particolare, l’articolo 1, comma 20, stabilisce che il partner superstite di un’unione civile ha diritto alla pensione di reversibilità, garantendo così un trattamento giuridico equiparato a quello delle coppie eterosessuali.
Nonostante l’importanza di questa conquista normativa, persistono rilevanti lacune, in particolare riguardo alla retroattività della norma, che ha suscitato ampi dibattiti giurisprudenziali.
La prima problematica concerne l’estensione del diritto alla pensione di reversibilità al partner superstite di un’unione civile, nel caso in cui il decesso del partner sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge.
Come noto, le leggi non hanno effetto retroattivo, salvo disposizioni esplicite in tal senso. Pertanto, qualora la normativa non preveda espressamente disposizioni per situazioni antecedenti alla sua entrata in vigore, risulta complesso estendere i benefici della pensione indiretta a casi precedenti l’introduzione della legge.
Il caso esaminato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è relativo al riconoscimento della pensione indiretta a L.D.M., partner superstite di una coppia unita civilmente, il cui compagno D.C., era deceduto prima dell'entrata in vigore della legge n. 76/2016.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 803/2020, ha inizialmente riconosciuto il diritto alla pensione indiretta, interpretando la legge in un’ottica di parità di trattamento tra coppie coniugate e coppie unite civilmente. Secondo questa pronuncia, il trattamento pensionistico di reversibilità deve essere ricondotto ai diritti e doveri di solidarietà e assistenza reciproca tipici delle relazioni di coppia, comprese quelle omoaffettive.
Tuttavia, tale pronuncia ha cercato di interpretare in maniera più estesa quello che è il diritto alla vita familiare, anche alla luce dei principi di uguaglianza e protezione delle relazioni affettive, sostenendo che, in determinati casi, il beneficio della pensione di reversibilità potrebbe essere esteso anche a situazioni antecedenti, qualora venga dimostrata l’esistenza di una convivenza stabile e duratura. Tale visione attribuisce valore anche alla convivenza di fatto, conferendo certamente un riconoscimento giuridico alle relazioni omoaffettive.
Nel caso di specie, diversamente dal giudice di merito, la Corte di cassazione, invece, ha sollevato dubbi sull’applicazione retroattiva della legge, ritenendo che solo una norma espressa potrebbe giustificare il riconoscimento dei diritti per le unioni civili antecedenti al 2016. La salvaguardia della certezza giuridica in relazione agli status familiari implica, infatti, che la legge non possa estendersi ai periodi precedenti la sua promulgazione.
2. La tutela del figlio minore nato da maternità surrogata
La seconda questione sottoposta alle Sezioni Unite della Corte di cassazione affronta il tema del diritto alla pensione di reversibilità per il figlio minore nato tramite maternità surrogata, nel caso specifico di decesso del genitore intenzionale.
Tale problematica richiede una sintetica ricognizione della normativa italiana, tenendo conto delle specificità del caso in esame. In particolare, è necessario esaminare il sistema delle disposizioni normative che disciplinano i diritti dei minori e i benefici previdenziali.
L'Italia, in conformità con la legge n. 40 del 2004, ha finora escluso la surrogazione di maternità, vietando severamente l’utilizzo di pratiche di procreazione assistita eterologa. Tale divieto trova fondamento in una concezione tradizionale della famiglia, che pone in rilievo il legame biologico tra madre e figlio, con l’intento di preservare la maternità da un'eventuale mercificazione.
Un aspetto rilevante è la componente religiosa: nonostante lo Stato italiano sia laico, la forte influenza della Chiesa nel dibattito pubblico ha contribuito a orientare l’opinione pubblica [1] e, di riflesso, la legislazione nazionale, mantenendo il divieto di maternità surrogata. Sebbene l'assenza di una normativa specifica sulla maternità surrogata nell'ordinamento italiano non possa essere direttamente ricondotta ad uno o più interventi di un Pontefice, è innegabile che la Chiesa cattolica eserciti una forte influenza sul dibattito etico e culturale [2].
Tuttavia, a fronte di questa premessa, non mancano interventi giurisprudenziali che, con visioni innovative, sollevano dubbi applicativi.
Un esempio significativo si è avuto nel gennaio 2021, quando la Corte d'Appello di Milano ha emesso la pronuncia in commento, riconoscendo il diritto alla pensione di reversibilità non solo al coniuge superstite, ma anche a suo figlio minore, avuto tramite maternità surrogata. Questa decisione si è distinta poiché la giurisprudenza di merito aveva già riconosciuto il diritto alla reversibilità al coniuge superstite di una coppia unita civilmente, ma mai al figlio qualificato come "non biologico".
Avverso tale pronuncia è stato promosso ricorso per Cassazione, che ha sollevato la questione alle Sezioni Unite, vista la sua complessità: è possibile garantire al minore il diritto alla pensione di reversibilità, in un contesto in cui la maternità surrogata è vietata dall'ordinamento italiano?
Il tema centrale di tale discussione riguarda la tutela degli interessi del minore, in particolare il rispetto della sua identità, che si fonda anche sul legame con il genitore intenzionale.
La domanda che emerge è come l’ordinamento possa conciliare il rispetto per tale legame con il divieto legislativo della maternità surrogata e le altre disposizioni normative in materia di previdenza sociale.
Gli interessi in gioco sono molteplici e, in assenza di un intervento normativo è rimessa alla Giurisprudenza il compito di bilanciare le esigenze di tutela del minore e i principi fondamentali dell’ordinamento italiano.
3. Il rifiuto dell’INPS e la questione discriminatoria
La terza questione riguarda il rifiuto opposto dall’INPS circa il mancato riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità suindicati soggetti e se tale omissione possa qualificarsi come condotta discriminatoria alla luce della normativa nazionale.
La mancata concessione di tale diritto solleva interrogativi sulla possibile discriminazione, soprattutto alla luce della legge n. 76/2016, che ha introdotto una significativa innovazione legislativa, ma che, al contempo, lascia spazio a varie interpretazioni.
Seguendo il ragionamento prospettato da parte ricorrente, l'assenza di tutela e il mancato riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità potrebbero compromettere la credibilità della legge n. 76/2016, la cosiddetta legge Cirinnà, che rappresenta un passo significativo nel panorama legislativo e culturale italiano. Limitare tali diritti, tuttavia, solleverebbe indubbiamente questioni di legittimità costituzionale, in quanto potrebbe apparire contraddittorio riconoscere diritti essenziali ma al contempo escludere alcune categorie di beneficiari.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con una recente pronuncia (Sentenza n. 15 del 2024), ha chiarito che, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, si configura discriminazione solo in presenza di una violazione esplicita della legge. Nel caso in cui una legge non contempli disposizioni specifiche per situazioni particolari – come quelle che riguardano coppie non coniugate o figli nati tramite maternità surrogata – non può ritenersi discriminatoria l’esclusione di tali soggetti dal trattamento di reversibilità. In altre parole, l'assenza di una previsione esplicita nella legge non implica necessariamente una violazione dei principi di uguaglianza e non può essere automaticamente qualificata come discriminatoria, a meno che non emerga una violazione esplicita dei diritti stabiliti dalla normativa vigente. Pertanto, in assenza di disposizioni specifiche, la questione resta aperta alla valutazione della giurisprudenza, che dovrà interpretare il quadro normativo alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.
4. Conclusioni
In conclusione, sulle tre questioni citate ed analizzate, e sui cui è ancora fortemente dibattuta la Giurisprudenza, emerge l’esigenza di comporre un sistema normativo più chiaro e coerente, che rispetti i principi di uguaglianza e di protezione delle relazioni familiari, in particolare quelle omoaffettive e minorili, anche alla luce dei principi della Carta costituzionale delle altre Carte Internazionali. Ed è proprio partendo dal caso di specie che si auspica ad una decisone giurisprudenziale in cui si riesca a garantire una tutela sistematica e non frazionata degli interessi coinvolti: del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia considerando l’evoluzione delle strutture familiari e la necessità di garantire diritti fondamentali come quello della pensione di reversibilità, in modo equo e inclusivo.
[1] Un esempio significativo dell'influenza della Chiesa cattolica nel plasmare il dibattito politico italiano, in particolare su temi etici, è chiaramente dimostrata dalla pubblicazione del documento "Dignitas infinita circa la dignità umana" del Dicastero per la Dottrina della Fede nell'aprile 2024. Questo documento condanna fermamente la maternità surrogata, definendola una pratica che viola la dignità umana. La forte presa di posizione del Vaticano, ribadita da Papa Francesco nel suo discorso agli ambasciatori, ha un impatto significativo sul dibattito pubblico e politico italiano.
[2] Garelli, F., Religion Italian style: Continuities and changes in a catholic country (2016), pp. 1-223.

