Pubbl. Lun, 6 Lug 2020
Il fenomeno del social dumping nella prospettiva dell´Unione europea
Modifica pagina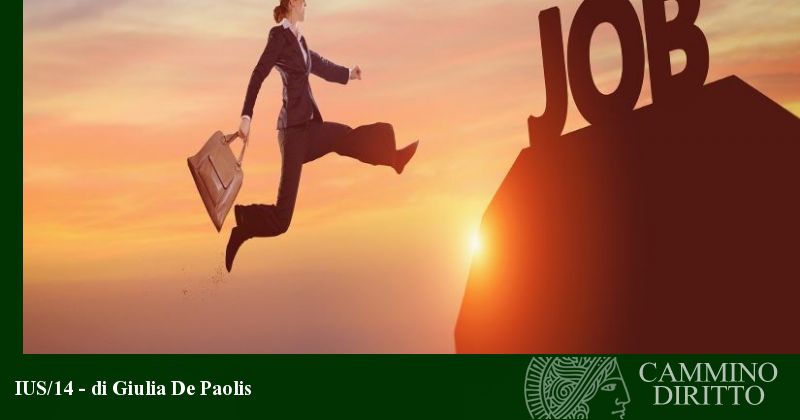
Il fenomeno del Social Dumping nella prospettiva dell´Unione Europea. Nel commercio internazionale, il termine dumping, sta a sottolineare la discriminazione dei prezzi tra mercati nazionali. Vi sono diversi tipi di dumping. Quanto al Social Dumping, l’elemento da cui deriva il fenomeno è rappresentato dalle differenze di regolamentazione sociale proprie dei singoli ordinamenti che, di converso, determinano (direttamente o indirettamente) diversità di costi del fattore lavoro.
 ENG
The phenomenon of Social Dumping in EU perspective. In International trade, ”Dumping” is traditionally defined as price discrimination between national markets. There are different types of dumping. Regarding the social dumping, we can say that this phenomenon is represented by the differences in social regulations that characterise the legal systems of individual Member States that cause remarkably diversity in labour costs.
ENG
The phenomenon of Social Dumping in EU perspective. In International trade, ”Dumping” is traditionally defined as price discrimination between national markets. There are different types of dumping. Regarding the social dumping, we can say that this phenomenon is represented by the differences in social regulations that characterise the legal systems of individual Member States that cause remarkably diversity in labour costs.Sommario: 1. Nozione generale di Dumping. 2. Social dumping e delocalizzazione. 3. Verso la costruzione di un'Europa sociale. 4. Conclusioni.
1. Nozione generale di Dumping.
Nel commercio internazionale, il termine dumping, sta a sottolineare la strategia e conseguente pratica di immettere nel mercato prodotti di un Paese ad un prezzo inferiore rispetto al valore normale del prodotto stesso.
Già Oddone Fantini, nel Novissimo Digesto, definiva il dumping quale la pratica secondo cui un prezzo o un sistema di prezzi viene adottato per conquistare o dominare un mercato estero, eliminando imprese o gruppi di imprese concorrenti.
Tale prezzo, generalmente molto più basso di quello praticato negli scambi all’interno, può essere talvolta anche inferiore al costo di produzione.
È possibile notare come la definizione stessa di dumping si sia evoluta nel corso degli anni, da “practice of selling a good for export at a price below that charged for the identical good in the exporting country”[1] a “offering a product for sale in export markets at a price below normal value”[2].
Per determinare l’esistenza del dumping è necessario che l’autorità inquirente del Paese di importazione effettui una comparazione tra il valore normale del bene ed il suo prezzo di esportazione.
Qualora il valore normale del bene sia inferiore al prezzo di esportazione, sarà dimostrata l’esistenza del dumping (PE sua esistenza, essa si divide essenzialmente in cinque stadi:
-
determinazione del prezzo di esportazione del prodotto;
-
indicazione del valore normale del prodotto;
-
netting back (adeguamento necessario tra prezzo d'esportazione e prezzo normale);
-
comparazione dei valori di riferimento;
-
calcolo del margine di dumping.
Una volta portate a termine tali procedure, sarà necessario verificare la presenza degli altri elementi richiesti dall’Anti-dumping agreement, per giustificare l’applicazione delle misure antidumping.
Per valore normale deve intendersi il prezzo praticato all’interno del Paese di origine delle merci, mentre nel caso di prodotti provenienti da Paesi non retti da un’economia di mercato, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un Paese terzo a economia di mercato, o al prezzo per l’esportazione da tale Paese terzo ad altri Paesi.
Pertanto, determinando una discriminazione internazionale dei prezzi, il dumping è spesso considerato come una forma di concorrenza sleale e quindi una barriera al commercio internazionale.
2. Social dumping e delocalizzazione.
Quanto al Social Dumping, sebbene ad oggi questa particolare forma di dumping non disponga di autonoma disciplina negli accordi che regolano gli scambi commerciali multilaterali, né sembra si possa ricorrere all’ausilio dell’art. VI del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), l’espressione interiorizza molteplici aspetti di una comune matrice problematica.
Benché con la stessa si faccia riferimento a fenomeni diversi[4], quali l’importazione di prodotti provenienti da stati in cui esistono condizioni lavorative non dignitose secondo i parametri occidentali, ovvero le prestazioni di servizi transfrontalieri in cui le imprese utilizzano manodopera meno costosa di quella locale, ovvero, ancora, la delocalizzazione della produzione in ambiti caratterizzati da livelli remunerativi e regimi normativi più favorevoli, l’elemento da cui deriva il fenomeno pare, in ultima analisi, rappresentato dalle differenze di regolamentazione sociale proprie dei singoli ordinamenti che, di converso, determinano (direttamente o indirettamente) diversità di costi del fattore lavoro.
Si condivide la dottrina per la quale la matrice del social dumping è da identificarsi nell’utilizzo (o, per meglio dire, sfruttamento) da parte delle imprese di tali differenze per localizzare e distribuire le relative attività produttive e commerciali; utilizzo che, a sua volta, tende ad orientare i legislatori nazionali verso un progressivo abbassamento dei livelli delle garanzie sociali, finalizzato a mantenere un adeguato livello di competitività dei singoli sistemi-paese, in coerenza con i principi della competizione regolativa.
Di tale meccanismo è espressione a livello globale la tendenza antiprotezionistica dei Developing countries - sintonica ad un’integrazione economica mondiale che appare più sensibile alla produttività ed alla redditività che alla dignità umana – nonché, a livello europeo, l’affermazione delle libertà di mercato (libertà di stabilimento, di prestazione dei servizi, di circolazione delle merci) che, supportate dal principio della preminenza del diritto comunitario, favoriscono l’uso/abuso delle differenze normative proprie di singoli ordinamenti nazionali ed assoggettano vasti ambiti del diritto privato e di quello pubblico degli Stati membri alle regole del mercato concorrenziale sulla base di un puro market oriented approach.
Dunque, con l’accezione social dumping si è soliti indicare il vantaggio competitivo acquisito da un’impresa rispetto ad altre, derivante dal differenziale dei costi di produzione esistente nei diversi Paesi e dovuti alla disuguale tutela del lavoro e dei lavoratori prevista dalle normative nazionali.
Tali costi produttivi ridotti sono spesso conseguenza dello sfruttamento della manodopera o dell’inosservanza delle regole di sicurezza sul lavoro rispettate, invece, in altri Stati.
La globalizzazione e, più in particolare, la recente delocalizzazione della produzione industriale nel territorio di un ben individuato gruppo di Paesi emergenti, ha creato uno dei problemi più complessi con il quale il sistema degli scambi commerciali è ora chiamato a confrontarsi[5].
Alcuni Stati, caratterizzati da legislazioni interne scarsamente sensibili ai problemi dell’adeguata remunerazione dei lavoratori, della sicurezza e dell’igiene del lavoro (perciò all’integrità fisica del lavoratore) attraggono più facilmente gli investimenti stranieri.
Sono proprio tali Paesi ad offrire ai produttori la possibilità di fornire beni ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello praticato dai concorrenti che operano in Paesi la cui legislazione è invece attenta alla sicurezza del lavoro e garantisce il diritto al lavoro, inteso non soltanto nella ristretta accezione di diritto ad un posto di lavoro, ma anche come stabilità di occupazione, giusta retribuzione e integrità fisica del lavoratore.
Di conseguenza, il rispetto delle condizioni di lavoro, intese non solo come mera applicazione delle norme di sicurezza ma anche come adozione di tutte quelle misure idonee a tutelare l’integrità fisica e morale della persona, porta l’impresa, indubbiamente, a sostenere ingenti costi aggiuntivi.
Al fine di sottrarsi ai costi relativi alla tutela del lavoratore e fronteggiare una concorrenza internazionale sempre più agguerrita, gli imprenditori operanti in Paesi con una legislazione particolarmente sensibile alle questioni attinenti alla sicurezza del lavoro e alla tutela della dignità umana, ricorrono sempre più frequentemente alla delocalizzazione dei propri apparati produttivi, trasferendoli così in paesi meno sensibili a tali problemi o comunque Paesi in cui leggi e controlli sull’impiego del lavoro minorile, sull’orario di lavoro ovvero in materia di salute, di sicurezza ed equa retribuzione della manodopera sono meno attenti o, per così dire, più tolleranti rispetto a quelli vigenti in altre nazioni.
Perciò la delocalizzazione della produzione, determina il trasferimento della stessa nel territorio di Stati in cui sono previsti costi inferiori.
Tale fenomeno è stato oggetto di studio ed analisi da parte di numerosi esperti del diritto e di economia internazionale.
3. Verso la costruzione di un'Europa sociale.
La definizione di una clausola sociale[6] all’interno dell’Uruguay Round, con l’intento esplicito di porre rimedio al fenomeno del social dumping non ha avuto il successo sperato.
L’obiettivo perseguito con tale clausola, che in parte ricalcava quanto previsto sul tema dalla Carta dell’Avana, era di costringere i Paesi ad adottare e rispettare standard minimi di tutela dei lavoratori e, in caso di violazione degli stessi, di consentire ritorsioni commerciali nei confronti degli inadempienti.
Tale proposta suscitò subito le reazioni dei DC, secondo i quali la clausola in questione avrebbe ostacolato le esportazioni dei Paesi che erano in condizioni di produrre beni a basso costo, incidendo negativamente sulla loro capacità competitiva sul mercato.
Una forma di tutela delle condizioni di lavoro, ancorché non sperimentata, fu prevista nel progetto presentato dal gruppo di lavoro del Consiglio dell’ILO, quando fu avanzata la proposta di istituire un Comitato Consultivo Congiunto WTO/ILO, con il compito di valutare il rispetto dei labour standard previsti dalla clausola sociale.
Fu previsto che, ove uno Stato avesse violato tale clausola, il Comitato avrebbe potuto inviargli una “raccomandazione”; che decorso un certo periodo, non superiore a due anni, sarebbe stato poi redatto un nuovo rapporto sul comportamento dello Stato inadempiente; che in caso di protratto inadempimento, lo Stato inosservante sarebbe stato, infine, deferito all’Organo per la soluzione delle controversie della WTO, per l’eventuale applicazione di contromisure di carattere commerciale[7].
A tale proposta fece seguito l’opposizione dei Developing countries, i quali sostennero che una clausola sociale non solo avrebbe limitato la loro sovranità, ma soprattutto avrebbe comportato il rischio che i Paesi più industrializzati avrebbero potuto utilizzare tale meccanismo per attuare misure protezionistiche dei loro mercati.
La Comunità Europea ha adottato il primo Regolamento Antidumping nel 1968, largamente basato sulla falsariga del GATT Antidumping Code del 1967.
Si occupa, tuttavia, di ripartire le competenze in materia tra la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri. Il regolamento subì notevoli modifiche nel corso degli anni.
Con tali modifiche furono recepiti principi enunciati nelle sentenze della Corte di Giustizia e vennero uniformate regole della normativa CE a quelle internazionali.
L’esigenza di adottare una disciplina antidumping unitaria, a livello internazionale, sentita da tutti, andò affievolendosi con lo scoppio della prima guerra mondiale che distolse l’attenzione degli Stati dai problemi riguardanti il commercio internazionale.
L’interesse verso una regolamentazione internazionale dell’antidumping riemerse, tuttavia, al termine del conflitto, con la ripresa degli scambi commerciali.
Fu allora che divennero concreti i primi tentativi di giungere ad una normativa internazionale dell’antidumping, attraverso la concertazione multilaterale.
In tal senso, l’esempio più rilevante delle intenzioni degli Stati di giungere ad una disciplina internazionale della materia è rappresentato dalla Conferenza di Ginevra del 1922. Il 24 marzo del 1948, nel corso dell’ultima conferenza, tenutasi presso le Nazioni Unite, i cinquantasei Stati partecipanti sottoscrissero all’Avana l’accordo istitutivo dell’ITO.
Con tale accordo fu prevista la creazione di un’istituzione internazionale per gestire e controllare i problemi del commercio internazionale inclusi l’erogazione di sovvenzioni statali alle imprese e l’antidumping, che avrebbe, quindi, sostituito il GATT.
Ed inoltre tale statuto prevedeva anche norme volte all’occupazione, allo sviluppo economico e ad accordi di produzione e di investimenti esteri.
Tale accordo internazionale venne firmato con l’obiettivo di stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.
Negli anni successivi, l’accordo fu sottoposto a molteplici revisioni da parte dei firmatari. Uno dei principali ostacoli all’attuazione uniforme del GATT venne da una clausola in esso contenuta, rimasta in vigore fino al 1994, ossia la “grandfather clause”.
Quest’ultima limitava la sua applicazione ai soli Stati che non si fossero già dotati di una disciplina in materia. Ulteriore passo in avanti fu rappresentato dalla sottoscrizione, nel 1967, dell’Agreement on Interpretation of Article VI (AD Code[8]).
L’AD Code 1967 prescrisse inoltre la costituzione di un Permanent Committee on Antidumping Practices con il compito di risolvere le controversie tra gli Stati Parte e di inviare raccomandazioni agli stessi affinché modificassero le loro normative interne per renderle conformi alle previsioni della predetta disciplina nonché di vigilare sull’osservanza, da parte degli Stati, di tali raccomandazioni.
In conseguenza della mancata ratifica dell’accordo da parte degli Stati Uniti, l’AD Code 1967 non ebbe mai completa attuazione. Successivamente, nel 1979 fu stipulato un nuovo Agreement on Implementation of Article VI of the GATT con il quale furono apportate sostanziali modifiche al precedente AD Code 1967 in tema di pregiudizio e di determinazione del danno, di vendite sottocosto, di nesso di causalità e di modalità di applicazione e di riscossione di dazi antidumping.
Con l’art. 15 del nuovo AD Code 1979 fu prevista una particolare procedura di Consultation, Conciliation, and Dispute Settlement, destinata a operare nell’ipotesi in cui uno degli Stati firmatari avesse ritenuto di essere stato danneggiato, nei suoi interessi commerciali, dall’attività di un altro Stato.
Soltanto nel 1991 si raggiunse un accordo tra gli Stati quando il Direttore Generale del GATT, Dunkel, elaborò un disegno che raccolse il consenso degli Stati, in occasione della Conferenza Ministeriale di Marrakech.
Il nuovo accordo fu frutto di una diligente e non agevole opera di mediazione svolta dal Dunkel[9]. Le contrastanti richieste degli Stati trovarono un punto d’incontro, giungendo così all’emanazione del nuovo Agreement on Implementation on Article VI of GATT (ADA).
È con la dichiarazione di Marrakech del 1994 che si segnò formalmente la fine dell’Uruguay Round.
Quasi cinquant’anni dopo il fallimento dell’ITO, gli Stati membri raggiunsero l’accordo per l’istituzione dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, organismo internazionale con il compito di incrementare gli scambi commerciali tra gli Stati, di eliminare i dazi doganali e di vigilare sul rispetto delle norme internazionali in materia.[10]
La necessità di porre un freno all’esercizio del potere sovrano e incondizionato degli Stati in campo economico fu uno degli obiettivi principali perseguiti dalla WTO con l’emanazione di un insieme di regole univoche finalizzate alla liberalizzazione degli scambi commerciali.
Altro elemento innovativo riguardava l’ingresso di molti Developing Countries nella WTO. Si rese, quindi, necessario creare una nuova e più ampia normativa del commercio internazionale.
Il WTO Agreement non si limitò alla creazione della World Trade Organization, ma riguardò anche l’accordo sulle tariffe doganali sul commercio dei beni (GATT), ed introdusse nuovi accordi sullo scambio dei servizi (GATS). Con l’adesione alla WTO, lo Stato membro accettava tutti gli accordi in esso contenuti.
Fu inoltre istituito un nuovo organo, con il compito di vigilare sul commercio dei beni, il Council for Trade in Goods. Con il trattato in esame venne anche istituito un Segretariato, con sede a Ginevra, retto da un Direttore generale, con il compito di favorire l’attuazione degli accordi[11]. Il testo dell’ADA scaturito dai negoziati dell’Uruguay Round è la normativa tuttora vigente che regola la possibilità per uno Stato di reagire contro le esportazioni oggetto di dumping provenienti da un altro Paese, applicando misure antidumping.
4. Conclusioni
L’allargamento dell’Unione europea ha fatto emergere la necessità e l’urgenza di creare un sistema integrato di relazioni industriali, nell’ambito del cosiddetto modello sociale europeo.
Come emerge dalla disamina sinora svolta, tuttavia, a causa della notevole eterogeneità riscontrabile tra i vari sistemi nazionali, è risultata di difficile attuazione un’armonizzazione in campo lavoristico.
Il dialogo sociale europeo ha subito un lento processo di erosione e ha portato a valorizzare strumenti di soft law. Nello scenario delle nuove tecniche regolative in funzione anti dumping sociale, merita di essere menzionata la cd. Corporate Social Responsibility (CSR), definita nel Libro verde della Commissione europea (2001) quale integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali (...) delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate.
Essa si pone in un contesto in cui vi è assenza di un sistema giuridico nazionale e sovranazionale capace di contrastare gli effetti negativi della concorrenza regolatoria e del social dumping.
In conclusione, è possibile affermare che, in un contesto in cui il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali non hanno ancora esercitato pienamente i propri effetti per quel che attiene un equilibrio tra diritti fondamentali e diritti economici, l’Unione europea dovrebbe impegnarsi con misure concrete, idonee a realizzare pienamente il potenziale del mercato interno e a prevenire il rischio di una corsa al ribasso delle regole (a race of laxity).
[1] L.Z. Lawrence, Brookings trade forum, Washington, 2010, p. 59.
[2] A. Lasagni, Does Country-Targeted Anti-dumping policy by the EU create trade diversion?, in Journal of World Trade, Kluwer Law International, 2000, p. 139.
[3] Per PE si intenda il prezzo di esportazione, mentre per VN il valore normale.
[4] Uno studio dell’ETUI (European Trade Union Institute) descrive il social dumping come “the practice, undertaken by self-interested market participants, of undermining or evading existing social regulations with the aim of gaining competitive advantage”; Marianne Tyssen, European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, in the context of parliamentary question (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-008441&language=EN) del 14 August 2015 “there is no definition of the concept of “social dumping”. The term is generally used to unfair competition due to the application of different wages and social protection rules to different categories of workers”.
[5] F. Beveridge, Globalization and International Investment, Ashgate, Aldershot, 2005.
[6] Una clausola sociale inserita in un accordo prevede la possibilità di restringere o bloccare le importazioni provenienti da Stati o imprese in cui la tutela del lavoratore sia inferiore ai livelli minimi previsti dai labour standards. G. Porro, Studi di diritto di economia internazionale, cit., p. 233.
[7] P.V. Dijck e G. Faber, Challenges to the New World Trade Organisation, Kluwer Law International, Boston, 1996, p. 260.
[8] AD Code sta per Antidumping Code.
[9] T.P Stewart, The GATT Uruguay Round: a Negotiating History 1986-1994 Vol. II, Kluwer Law International, Boston, 1993, cit., p. 1519.
[10] S.M. Carbone, R. Luzzato, A. Santa Maria, Istituzioni di diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2003, p. 470.
[11] P. Picone, A. Ligustro, Diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, p. 36 ss.

