Pubbl. Lun, 18 Ago 2025
Rapina impropria e omicidio volontario: il difficile dialogo tra nesso teleologico e principio di specialità alla prova delle Sezioni Unite
Gabriele Ferro
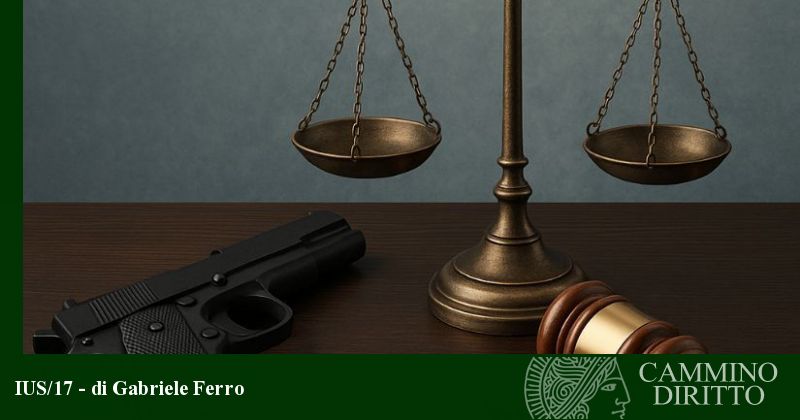
Il presente contributo analizza la questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con Ordinanza n. 23353 del 23.06.2025, concernente la possibilità di applicare la circostanza aggravante del nesso teleologico in relazione al delitto di rapina impropria seguito dalla morte della persona offesa. Premessa una sintetica ricognizione degli istituti giuridici in rilievo, l´analisi si sofferma sul contrasto interpretativo insorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, evidenziandone le ricadute sistemiche ed applicative, per poi approdare all´auspicio che il Supremo Consesso sappia coniugare l´esigenza di assicurare una risposta sanzionatoria proporzionata con quella che impone di modellare il sistema penale secondo l´irrinunciabile principio di legalità.
Sommario: 1. Premessa; 2. Prolegomeni: la struttura della rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico; 3. Il contrasto interpretativo; 4. Conclusioni.
1. Premessa
Con Ordinanza del 23 giugno 2025, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha deferito al vaglio delle Sezioni Unite una questione ermeneutica foriera di significative ricadute applicative in tema di trattamento sanzionatorio, avente il seguente tenore: «se, in caso di rapina o tentata rapina impropria in cui la violenza abbia cagionato la morte della persona offesa, rispetto al delitto di omicidio volontario sia configurabile l’aggravante del nesso teleologico ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.».
La rilevanza della questione – come opportunamente evidenziato dallo stesso Collegio rimettente[1] – trascende il profilo meramente qualificatorio del fatto-reato, proiettandosi incisivamente tanto sul trattamento sanzionatorio applicabile, quanto sulla concreta accessibilità al rito alternativo normativamente contemplato dagli artt. 438 e ss. c.p.p.
L’applicabilità della circostanza aggravante in parola comporterebbe, infatti, alla luce del disposto di cui all’art. 576, n. 1, c.p., l’irrogazione della pena dell’ergastolo per il delitto di omicidio e, per l’effetto, l’impossibilità per l’imputato, ai sensi dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p., di accedere alla disciplina giudizio abbreviato, con conseguente esclusione dei connessi benefici in termini di deflazione processuale e di riduzione sanzionatoria.
2. Prolegomeni: la struttura della rapina impropria e l’aggravante del nesso teleologico
Prima di analizzare più nel dettaglio i diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi in merito alla vexata quaestio oggetto del provvedimento remissivo, appare opportuno, sia pure in via sintetica, muovere da una propedeutica ricognizione degli istituti giuridici ad essa sottesi, a partire dalla disciplina del delitto di rapina impropria (art. 628 co. 2 c.p.).
Tale fattispecie delittuosa, com’è noto, punisce la condotta di chi «adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità».
Malgrado la medesima collocazione topografica, la rapina impropria presenta un'architettura dogmatica marcatamente eterogenea rispetto all’ipotesi delittuosa disciplinata dal primo comma dell’art. 628 c.p.
La principale differenza rispetto a quest’ultima, invero, risiede nel fatto dell’essere la prima ontologicamente concepita secondo un impianto strutturale cronologicamente rovesciato, in cui, cioè, la condotta violenta o minacciosa, anziché costituire il mezzo diretto a recidere il rapporto di signoria tra la res e il precedente detentore, figura quale strumento funzionalmente orientato a consolidare il possesso, ovvero a garantire l’impunità del soggetto agente.
Sempre sul piano oggettivo, inoltre, è necessario che tale contegno coercitivo si esplichi «immediatamente dopo la sottrazione».
Con riguardo a quest’ultimo requisito, è pressoché unanime, in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte, l’orientamento secondo cui lo stesso debba essere interpretato alla luce delle categorie processuali di flagranza e quasi flagranza[2], nel senso che non è necessaria una perfetta corrispondenza temporale tra la sottrazione e la condotta coercitiva, risultando «sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta a impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o ad assicurare al colpevole l'impunità»[3].
Quanto al profilo dell’elemento psicologico, esso è costituito dal dolo specifico, richiedendosi che la condotta violenta o minacciosa posta in essere dall’agente risulti finalisticamente indirizzata a consolidare il possesso della res sottratta, ovvero ad assicurarsi l’impunità.
Autonoma e specifica considerazione deve, altresì, essere dedicata alla circostanza aggravante del nesso teleologico, normativamente sancita dall’art. 61, n. 2, c.p.
Alla luce del chiaro contenuto semantico della disposizione richiamata, tale circostanza ricorre allorché un determinato fatto dotato di rilevanza penale venga commesso «per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato».
Trattasi di circostanza di natura soggettiva, il cui fondamento – secondo il granitico indirizzo interpretativo della Suprema Corte – risiede nella «più intensa criminosità nella condotta dell'agente, la cui pervicace determinazione soggettiva nella consumazione del reato-fine è resa manifesta dal rifiuto di arretrare di fronte all'eventualità di perpetrare altro reato»[4].
Lungi dall’operare secondo icastiche logiche presuntive, la configurabilità del meccanismo circostanziale in discorso risulta, inoltre, inestricabilmente correlata alla rigorosa dimostrazione, quand’anche per il tramite di circostanze indiziarie, che la volontà dell’agente fosse, sin dall’inizio, orientata alla realizzazione del c.d. reato-scopo[5].
Deve, per contro, ritenersi del tutto privo di incidenza il fatto che il reato-fine sia stato interamente portato a compimento; così come non assume rilievo che nei confronti dello stesso debba trovare applicazione una causa di non punibilità, di estinzione o di improcedibilità[6].
3. Il contrasto giurisprudenziale
Delineato il perimetro delle figure normative in rilievo, occorre adesso concentrare il fulcro della presente indagine sul contrasto sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Ebbene, la vexata quaestio oggetto dell'ordinanza remissiva vede, allo stato, contrapposti due distinti indirizzi interpretativi.
Segnatamente, secondo un primo – e più rigoroso – fronte ermeneutico, in tema di rapina impropria, «qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni oggetto dell'impossessamento, abbia cagionato la morte della persona offesa, l'aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., contestata in relazione al reato di omicidio, non è assorbita in quello di rapina, in quanto non sussiste incompatibilità giuridica tra il reato di rapina impropria e l'aggravante del nesso teleologico nel caso in cui la violenza esercitata dall'agente risulti esorbitante rispetto a quella idonea a configurare il delitto contro il patrimonio»[7].
Ebbene, le ragioni ontologiche a sostengo di tale assunto esegetico si colgono, evidentemente, nella concezione di radicale alterità tra le fattispecie in rilievo; costituendo, infatti, la violenza integrante il fatto omicidiario – o comunque lesivo – un quid pluris rispetto a quella suscettibile di essere assorbita nel delitto di rapina, non vi sarebbe ragione alcuna per ravvisare profili di incompatibilità tra quest’ultima e l’aggravante del nesso teleologico.
Detto altrimenti, in un contesto in cui la condotta predatoria trascende lo standard tipico della rapina – acquisendo, pertanto, una propria autonoma e pregnante rilevanza penalistica – l’aggravante del nesso teleologico si atteggia quale strumento di valorizzazione del più intenso disvalore giuridico esistente tra due fattispecie delittuose che, seppur ontologicamente distinte, risultano inestricabilmente connesse sul piano finalistico-funzionale.
In consapevole e dichiarata antitesi rispetto all’orientamento testé delineato, si colloca il diverso – e senz’altro più garantista – approdo ermeneutico secondo cui «in tema di rapina impropria, ove la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, determini la morte della persona offesa, la circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., è assorbita nel delitto per il principio di specialità, attesa la coincidenza tra le fattispecie della modalità commissiva dell'uso della violenza e dell'elemento finalistico dell'aver agito allo scopo di assicurarsi il profitto del reato o l'impunità»[8].
Tale opzione interpretativa, chiaramente ancorata al principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., muove dall’assunto per cui il coefficiente finalistico richiesto dall’art. 61, n. 2, c.p. risulta già integralmente ricompreso nell’architettura dell’art. 628, co. 2, c.p.
In questa prospettiva, optare per il mancato assorbimento dell’aggravante teleologica equivarrebbe a operare un’indebita duplicazione valutativa, poiché l’elemento intenzionale che caratterizza il delitto di rapina impropria (volontà di esercitare violenza per assicurarsi il profitto del reato o l’impunità) verrebbe nuovamente valutato come circostanza aggravante del fatto omicidiario o lesivo contestualmente realizzato: in palese violazione, dunque, del principio secondo cui nessuno può essere punito più di una volta per il medesimo fatto (ne bis in idem sostanziale).
4. Conclusioni
Così riassunti i termini della suesposta querelle interpretativa, si ritiene maggiormente persuasivo il secondo dei modelli ermeneutici annotati.
Tale opzione, invero, si giustifica – ad avviso di chi scrive – non soltanto in ossequio alla necessità di assicurare, nell’ottica di tutela del favor rei, piena e coerente attuazione al principio cardine del ne bis in idem sostanziale, ma anche perché l’adesione all’alternativa prospettazione esegetica, rigidamente ancorata al parametro dell’“esorbitanza” della violenza, avrebbe quale ineluttabile effetto quello di obliterare la natura eminentemente soggettiva dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p., piegandola a un criterio applicativo di carattere meramente oggettivo-quantitativo dell’offesa.
Ciò posto, indipendentemente dalla scelta nomofilattica che il Supremo Consesso riterrà più opportuno adottare, si ritiene che non possa neppure trovare applicazione – come invece audacemente suggerito dalla Sezione rimettente[9] – l’indirizzo tracciato dall’oramai celebre pronuncia “Magistri”[10].
Vero è che, in tale storica pronuncia, la Suprema Corte ha significativamente dilatato il perimetro applicativo del reato complesso, riconoscendone l’operatività anche al di fuori dei limiti imposti dall’interpretazione letterale dell’art. 84 c.p.; altrettanto vera, tuttavia, è l’esigenza che impone di ancorare l’operatività di siffatto paradigma ermeneutico alla coesistenza di due requisiti indefettibili: la contestualità spazio-temporale delle condotte e, soprattutto, la circostanza dell’essere le stesse collocate «in una comune prospettiva finalistica»[11].
Ebbene, è proprio quest’ultimo requisito a doversi ritenere insuscettibile di operare con riguardo alla quaestio rimessa all’attenzione del Supremo Consesso, costituendo, infatti, la risoluzione omicida (o lesiva) una componente necessariamente estemporanea ed eventuale rispetto alla realizzazione della fattispecie delittuosa patrimoniale.
Detto altrimenti, è ontologicamente assente un originario e unitario programma delittuoso che contempli, ab origine, l’utilizzo della violenza quale estremo corollario della condotta sottrattiva.
Di fronte a un così complesso itinerario logico-giuridico, è dunque affidato al Supremo Consesso il delicato compito di tracciare una soluzione ermeneutica capace di comporre, in armonica sintesi, da un lato, l’esigenza di garantire una risposta sanzionatoria proporzionata al disvalore complessivo della condotta e, dall’altro, quella di preservare l’architettura di un modello punitivo geneticamente informato all’irrinunciabile presidio – costituzionalmente garantito – del principio di legalità.
[1] Cfr. Cass. Pen. Sez. I, Ordinanza n. 23353 del 22.05.2025, § 2.3 del Considerato in diritto.
[2] Cfr. in senso contrario, G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte Speciale, vol. II, tomo 2, I delitti contro il patrimonio, 7ª ed., Zanichelli, 2015, 134, ove l’accostamento della nozione di immediatezza alla categoria processuale della flagranza è ritenuto non conducente, presupponendo quest’ultima l’essere colti nell’atto di commettere il reato e, dunque, un rapporto di stretta attualità tra la sottrazione e la condotta violenta o minacciosa; rapporto che difetta strutturalmente nella rapina impropria, nella quale l’attività coercitiva si esplica in un momento successivo alla sottrazione.
[3] Cfr. Cass. Pen. Sez. II, n. 30775 del 10.05.2023, Rv. 285038-02.
[4] Cfr. Cass. Pen., 17.12.1984, Masella, CED 168905.
[5] Cfr., in senso conforme, Cass. Pen. Sez. VI, n. 48552 del 18.11.2009.
[6] Cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 32688 del 14.04.2003.
[7] Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 46869 del 25.05.2022, Ursan, Rv. 284038-01.
[8] Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n. 37070 del 04.04.2023, Magno, Rv. 285247-01.
[9] Cfr. Ordinanza, § 4 del Considerato in diritto, cit.
[10] Cfr. Cass. Pen. Sez. U., n. 38402 del 15.07.2021, con la quale la Suprema Corte, pronunciandosi in materia di omicidio volontario commesso dall’autore del reato di atti persecutori, ex art. 576 c. 1 n. 5.1. c.p., ha enucleato il principio di diritto secondo cui «il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen.».
[11] Cfr. Cass. Pen. Sez. U., n. 38402 del 15.07.2021, § 6 del Considerato in diritto, cit.

