Pubbl. Lun, 1 Set 2025
La proprietà condizionata
Modifica pagina
Lorenzo La Via
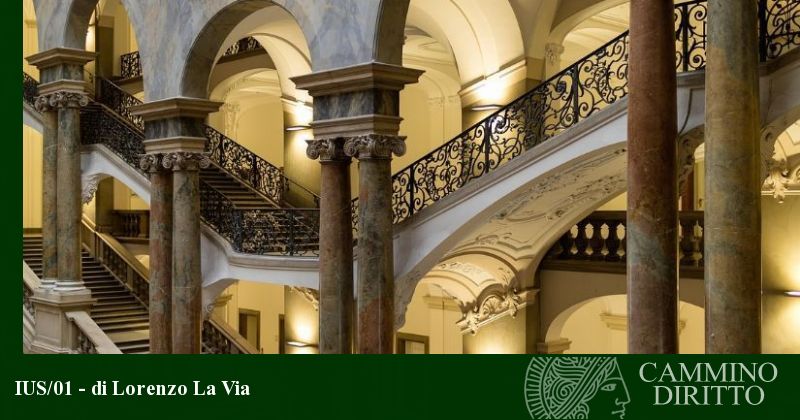
L’elaborato si propone di esaminare un fenomeno di recente emersione che, sebbene poco diffuso, sembra destinato a diventare una pratica comune nel prossimo futuro. Si delinea così una nuova concezione di proprietà, il cui titolare non gode di un possesso assoluto, poiché non può esplicare tutte le facoltà tipiche del bene.
 ENG
ENG
Conditional ownership
The paper aims to examine a recently emerging phenomenon that, although not widespread, seems destined to become a common practice in the near future. This outlines a new concept of ownership, where the owner does not enjoy absolute possession, as they cannot fully exercise all the typical rights of the asset.Sommario: 1. Considerazioni introduttive; 2. Il concetto tradizionale di proprietà; 3. Il blocco delle funzionalità: il c.d. feature locking; 4. Il concetto moderno di proprietà; 5. La proprietà frazionata; 6. L’aspettativa e la licenza di uso; 7. La proprietà condizionata; 8. Tutela del consumatore; 9. Considerazioni conclusive.
1. Considerazioni introduttive
Il diritto di proprietà ha costituito sin dall’antichità uno dei pilastri dell’ordinamento giuridico, tradizionalmente concepito come un diritto pieno, esclusivo e inviolabile . Tuttavia, l’odierna evoluzione tecnologica e i nuovi modelli economici stanno gradualmente mettendo in crisi questa visione monolitica, dando vita a forme inedite di godimento dei beni che non coincidono più con un possesso assoluto in capo al proprietario. In particolare, l’esperienza concreta del consumatore contemporaneo rivela come l’acquisto di un bene possa non comportare la libera ed integrale disponibilità di tutte le sue funzionalità.
In questo contesto emerge il fenomeno della proprietà condizionata, intesa come la situazione nella quale il titolare di un bene, pur divenendone proprietario a tutti gli effetti, vede compresso l’esercizio di alcune facoltà dominicali essenziali. L’accesso a determinate utilità o funzionalità del bene viene infatti subordinato all’adempimento di obblighi ulteriori – tipicamente di natura contrattuale o economica – imposti dalla volontà del produttore o del venditore. Non siamo in senso stretto di fronte a un nuovo tipo di diritto reale, bensì a una modulazione contrattuale della proprietà esistente, resa possibile dall’intreccio tra contratto di vendita con clausole limitative e controlli tecnologici incorporati nel bene. In altri termini, il compratore acquisisce la titolarità del bene nel suo patrimonio, ma il godimento di parte delle utilità rimane vincolato a condizioni successive: il risultato è un dominio formale pieno, ma sostanzialmente limitato.
L’analisi di tale fenomeno richiede un approccio sistematico e multidimensionale, conforme ai canoni interpretativi del diritto civile. In primo luogo, sarà adottato il criterio letterale, esaminando le disposizioni normative rilevanti – dagli articoli del codice civile e della Costituzione italiana fino alla normativa dell’Unione Europea – per verificare in che misura l’ordinamento contempli o escluda limitazioni di questo genere. In secondo luogo, si procederà con un approccio sistematico, mettendo la proprietà condizionata a confronto con figure affini già note (come l’usufrutto, la comunione, il patto di riservato dominio e la licenza d’uso) per evidenziarne convergenze e differenze. In terzo luogo, si seguirà un criterio storico, ripercorrendo in sintesi l’evoluzione del concetto di proprietà dal diritto romano sino all’attuale assetto costituzionale e sovranazionale, così da contestualizzare l’emergere di questa nuova forma di proprietà nel quadro evolutivo dei diritti reali. Infine, si utilizzerà il criterio teleologico, indagando la ratio e le finalità sottese alle restrizioni imposte: queste ultime appaiono infatti espressione di nuovi modelli di business che, perseguendo logiche di monetizzazione continua, incidono sulla tutela del consumatore e sull’equilibrio contrattuale tra le parti.
Accanto a questi profili, si terrà conto della dimensione comparata e sovranazionale. In altri ordinamenti – si pensi agli Stati Uniti o ad alcuni Paesi europei continentali – sono già emerse prassi giurisprudenziali e interventi normativi che affrontano, direttamente o indirettamente, problematiche analoghe a quelle poste dalla proprietà condizionata, influenzando così anche il dibattito nel nostro ordinamento. L’obiettivo finale è dunque verificare se e in quale misura la proprietà condizionata possa conciliarsi con i principi fondamentali dell’ordinamento vigente, individuando al contempo le prospettive di tutela per il consumatore e le eventuali necessità di un intervento legislativo volto a disciplinare in modo organico la materia.
2. Excursus storico e inquadramento della proprietà
Il concetto classico di proprietà, inteso come dominio pieno ed esclusivo su un bene, affonda le sue radici nell’esperienza giuridica romana. Nel diritto romano il dominium era concepito come il potere massimo esercitabile da un soggetto su una res, comprensivo sia della facoltà di godimento sia di quelle di disposizione e persino di distruzione del bene. Sin da quell’epoca tuttavia la proprietà non si presentava come un diritto assoluto e illimitato: poteva infatti subire restrizioni in presenza di prevalenti interessi pubblici, ad esempio mediante servitù imposte in favore di terzi o requisizioni per esigenze collettive. Ciò indica come, già nell’ordinamento romano, la sfera dominicale del proprietario fosse suscettibile di compressioni qualora lo richiedesse il soddisfacimento di bisogni generali della comunità.
Con l’età moderna – e in particolare con lo Statuto Albertino del 1848 – la proprietà privata venne elevata a diritto inviolabile, quasi sacralizzato, simbolo dei valori borghesi emergenti e baluardo di tutela dell’individuo contro gli arbitri del potere statuale . In tale fase storica il bene di proprietà era considerato un’estensione della libertà individuale e una garanzia di sicurezza economica: il possesso di beni, soprattutto immobili, significava autonomia e affermazione personale. La proprietà assoluta assume così anche una funzione politico-sociale, divenendo il cardine sul quale la borghesia fondava le proprie rivendicazioni di tutela nei confronti delle ingerenze dello Stato. Questa concezione individualistica e pressoché illimitata della proprietà trovò rispondenza nel Codice civile unitario del 1865, che recepì l’impostazione liberale dell’epoca.
Fu però con il Codice civile del 1942 che il diritto di proprietà venne consacrato nella formulazione ancora oggi vigente. L’art. 832 c.c. definì la proprietà come “il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”, racchiudendo in questa sintetica locuzione l’intero nucleo del potere dominicale [9]. Da tale definizione emergono due componenti fondamentali: il godimento, inteso come la facoltà di trarre dal bene ogni utilità, materiale o immateriale; e la disponibilità, intesa come la possibilità di alienare il bene, trasformarlo o persino distruggerlo a proprio piacimento. Allo stesso tempo, l’esclusività garantisce che nessun terzo possa interferire nell’esercizio di queste facoltà, mentre la pienezza esprime la totalità dei poteri riconosciuti al proprietario. Secondo la dottrina tradizionale, tali caratteristiche delineano un diritto unitario e indivisibile, la cui elasticità assicura che ogni limitazione temporanea o parziale sia destinata a riassorbirsi spontaneamente, restituendo al proprietario la pienezza originaria dei poteri non appena venga meno la causa della compressione [1]. In questa prospettiva, come autorevolmente sottolineato in dottrina, la proprietà non può ridursi a una somma di facoltà scindibili, ma costituisce piuttosto un diritto unico e inscindibile dal quale discendono i molteplici poteri di uso, godimento e disposizione [4].
L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 ha impresso un mutamento radicale a tale panorama concettuale. L’art. 42 Cost. riconosce la proprietà privata, ma ne subordina l’esercizio alla funzione sociale, ossia alla conformità con l’utilità collettiva e con gli altri interessi generali . La proprietà, pur rimanendo formalmente un diritto pieno ed esclusivo, non è più concepita come illimitata e impermeabile ad ogni interferenza: il legislatore può modularne l’esercizio e prevedere vincoli al godimento, al fine di assicurarne la compatibilità con l’interesse pubblico e con altri diritti fondamentali della persona [4]. Le vicende del secondo dopoguerra, segnate dal conflitto tra libertà economiche e istanze di giustizia sociale, hanno condotto infatti a una rilettura meno individualistica e più relazionale della proprietà . In dottrina si è parlato di «terribile diritto», enfatizzandone la duplice valenza di diritto fondamentale dell’individuo ma anche di potere da bilanciare con la solidarietà sociale [5]. Pur senza intaccarne il ruolo centrale, la proprietà è stata costituzionalmente ancorata a una funzione sociale e sottoposta ai limiti e obblighi che ne derivano.
A completare questo quadro si aggiunge, in epoca più recente, la dimensione sovranazionale. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000, così come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, hanno ribadito la qualifica della proprietà quale diritto inviolabile, ammettendo al contempo limiti proporzionati giustificati da esigenze di interesse pubblico. Si è consolidata così un’idea di proprietà che, pur conservando la propria essenza unitaria, risulta sempre più permeabile ai mutamenti sociali, politici ed economici . In sintesi, dall’assolutezza del dominium romano alla sacralizzazione borghese ottocentesca, dalla definizione codicistica del 1942 fino alla revisione costituzionale e agli sviluppi sovranazionali, il diritto di proprietà si è progressivamente trasformato in un istituto dinamico, capace di coniugare la tutela dell’autonomia individuale con la salvaguardia di interessi collettivi sempre più incisivi . È alla luce di questa evoluzione storica e normativa che occorre interrogarsi sulla compatibilità della proprietà condizionata con i principi fondamentali dell’ordinamento positivo, poiché tale fenomeno sembra incrinare l’idea stessa di dominio pieno ed esclusivo, sostituendola con una forma di appartenenza parziale e subordinata.
3. Il concetto tradizionale di proprietà nel Codice Civile
Se l’analisi storica mostra il progressivo affermarsi di limiti e counterweights al diritto di proprietà, l’articolo 832 c.c. rimane il punto di partenza imprescindibile per coglierne la portata nel nostro ordinamento . Come visto, il Codice del 1942 definisce la proprietà privata nei termini di un diritto di godere e disporre del bene in modo pieno ed esclusivo. Questa definizione racchiude in poche parole l’essenza del diritto dominicale, che la dottrina classica ha a lungo interpretato come un potere assoluto e unitario [6][1]. Il godimento rappresenta la facoltà di trarre dal bene ogni utilità e beneficio – sia materiale che immateriale – secondo la propria volontà; la disponibilità attiene invece alla libertà di decidere del destino del bene, potendolo alienare, trasformare o persino distruggere senza dover rendere conto ad altri . La pienezza del diritto indica che il proprietario detiene la totalità delle facoltà possibili sulla cosa, mentre l’esclusività garantisce che egli possa esercitarle impedendo qualsiasi ingerenza altrui.
Queste caratteristiche hanno alimentato la tradizionale contrapposizione tra la proprietà e figure limitative o parziali ad essa affini, come l’usufrutto, la comunione e il possesso . In ciascuno di tali casi, infatti, si assiste a una delimitazione dei poteri sul bene che però non scalfisce l’unitarietà del diritto di proprietà: ad esempio, l’usufruttuario esercita per un tempo determinato facoltà di godimento su cosa altrui, ma la nuda proprietà resta in capo al titolare originario; allo stesso modo, il comproprietario di un bene in comunione gode insieme agli altri di utilità e frutti, ma ciascuno conserva una quota ideale e la proprietà complessiva non perde la sua identità unitaria, riunificandosi qualora la comunione si sciolga. Persino il possesso, inteso come situazione di fatto, può essere descritto come un godimento del bene privo di titolo dominicale, ma non mette in dubbio l’esclusività giuridica del proprietario vero e proprio. L’idea di fondo, ribadita dalla dottrina più autorevole, è che la proprietà non possa frammentarsi in una somma di facoltà autonome: si tratta, piuttosto, di un fascio unitario da cui discendono inscindibilmente i vari poteri di utilizzo, godimento e disposizione [1]. La teorica “elasticità” del diritto di proprietà garantisce che qualunque compressione particolare – derivante magari da vincoli pubblicistici (come un vincolo paesaggistico) o da rapporti obbligatori liberamente assunti dal proprietario – non intacchi l’essenza del diritto stesso. Questo rimane integro nella sua titolarità e tende a riespandersi una volta cessata la causa limitativa, recuperando la pienezza originaria.
Con l’avvento della Costituzione del 1948, come anticipato, l’assolutezza di questa concezione ha trovato un significativo temperamento. Il riconoscimento della funzione sociale della proprietà privata comporta che il legislatore possa imporre limiti e oneri al proprietario nell’interesse generale, senza per questo negare la natura piena ed esclusiva del diritto dominicale. Ne è scaturita una figura giuridica complessa: la proprietà rimane piena ed esclusiva sul piano formale e concettuale, continuando a rappresentare il modello cardine dell’autonomia privata, ma nel concreto esercizio risulta permeabile alle esigenze della collettività e alle istanze poste dall’ordinamento sovranazionale [1]. Questo nuovo equilibrio ha portato la dottrina a interrogarsi sulla tenuta della definizione codicistica tradizionale di fronte alle sfide contemporanee. In ogni caso, la proprietà “classica” – quella delineata dall’art. 832 c.c. – costituisce tuttora il parametro concettuale e normativo di riferimento imprescindibile per valutare la novità rappresentata dalla proprietà condizionata. Sarà rispetto a tale paradigma, infatti, che occorrerà misurare l’eventuale erosione della pienezza e dell’esclusività prodotta dalle nuove prassi contrattuali, le quali rischiano di ridurre il diritto dominicale a un mero titolo formale, svuotato di contenuto effettivo.
4. Figure affini e distinzioni sistematiche
Per comprendere appieno la portata innovativa della proprietà condizionata è necessario collocarla nel sistema dei diritti reali, confrontandola con istituti già noti e consolidati, così da verificare se si tratti davvero di un fenomeno inedito oppure di una variante di situazioni esistenti [3]. L’analisi sistematica permette infatti di chiarire se il diritto in esame integri una categoria autonoma oppure rientri, con adattamenti, in schemi giuridici tradizionali.
Un primo termine di paragone è l’usufrutto, che rappresenta il caso tipico di dissociazione tra titolarità e godimento: l’usufruttuario può utilizzare e trarre utilità dal bene, mentre il proprietario conserva la sola nuda proprietà [3]. Si ha dunque una separazione temporanea e parziale dei poteri dominicali, destinata a ricomporsi con l’estinzione dell’usufrutto, allorché il proprietario riacquista la pienezza del suo dominio. Nel caso della proprietà condizionata, invece, non vi è alcun trasferimento di facoltà a un soggetto diverso: il proprietario rimane l’unico titolare del bene, ma alcune sue prerogative di godimento risultano compresse e non liberamente esercitabili finché non siano adempiute certe condizioni contrattuali. Non si ha quindi quella scissione soggettiva tipica dell’usufrutto, bensì una limitazione pattizia all’interno dello stesso diritto di proprietà, che incide sull’effettivo godimento pur lasciando intatta la titolarità.
Un’altra figura di riferimento è la comunione tra più proprietari. In tal caso il bene appartiene pro indiviso a una pluralità di soggetti, ognuno dei quali può goderne entro i limiti del pari diritto altrui. Anche qui, tuttavia, la limitazione è relativa: ogni comproprietario detiene una quota ideale del bene e, ancorché debba coordinare il suo uso con quello degli altri, conserva integralmente i poteri tipici del proprietario (sebbene esercitati in concorso con gli altri titolari). Non si verifica dunque, neppure nella comunione, una compressione assoluta delle facoltà dominicali: la proprietà resta intera, sia pure ripartita per quote ideali, e ciascun titolare mantiene la possibilità di godere e disporre (ad esempio alienando la propria quota) nei limiti della legge. Nella proprietà condizionata, invece, il proprietario è unico e resta formalmente pieno proprietario, ma alcune utilità del bene gli sono precluse sino a che non vengano adempiuti ulteriori obblighi estranei al normale contenuto del diritto. La differenza rispetto alla comunione sta dunque nel fatto che qui la compressione delle facoltà incide sul rapporto tra proprietario e bene, e non sui rapporti tra più contitolari [3].
Più pertinente sul piano strettamente contrattuale è il confronto con la vendita con patto di riservato dominio disciplinata dall’art. 1523 c.c. In tale contratto – volto tipicamente alla dilazione di pagamento – le parti convengono che la proprietà si trasferirà all’acquirente solo al momento del pagamento integrale del prezzo [9]. Fino all’adempimento della condizione sospensiva (il saldo del prezzo), la proprietà del bene mobile rimane interamente al venditore, mentre l’acquirente ne ha soltanto la detenzione qualificata, godendo del bene in attesa di diventarne proprietario definitivo. L’acquirente, in questa situazione, vanta dunque un’aspettativa di divenire proprietario, suscettibile di consolidarsi al verificarsi dell’evento futuro ed incerto costituito dal pagamento integrale [6]. La proprietà condizionata si colloca in un contesto diverso: qui il trasferimento della titolarità è immediato e pieno, sicché l’acquirente diviene fin da subito proprietario del bene, e non deve attendere alcun evento futuro per acquisire il diritto. Ciò che viene posticipato non è il sorgere del diritto di proprietà, già acquisito, ma la possibilità effettiva di esercitare alcune facoltà che ne fanno parte. Non sarebbe quindi corretto parlare, nel nostro caso, di “aspettativa di proprietà”, poiché il compratore non è un aspirante proprietario in attesa della titolarità: egli è già proprietario, ma incontra limiti pratici nell’esercizio di alcune prerogative dominicali. La differenza del patto di riservato dominio – in cui la proprietà resta al venditore finché il prezzo non sia pagato – nella proprietà condizionata la proprietà passa subito all’acquirente, sebbene depotenziata nell’uso fino all’adempimento degli obblighi ulteriori pattuiti. Non vi è dunque identità tra i due istituti.
Una figura ancora più diffusa negli scambi moderni, specie in ambito digitale, è la licenza d’uso: si pensi alle licenze software, alle piattaforme online o ad altri beni digitali. In tali ipotesi il consumatore non acquista la proprietà del bene immateriale (il software, il contenuto digitale), ma ottiene semplicemente un diritto personale di utilizzo alle condizioni stabilite dal produttore – condizioni spesso unilaterali, suscettibili di modifiche o revoche secondo i termini della licenza stessa. La distanza rispetto alla proprietà condizionata è netta: nella licenza d’uso non c’è alcun trasferimento di proprietà del bene, che rimane nella sfera giuridica del concedente; l’utente finale ha soltanto un diritto di godimento temporaneo o limitato, revocabile alle condizioni contrattuali. Nella proprietà condizionata, invece, come più volte ribadito, il bene entra a far parte del patrimonio dell’acquirente con un vero e proprio trasferimento dominicale. Ciò che accomuna la licenza e la proprietà condizionata è la logica delle restrizioni contrattuali all’uso: entrambe limitano le facoltà di godimento dell’utente finale. Ma vi è una differenza sostanziale: nella licenza l’utente è consapevole di non essere proprietario e accetta un’utilizzazione circoscritta del bene altrui; nella proprietà condizionata, al contrario, l’acquirente è proprietario a tutti gli effetti, e tuttavia vede svuotata parte dell’efficacia della sua qualità di proprietario a causa di obblighi contrattuali che ne comprimono l’esercizio delle facoltà. In altri termini, il bene è suo, ma non pienamente disponibile; il dominio è formalmente integro, ma sostanzialmente limitato.
Questi confronti evidenziano come la proprietà condizionata non sia sovrapponibile a nessuno degli istituti tradizionali finora esaminati. Essa non spezza il diritto di proprietà come fa l’usufrutto, non lo divide fra più soggetti come nella comunione, non ne sospende il trasferimento come nel patto di riservato dominio, e non lo sostituisce con un mero diritto d’uso come avviene nella licenza . Piuttosto, si presenta come una compressione contrattuale delle facoltà proprietarie: la titolarità resta unitaria in capo all’acquirente, ma la libertà di godimento è ridotta in concreto. Ci troviamo in una zona di confine in cui coesistono una pienezza formale del diritto e una limitazione sostanziale delle sue prerogative. Ed è proprio in questa terra di nessuno che il fenomeno acquista rilievo, ponendo nuovi interrogativi sulla natura stessa della proprietà e sul suo rapporto con il mercato contemporaneo tecnologico e digitale. Non a caso, alcuni Autori hanno segnalato come tali vincoli contrattuali stiano di fatto reintroducendo restrizioni analoghe a quelle delle servitù su beni mobili, tradizionalmente vietate dal diritto di proprietà: attraverso i contratti, si sta riconoscendo una nuova forma di proprietà condizionata che il sistema giuridico classico non contemplava. Di fronte a questa realtà emergente – difficilmente riconducibile alle categorie codificate – la dogmatica civilistica è chiamata a interrogarsi: il problema non è meramente terminologico o classificatorio, ma riguarda l’essenza di un diritto che l’ordinamento ha a lungo considerato assoluto e indivisibile, e che oggi rischia di ridursi a un contenitore formale privo di effettivo contenuto economico e sociale.
5. La proprietà condizionata come fenomeno emergente
Alla luce delle coordinate normative e sistematiche sin qui tracciate, possiamo ora focalizzarci sul fenomeno in esame, che si presenta come una delle novità più significative nel diritto dei beni dell’era digitale. Si parla di proprietà condizionata ogniqualvolta il titolare di un bene, pur avendolo acquistato e divenendone formalmente proprietario, non può esercitare liberamente tutte le facoltà che tradizionalmente compongono il diritto di proprietà (art. 832 c.c.) a causa di vincoli ulteriori. In sostanza, il proprietario si trova di fronte a un diritto non sottratto né diviso, ma compresso contrattualmente: il bene è suo, ma l’accesso a determinate utilità rimane subordinato al rispetto di obblighi ulteriori estranei al trasferimento, spesso previsti nel contratto di acquisto o resi tecnicamente necessari dal produttore. Non vi è dunque spossessamento né sospensione del diritto, bensì un’inedita erosione “interna” delle facoltà proprietarie, che altera in concreto l’esperienza di godimento del bene da parte dell’acquirente.
Gli esempi pratici di questo fenomeno provengono soprattutto dai mercati tecnologicamente avanzati. Il caso emblematico è offerto dal settore automobilistico di ultima generazione: alcune case produttrici vendono vetture già dotate di specifiche funzioni o accessori (come i sedili riscaldati, gli assistenti alla guida evoluti, ecc.), che però rimangono disattivati finché l’acquirente non paga un corrispettivo ulteriore per sbloccarli. In altri termini, l’auto viene venduta con l’hardware già predisposto per certe funzionalità, ma il proprietario può utilizzarle solo sottoscrivendo un abbonamento o pagando unlock periodici. Un caso noto ha riguardato la casa automobilistica BMW, che aveva introdotto un servizio in abbonamento per l’utilizzo dei sedili riscaldabili: di fronte alle proteste dei consumatori, tale modello è stato poi ritirato [8]. Fenomeni analoghi si riscontrano nell’elettronica di consumo: stampanti e altri dispositivi domestici che restano parzialmente inutilizzabili se l’utente non acquista materiali di consumo o componenti proprietarie fornite dal produttore (ad esempio, cartucce con chip di autenticazione). Anche nel settore dei videogiochi e delle piattaforme digitali è diffusa la pratica di limitare l’uso di funzionalità già integrate nel prodotto, rendendole accessibili solo mediante acquisti ingame, abbonamenti o contratti di servizio ulteriori: in tal modo, un bene che dovrebbe essere trasferito come “prodotto completo” di fatto viene fruito come licenza condizionata, subordinata al perdurare di rapporti contrattuali successivi alla vendita.
Da questi esempi emerge nitidamente la divergenza tra la proprietà intesa in senso classico – che conferirebbe al proprietario un dominio assoluto sul bene – e la concreta esperienza del consumatore moderno. Da un lato, il bene entra formalmente nel patrimonio dell’acquirente al momento della vendita; dall’altro, alcune utilità e funzioni rimangono vincolate ad ulteriori prestazioni, assumendo la forma di veri e propri corrispettivi successivi che il proprietario deve corrispondere per godere appieno di ciò che già possiede. La titolarità del diritto resta dunque unitaria e indiscussa, ma il godimento è compresso da obblighi che – pur non qualificandosi giuridicamente come diritti reali altrui sul bene – incidono direttamente sulla possibilità di fruirne. In altre epoche una situazione del genere sarebbe stata considerata anomala, se non contraddittoria, rispetto al paradigma proprietario: eppure nel mercato odierno tali pratiche tendono a diffondersi, specie nei settori legati all’informatica e all’Internet delle cose.
Il dato più significativo è che queste compressioni non discendono da limiti imposti dall’ordinamento nell’interesse pubblico (come avviene, ad esempio, per i vincoli urbanistici, ambientali o paesaggistici), bensì da scelte contrattuali e tecnologiche di soggetti privati. In altri termini, la proprietà condizionata segna un passaggio dirompente: la limitazione del godimento non nasce dalla legge, ma dal mercato, e va a intaccare un ambito – quello della pienezza dominicale – che fino a tempi recenti era ritenuto intangibile salvo casi eccezionali di pubblico interesse. In prospettiva formale non si può negare che l’acquirente diventi proprietario del bene; tuttavia, sul piano sostanziale egli non ne dispone pienamente. Proprio qui si coglie la peculiarità del fenomeno: la proprietà condizionata non spezza il diritto (come avverrebbe, ad esempio, se parte del diritto rimanesse in capo al venditore), ma ne riduce l’effettività, trasformando il dominio da pieno a diritto d’accesso graduato. La novità sta nel creare una frattura tra la titolarità giuridica e l’esercizio pratico del possesso e della disponibilità; frattura che solleva dubbi sulla tenuta del concetto stesso di proprietà così come tradizionalmente inteso.
In quest’ottica, la proprietà condizionata si colloca in un territorio ibrido, a metà strada tra il diritto reale e la disciplina contrattuale, senza poter essere ricondotta in modo pienamente soddisfacente né all’una né all’altra categoria. Ciò la rende una sfida notevole per la dogmatica civilistica contemporanea: non è solo questione di trovare un nome nuovo o di classificare un’anomalia, ma di interrogarsi sull’essenza di un diritto – la proprietà – che il nostro ordinamento ha sempre concepito come assoluto e indivisibile, e che oggi rischia di ridursi a una mera apparenza, priva di reale contenuto economico e utilità sociale. Alcuni commentatori hanno descritto in termini critici questa tendenza alla progressiva erosione delle prerogative degli acquirenti, coniando espressioni come enshittification per indicare la degenerazione dell’esperienza d’uso causata da strategie di mercato volte a massimizzare il profitto a scapito dei diritti degli utenti [7]. Si tratta di neologismi dal tono volutamente polemico, ma che ben catturano il rischio insito nella proprietà condizionata: quello di lasciare al consumatore solo l’illusione della proprietà, mentre il controllo effettivo sul bene rimane in mano al produttore attraverso meccanismi contrattuali e tecnologici.
6. L’aspettativa e la licenza di uso
L’indagine teleologica mira a comprendere le finalità e le giustificazioni alla base delle limitazioni che caratterizzano la proprietà condizionata, nonché a valutare se tali prassi siano in linea con gli scopi dell’ordinamento in materia di diritti di proprietà e di contratti. In primo luogo, va considerato che la tradizionale ratio della proprietà privata – così come delineata dal codice civile e dalla Costituzione – è quella di garantire al titolare un potere effettivo sul bene, nel rispetto della funzione sociale ma senza ingerenze privatistiche arbitrarie. La pienezza ed esclusività della proprietà mirano proprio ad assicurare che il proprietario possa godere e disporre del bene liberamente, fatto salvo il bilanciamento con interessi generali stabilito ex lege. L’introduzione su base contrattuale di limiti al godimento posti nell’esclusivo interesse di un’altra parte privata (il produttore/venditore) appare dunque aliena rispetto ai tradizionali limiti legali alla proprietà, che trovano invece giustificazione in esigenze di carattere pubblico (si pensi all’utilità sociale, alla sicurezza, all’ordine pubblico, ecc.). In tal senso, la proprietà condizionata potrebbe porsi in tensione con la ratio originaria delle norme proprietarie, nata per tutelare la sfera di autonomia individuale del proprietario contro interferenze ingiustificate. Teleologicamente parlando, le condizioni d’uso imposte dal venditore rischiano di frustrare la causa stessa del contratto di vendita, che è il trasferimento della piena disponibilità del bene dietro corrispettivo in denaro.
Dal punto di vista del produttore o venditore, la ragione di queste clausole limitative è evidente: esse permettono di implementare modelli di business fondati su entrate ricorrenti (pay-per-use, subscription models, microtransazioni) e di mantenere un controllo post-vendita sul bene, ad esempio per segmentare il mercato o prevenire utilizzi non remunerativi. Si potrebbe sostenere che, in alcuni casi, ciò consenta di offrire beni a un prezzo iniziale inferiore, scaricando su chi vorrà usare certe funzionalità il relativo costo (una sorta di pricing modulare). Tuttavia, questa giustificazione economica entra in conflitto con la finalità primaria del contratto di vendita e con il principio di trasferimento pieno della proprietà a seguito del pagamento del prezzo. Teleologicamente, il diritto dei contratti – specie nella sua declinazione consumeristica – mira a consentire un equilibrio tra le parti e a impedire che una parte forte (qui il produttore, titolare di know-how tecnico e potere di mercato) imponga condizioni tali da svuotare la controprestazione della parte debole. Se il compratore paga per acquistare un bene, la ratio contrattuale vorrebbe che ottenesse in cambio la disponibilità del bene stesso e delle sue normali utilità. Condizionare l’uso di parte di queste utilità a ulteriori pagamenti significa, dal punto di vista della funzione economico-sociale del contratto di vendita, spezzare la corrispettività sinallagmatica: il rischio è di far pagare separatamente ciò che dovrebbe essere compreso nel prezzo originario, alterando il bilanciamento delle prestazioni.
Un’altra angolazione teleologica riguarda la tutela del consumatore e la trasparenza contrattuale. Lo scopo delle norme a protezione del contraente debole è di assicurare che il consumatore sia informato e che non subisca clausole inique o sorprendenti. Dal punto di vista delle finalità legislative, condizionare il godimento di un bene venduto a clausole ulteriori appare ammissibile solo entro certi limiti: occorre che tali condizioni siano chiaramente portate a conoscenza del compratore prima dell’acquisto e che non risultino eccessivamente gravose o sproporzionate rispetto al valore del bene e al corrispettivo pattuito. In assenza di queste cautele, le clausole in questione tradiscono la loro funzione: da strumenti per adattare l’uso del bene a specifici accordi, esse diventano mezzi per trasferire surrettiziamente dei costi sul consumatore o per mantenerlo vincolato al produttore (si pensi all’acquisto obbligato di ricambi o servizi post-vendita del medesimo produttore, in assenza di alternative). Tali pratiche sono in evidente contrasto con la ratio del diritto dei consumatori, che punta a garantire scelte contrattuali consapevoli e un equo contemperamento dei diritti e obblighi contrattuali.
Infine, il criterio teleologico impone di guardare agli effetti sistemici di queste nuove forme contrattuali. Un ordinamento giuridico persegue, tra i suoi fini, anche la certezza delle situazioni giuridiche e la fiducia dei consociati nei mercati. Se la proprietà di un bene non garantisce più all’acquirente il potere di utilizzarlo liberamente, viene meno in parte la fiducia che tradizionalmente accompagna l’atto di acquisto: il consumatore potrebbe chiedersi se abbia senso comprare un bene “a metà”. In prospettiva, ciò rischia di ridurre la propensione stessa ad acquistare e possedere beni, favorendo modelli alternativi (noleggio, abbonamento puro, ecc.) e modificando profondamente i rapporti di mercato e il concetto di accesso ai beni. Teleologicamente, il diritto dovrebbe farsi carico di queste tendenze, stabilendo magari un nocciolo irriducibile di facoltà che devono necessariamente accompagnare la titolarità di un bene, affinché la proprietà conservi la sua funzione. In mancanza di un intervento correttivo, si potrebbe assistere – come alcuni denunciano – a una sorta di feudalizzazione del mercato dei beni: il produttore manterrebbe un potere sul bene anche dopo la vendita, analogamente a come il signore feudale manteneva diritti sul fondo concesso. Sarebbe un arretramento rispetto ai fini di libertà e autonomia che l’evoluzione del diritto di proprietà ha perseguito negli ultimi secoli. È dunque nell’interesse del legislatore, oltre che dei consumatori, riequilibrare il modello contrattuale della proprietà condizionata, così da consentire l’innovazione economica senza sacrificare i valori fondamentali di tutela della parte debole e di effettività dei diritti.
7. La dimensione comparata e sovranazionale
Il fenomeno della proprietà condizionata non è passato inosservato in altri ordinamenti, dove si sono registrate reazioni giurisprudenziali e legislative di grande interesse ai fini di un confronto. L’analisi fin qui condotta consente di delineare con maggiore precisione i tratti di questo istituto di fatto che negli ultimi anni si va imponendo nel mercato globale e, di riflesso, nel diritto: la proprietà condizionata si manifesta quando il trasferimento del bene è pieno e immediato sul piano formale, ma l’esercizio delle facoltà dominicali rimane subordinato a prestazioni ulteriori – spesso di natura economica – imposte dal venditore o dal produttore. In tal modo, il diritto di proprietà si presenta esteriormente intatto, ma sostanzialmente limitato. La peculiarità risiede, come visto, nella frattura tra il dato formale (la titolarità del bene in capo all’acquirente) e quello sostanziale (l’impossibilità per il medesimo di disporre liberamente di tutte le utilità del bene). Si tratta di una compressione atipica, che non deriva dalla legge o da interessi pubblici – come usualmente accade per i limiti legali alla proprietà – bensì dalla volontà privata e da strategie di mercato. Ciò che rende il fenomeno ancor più problematico, come già sottolineato, è la tendenza di tali compressioni a perdurare nel tempo: esse non hanno carattere transitorio né si riassorbono automaticamente, ma anzi perdurano finché l’acquirente non adempia agli obblighi ulteriori stabiliti contrattualmente dal produttore, con il rischio di svuotare l’istituto proprietario del suo nucleo essenziale.
Di fronte a questi sviluppi, i sistemi giuridici stranieri hanno adottato approcci differenti. Nell’ordinamento degli Stati Uniti, ad esempio, la tradizione del common law ha sempre guardato con sfavore ai tentativi di imporre vincoli d’uso sui beni mobili dopo la vendita, considerandoli in linea di principio incompatibili con la natura della proprietà privata. Già nel XIX secolo la giurisprudenza americana formulò il rifiuto delle cosiddette equitable servitudes on chattels, negando validità a condizioni d’uso che il venditore volesse apporre sulla cosa una volta venduta, in analogia al divieto di pacta servanda sui beni mobili. Questo orientamento di principio – volto a tutelare la libertà del compratore di disporre del bene acquistato – è sopravvissuto fino all’era contemporanea, come dimostra una importante sentenza della Corte Suprema USA del 2017. In Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. la Corte ha affermato che qualunque limitazione posta dal venditore all’uso o rivendita di un prodotto dopo la vendita è inefficace dal punto di vista dei diritti di proprietà industriale, poiché la decisione di vendere un bene esaurisce i diritti di esclusiva del produttore su di esso. In tale caso (riguardante cartucce per stampanti vendute con una clausola di non riutilizzo), la Suprema Corte ha così negato tutela alle restrizioni post-vendita, applicando rigorosamente il principio di exhaustion che fa parte della ratio sia del diritto brevettuale sia, più in generale, della libera circolazione dei beni venduti sul mercato[15]. Questo pronunciamento rappresenta un chiaro segnale dell’intento, nell’ordinamento statunitense, di evitare che il venditore possa mantenere un controllo invasivo sul bene dopo averlo ceduto, almeno quando ciò si traduca in una violazione di diritti fondamentali (come quello di rivendere il bene).
D’altra parte, va segnalato che negli Stati Uniti la vicenda della licenza software e, più in generale, delle EULA (End-User License Agreements) ha seguito un percorso diverso: qui i tribunali per lungo tempo hanno considerato le restrizioni contrattuali all’uso dei beni digitali come questioni di diritto contrattuale e non di diritti reali, finendo per legittimare di fatto l’imposizione di vincoli post-vendita mediante condizioni generali accettate dall’utente. In mancanza di una visione “proprietaria” del problema, i giudici statunitensi hanno spesso ritenuto valide clausole che, ad esempio, vietavano il trasferimento di una licenza software o limitavano l’uso di un dispositivo a certi scopi, sempreché il contratto fosse ritenuto valido secondo le regole generali. Ciò ha portato – come è stato acutamente osservato in dottrina – a un riconoscimento surrettizio di servitù sui beni mobili tramite il diritto dei contratti, fenomeno che il sistema giuridico aveva a lungo proibito per buone ragioni. Questa divergenza di approcci all’interno dello stesso ordinamento (favorevole al compratore in materia di reselling di beni fisici brevettati, ma più permissivo sulle restrizioni via contratto nelle licenze digitali) evidenzia la complessità del tema e suggerisce la necessità di un intervento legislativo organico.
Nell’Unione Europea, la discussione sulla proprietà condizionata si intreccia con l’attuazione delle recenti direttive in materia di vendita di beni e fornitura di contenuti digitali. In particolare, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura dei beni digitali venduti con licenza nella famosa sentenza UsedSoft GmbH c. Oracle (2012)[13]. In quel caso, riguardante la rivendita di licenze usate di software scaricato online, la Corte di Giustizia ha di fatto assimilato la cessione di una licenza perpetua di software a una vendita di beni, applicando il principio dell’esaurimento del diritto d’autore sul programma venduto. Pur trattandosi di una fattispecie diversa (non vi era una “proprietà condizionata” in senso stretto, bensì la qualificazione della licenza come vendita), la logica di fondo della Corte è significativa: anche un bene intangibile come il software, una volta ceduto definitivamente contro pagamento, deve poter essere liberamente utilizzato e trasferito dall’acquirente, senza che il produttore possa imporre vincoli ulteriori all’uso o alla rivendita. Questa impostazione privilegia evidentemente la tutela dell’acquirente e il mantenimento della sostanza economica del bene acquisito, ed è coerente con la tradizione civilistica europea che mal tollera restrizioni convenzionali alla pienezza proprietaria. Si noti però che, al di fuori di tale importante precedente, il quadro normativo UE non si era occupato espressamente del fenomeno delle funzionalità “bloccate” nei beni materiali fino alla recente introduzione delle nuove direttive sui beni digitali (di cui si dirà oltre).
In alcuni ordinamenti europei nazionali si iniziano comunque a vedere segni di attenzione al problema. Ad esempio, in Francia le autorità di regolazione hanno scrutinato pratiche analoghe (come la comunicazione pubblicitaria di veicoli con funzionalità ADAS non attivate senza abbonamento), ravvisando profili di ingannevolezza e ordinando una maggiore trasparenza al produttore. In Germania e in altri Paesi si discute in sede dottrinale della compatibilità di clausole di questo genere con la disciplina dei vizi della cosa venduta e con le garanzie legali: l’idea è che vendere un bene con parti inutilizzabili possa integrare un difetto di conformità rispetto al contratto. Tali dibattiti hanno preparato il terreno alle soluzioni normative europee di cui appunto le direttive 2019/770 e 2019/771 sono espressione, nel tentativo di adeguare la tutela del compratore all’era dei beni “ibridi” (materiali con componenti digitali rilevanti).
Il confronto comparato conferma la delicatezza delle questioni poste dalla proprietà condizionata. Ordinamenti diversi hanno già dovuto affrontare conflitti tra produttori e acquirenti riguardo al controllo post-vendita dei beni, con esiti che sottolineano l’urgenza di un intervento di regolazione armonizzato. L’Unione Europea, da parte sua, con le direttive (UE) 2019/770 e 2019/771 ha predisposto strumenti utili ma al momento ancora parziali [2][10], soprattutto per quanto concerne i beni materiali con componenti digitali (i richiamati “beni ibridi”) [10]. Esperienze come il caso John Deere negli Stati Uniti – in cui le autorità antitrust e i tribunali sono intervenuti per assicurare agli agricoltori il diritto di riparare e accedere al software dei macchinari agricoli, limitando le restrizioni imposte dal produttore – o le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia (come la sanzione a Tesla del 2023 per pratiche commerciali ingannevoli sull’Autopilot) mostrano come, in assenza di norme specifiche, la giurisprudenza inizi a colmare i vuoti ma con il rischio di soluzioni frammentarie e non coordinate. Ne deriva che la questione della proprietà condizionata investe principi cardine e richiede probabilmente una risposta sistemica da parte del legislatore, oltre che un attento esame dogmatico.
8. Tutela del consumatore e problemi applicativi
La proprietà condizionata non pone soltanto problemi teorici di inquadramento giuridico, ma solleva implicazioni pratiche di grande rilievo, soprattutto sotto il profilo della tutela del consumatore. Infatti, se è vero che il bene acquistato entra nel patrimonio dell’acquirente, è parimenti evidente che la possibilità di goderne integralmente viene spesso subordinata a condizioni ulteriori. Ciò comporta il rischio di scivolare in pratiche commerciali scorrette o in clausole contrattuali squilibrate, vietate dal nostro ordinamento a protezione del consumatore.
Il diritto europeo ha recentemente predisposto strumenti di tutela che consentono di valutare simili ipotesi. La Direttiva (UE) 2019/771 (sui contratti di vendita di beni di consumo, recepita nel Codice del Consumo) stabilisce che i beni venduti devono essere conformi al contratto e alle ragionevoli aspettative dell’acquirente [11]. In base a tale principio, è lecito chiedersi se un prodotto che contenga già componenti o funzionalità tecniche integrate ma rese inaccessibili senza ulteriori pagamenti possa considerarsi conforme alle aspettative legittime del compratore medio. In linea teorica, la risposta dovrebbe essere negativa: il consumatore può ragionevolmente attendersi che un bene acquistato sia pienamente utilizzabile per le caratteristiche essenziali che presenta, salvo diversa ed esplicita pattuizione. Qualora invece alcune funzionalità presenti risultino bloccate e richiedano esborsi successivi non evidenziati con chiarezza, il bene potrebbe risultare non conforme ai requisiti di qualità e funzionamento pattuiti, con conseguente applicabilità dei rimedi previsti (ripristino della conformità, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto).
In questa prospettiva, la proprietà condizionata rischia di collocarsi al confine tra la conformità del bene al contratto e la scorrettezza contrattuale. Se le restrizioni all’uso non sono state chiaramente comunicate al momento della conclusione del contratto, potrebbe configurarsi una violazione degli articoli 20-27 del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali sleali (ingannevoli od omissive) [12]. L’omessa informazione circa il fatto che parte delle funzionalità del bene richiede ulteriori pagamenti costituisce infatti un’ingannevolezza per omissione, in quanto riguarda una caratteristica fondamentale del prodotto (la sua utilizzabilità) idonea ad orientare significativamente la decisione di acquisto del consumatore. Inoltre, le clausole contrattuali che limitano l’uso del bene subordinandolo a prestazioni ulteriori potrebbero essere considerate vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, qualora determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali [12]. Ad esempio, una clausola che imponesse al compratore l’obbligo di acquistare esclusivamente dal produttore determinati servizi o accessori per poter godere pienamente del bene potrebbe rientrare tra quelle che, presuntivamente o in concreto, sono ritenute abusive perché annullano o riducono drasticamente l’utilità della prestazione ricevuta dal consumatore [12].
Alcuni casi concreti e recenti dimostrano la rilevanza pratica del fenomeno. In Italia, ad esempio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato nel 2023 la società Tesla per pubblicità ingannevole relativa al sistema di guida assistita “Autopilot”: gli extra-costi necessari per attivare effettivamente la funzione, dopo l’acquisto dell’auto, non erano stati comunicati con sufficiente trasparenza nella fase pubblicitaria. In Francia, come accennato, le autorità di vigilanza hanno ordinato alla filiale locale di Tesla di cessare pratiche commerciali analoghe, ritenute ingannevoli, legate alla promozione di funzionalità di guida autonoma subordinandone poi l’effettiva attivazione a ulteriori pagamenti. Negli Stati Uniti, la vicenda relativa ai trattori John Deere ha assunto rilievo ancora maggiore nel dibattito pubblico: a seguito di azioni legali e di un forte movimento per il right to repair, alcuni tribunali statunitensi hanno riconosciuto agli agricoltori il diritto di accedere ai software di diagnostica e gestione dei propri macchinari, di fatto limitando le restrizioni contrattuali imposte dal produttore e garantendo ai proprietari la facoltà di riparare autonomamente i beni acquistati. Questi esempi mostrano come i confini tra proprietà materiale e controllo digitale diventino sempre più labili, generando conflitti che incidono direttamente sui diritti dei consumatori e che richiedono risposte giuridiche adeguate.
Il vuoto normativo attuale – soprattutto in relazione ai beni ibridi, ossia beni materiali dotati di componenti o funzioni digitali rilevanti – evidenzia l’urgenza di un intervento sia legislativo che interpretativo. Da un lato, la Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali (anch’essa recepita nel nostro ordinamento) offre alcune tutele, prevedendo ad esempio obblighi informativi e di aggiornamento per i contenuti digitali forniti assieme ai beni [2][10]. Tuttavia, essa copre principalmente i profili “digitali” autonomi e non risolve completamente il problema delle funzionalità intrinseche al bene materiale ma bloccate da sistemi proprietari [2]. Ne consegue che, allo stato attuale, il consumatore rischia di trovarsi proprietario solo a metà: titolare del bene in senso giuridico, ma non di tutte le utilità che da esso si potrebbero ottenere in condizioni normali. È una situazione che compromette gli obiettivi stessi delle normative a tutela del compratore, volte a garantire che chi acquista un bene ne possa godere pienamente secondo le aspettative ragionevoli.
Una possibile via per risolvere queste criticità potrebbe consistere nel delineare – de iure condendo – un nucleo minimo essenziale di funzionalità che devono rimanere inscindibilmente connesse alla titolarità del bene, sottraendole alla possibilità di esclusioni o condizionamenti contrattuali. Al di fuori di tale nucleo essenziale, le parti conserverebbero la libertà di pattuire limitazioni ulteriori, purché in modo trasparente, informato e proporzionato. In tal modo si raggiungerebbe un duplice risultato: da un lato si rafforzerebbe la posizione del consumatore, garantendogli la possibilità di esercitare un dominio effettivo e non soltanto illusorio sul bene acquistato; dall’altro, si consentirebbe alle imprese di sviluppare modelli economici innovativi (basati su servizi aggiuntivi, personalizzazioni a pagamento, ecc.) senza però sfociare in forme di sfruttamento contrattuale o di elusione delle garanzie legali. La sfida regolatoria consiste proprio nel trovare questo punto di equilibrio tra libertà contrattuale e protezione del contraente debole, tra innovazione di mercato e garanzia di trasparenza.
La proprietà condizionata si pone come un banco di prova cruciale per la disciplina consumeristica contemporanea. Essa obbliga l’ordinamento a ridefinire il confine tra la libera iniziativa economica dei produttori e la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori, primo fra tutti il diritto di proprietà nella sua sostanza. Evitare che il diritto di proprietà – riconosciuto inviolabile a livello costituzionale ed europeo – venga progressivamente svuotato del suo contenuto da prassi contrattuali aggressive, lasciando al compratore soltanto un simulacro formale di titolarità, è un obiettivo primario che il legislatore e gli interpreti dovranno perseguire per mantenere credibile ed efficace il sistema di tutele esistente.
9. Considerazioni conclusive
La proprietà condizionata rappresenta uno dei fenomeni più emblematici del mutamento che l’innovazione tecnologica e i nuovi modelli economici stanno imponendo al diritto privato contemporaneo. Pur non configurandosi (almeno per ora) come un istituto giuridico autonomo espressamente disciplinato, essa si presenta come una particolare modulazione della proprietà tradizionale, resa possibile dall’innesto di clausole contrattuali e di strumenti tecnologici capaci di comprimere l’esercizio di alcune facoltà dominicali dell’acquirente. L’effetto pratico è una frattura tra la titolarità formale e la fruizione sostanziale del bene: il consumatore diviene proprietario del bene, ma non ne dispone liberamente, poiché alcune utilità restano vincolate a ulteriori prestazioni economiche a favore del venditore o produttore.
Applicando al fenomeno i tradizionali criteri interpretativi, si colgono significativi elementi di discontinuità rispetto al passato. Sul piano letterale, la definizione codicistica della proprietà continua a esprimere un diritto “pieno ed esclusivo”, difficilmente conciliabile con limitazioni che non traggono origine da vincoli legali tipici, ma da condizioni di mercato imposte da privati. Sul piano sistematico, come si è visto, la proprietà condizionata non trova un immediato corrispettivo nelle figure note: non è usufrutto, non è comunione, non è riserva di proprietà, non è licenza d’uso – bensì una compressione pattizia delle facoltà del titolare, che lascia intatta la proprietà formale ma ne riduce l’effettività. Sul piano storico, essa rompe la tradizione che ha sempre visto nella proprietà un diritto sì elastico ma unitario, destinato a riacquistare la sua pienezza una volta cessate le limitazioni temporanee o parziali: nel nostro caso, invece, le limitazioni possono persistere indefinitamente, finché il proprietario non “riscatta” le proprie facoltà mediante ulteriori pagamenti o adempimenti. Sul piano teleologico, infine, la proprietà condizionata risponde alle esigenze economiche delle imprese in termini di massimizzazione dei profitti post-vendita, ma lo fa sacrificando la posizione del consumatore, trasformando il tradizionale diritto di dominio in un diritto d’accesso condizionato e revocabile.
Anche il confronto comparato e sovranazionale conferma la delicatezza e l’urgenza della questione. Molti ordinamenti stanno affrontando i conflitti tra produttori e acquirenti generati dal controllo digitale post-vendita dei beni: le risposte finora osservate – dai richiami delle autorità di settore, all’azione dei tribunali, fino ai primi interventi normativi – evidenziano il rischio di soluzioni frammentarie e non coordinate, se manca un quadro di regole chiare. Le direttive europee del 2019 sui beni e contenuti digitali hanno costituito un primo passo significativo, ma restano ancora parziali rispetto all’ampiezza del fenomeno, soprattutto per quanto riguarda i beni materiali arricchiti da componenti digitali. Vicende come il caso John Deere negli Stati Uniti o i provvedimenti dell’AGCM in Italia mostrano da un lato una crescente consapevolezza del problema da parte delle autorità, dall’altro il rischio che, in assenza di un intervento organico, si creino disparità applicative o lacune di tutela.
La diffusione della proprietà condizionata costringe il diritto contemporaneo a interrogarsi sulla sopravvivenza stessa del concetto di dominio pieno ed esclusivo. Se questa tendenza dovesse consolidarsi, bisognerà chiedersi se abbia ancora senso parlare di proprietà come diritto inviolabile – come fa la nostra Carta costituzionale – o se si stia progressivamente scivolando verso una concezione ridotta a mera titolarità formale, priva di contenuto effettivo e soggetta a continue ingerenze contrattuali del cedente. Appare dunque auspicabile un intervento legislativo capace di individuare un nocciolo irrinunciabile di facoltà legate al bene e di disciplinare con rigore le condizioni in cui l’esercizio di tali facoltà possa essere legittimamente subordinato a corrispettivi ulteriori. Parallelamente, occorrerà rafforzare il diritto del consumatore a un’informazione completa e a scelte contrattuali realmente consapevoli, così da prevenire sul nascere pratiche sleali e clausole abusive che svuotino di significato la proprietà trasferita.
La sfida posta dalla proprietà condizionata al diritto non è soltanto teorica, ma profondamente pratica: si tratta di garantire che l’innovazione tecnologica e la libertà di iniziativa economica possano convivere con la salvaguardia dei diritti fondamentali, affinché la proprietà continui a rappresentare un potere effettivo e non si riduca a un’illusione giuridica priva di sostanza.
[1] M. BIANCA, Diritto civile, VI. La proprietà, Giuffrè Editore, Milano, 2017.
[2] C. CAMARDI, “Prime osservazioni sulla direttiva (UE) 2019/770 sui contenuti digitali”, in Contratto e impresa, 2019.
[3] A. GAMBARO, U. MORELLO, I diritti reali, in Trattato di diritto civile, dir. da R. Sacco, UTET, Torino, 2011.
[4] S. PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Giuffrè, Milano, 1964.
[5] S. RODOTÀ, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata, Il Mulino, Bologna, 1990.
[6] A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 26ª edizione, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2023.
[7] American Dialect Society, “2023 Word of the Year Is ‘Enshittification’”, 5 gennaio 2024, disponibile su: americandialect.org/2023-word-of-the-year-is-enshittification/.
[8] The Verge, “BMW – fine degli abbonamenti ai sedili riscaldati”, 7 settembre 2023, disponibile su: www.theverge.com
[9] Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262).
[10] Direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e di servizi digitali.
[11] Direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni.
[12] D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo.
[13] Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 3 luglio 2012, causa C-128/11, UsedSoft GmbH c. Oracle.

