Pubbl. Sab, 22 Ago 2020
Del discorso politico sulla verità: il logos tra microfisica del potere e manipolazione linguistica
Modifica pagina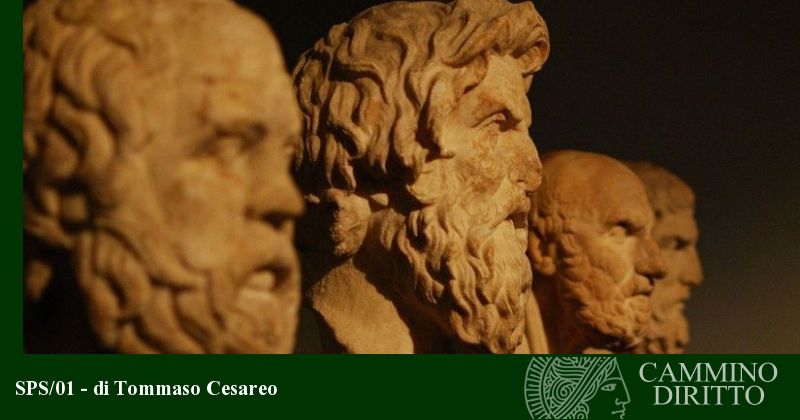
Il linguaggio costituisce uno dei mezzi più efficaci di imposizione, esercizio e conservazione del potere. Attraverso molteplici forme di estrinsecazione, il logos gioca un ruolo preminente nel processo di infusione di una certa verità politica, a fondamento del quale si profilano scontri dialettici contraddistinti, ai rispettivi poli, da narrazioni ideologicamente e linguisticamente forti. Una lizza dialettica che dispiega tutta l’efficacia manipolatrice del linguaggio, i cui schemi e funzioni tradizionali vengono talvolta messi in discussione dall’uso aberrante di cui l’uomo si rende autore. Lo scenario storico di riferimento prende le mosse da Omero e Aristotele, passando per Machiavelli, Marx, Nietzsche, Carroll, Foucault, Orwell, Eco.
 ENG
Language constitutes one of the most effective means of imposing, exercising and conserving power. Through multiple forms of expression, logos plays a pre-eminent role in the process of infusion of a certain political truth, the basis of which are dialectical clashes characterized, at their respective poles, by ideologically and linguistically strong narratives. A dialectical struggle that unfolds all the manipulative efficacy of language, whose traditional patterns and functions are sometimes questioned by the aberrant use of which man makes himself the author. The historical reference scenario starts from Homer and Aristotle, passing through Machiavelli, Marx, Nietzsche, Carroll, Foucault, Orwell, Eco
ENG
Language constitutes one of the most effective means of imposing, exercising and conserving power. Through multiple forms of expression, logos plays a pre-eminent role in the process of infusion of a certain political truth, the basis of which are dialectical clashes characterized, at their respective poles, by ideologically and linguistically strong narratives. A dialectical struggle that unfolds all the manipulative efficacy of language, whose traditional patterns and functions are sometimes questioned by the aberrant use of which man makes himself the author. The historical reference scenario starts from Homer and Aristotle, passing through Machiavelli, Marx, Nietzsche, Carroll, Foucault, Orwell, EcoSommario: 1. Introduzione; 2. La microfisica del potere: la teoria di Foucault applicata ai discorsi linguistici; 3. Connotazione politica del discorso sulla verità; 4. Dalla manomissione del linguaggio alle procedure di esclusione; 5. Dall’eroe omerico al principe machiavellico: modelli di leadership politica nella conquista e mantenimento del potere; 6. Conclusioni.
1. Introduzione
«In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e Dio era il Verbo»[1].
Così recita l’incipit del Vangelo secondo Giovanni, da cui non si può assolutamente prescindere se si vuol avviare un’indagine sul potere del logos.
Nel 1991, durante la cerimonia di assegnazione del premio Nobel per la letteratura, la vincitrice Nadine Gordimer disse:
«In principio era il Verbo. Il Verbo era presso Dio, indicava la Parola di Dio, la Parola della Creazione. Ma lungo i secoli di cultura dell’uomo, la parola ha acquisito altri significati, profani oltre che religiosi. Avere la parola è diventato sinonimo di autorità suprema, prestigio, potere di persuasione, immenso e talvolta pericoloso; vuol dire apparire in prima serata, a un talk-show televisivo, avere il dono dell’eloquenza oltre quello delle lingue […]»[2].
Illuminante a tal proposito è una pagina del Faust di Goethe, allorché il protagonista si mette a tradurre, poco prima che gli appaia Mefistofele, l’inizio del Vangelo di Giovanni:
«Sta scritto: “Nel principio era la Parola”. E eccomi già fermo. Chi m’aiuta a procedere? M’è impossibile dare a “Parola” tanto valore. Devo tradurre altrimenti, se mi darà giusto lume lo Spirito. Sta scritto: “In principio era il Pensiero”. Medita bene il primo rigo, ché non ti corra troppo la penna. Quel che tutto crea e opera, è il Pensiero? Dovrebb’essere: in principio era l’Energia. Pure, mentre trascrivo questa parola, qualcosa già mi dice che non qui potrò fermarmi. Mi dà aiuto lo Spirito! Ecco che vedo chiaro e, ormai sicuro, scrivo: “In principio era l’Azione”!»[3].
Il termine logos viene utilizzato per indicare la parola, il discorso, la lingua, la ragione. Il linguaggio è costituito da un complesso di solide regole che consentono ad un determinato gruppo di persone di interagire fra di loro, rendendo possibile una vita comunitaria. Non a caso, la “logica” non solo ha la stessa radice di logos, ma è proprio la scienza che si propone di studiare il pensiero in quanto manifestato[4].
Il logos è anche il discorso congegnato in ossequio ad una ratio grammaticale, ad un codice formale di principi. È una struttura intrisa del canone della coerenza, dove ordine del pensiero ed ordine delle cose collimano[5].
Tuttavia, l’incipit del Vangelo di Giovanni va oltre il concetto di logos come sistema di comunicazione fra soggetti. Il potere dell’intelletto umano trasforma la parola in un quid pluris rispetto ad un assetto convenzionale di comunicazione: conferisce al termine una veste metafisica (“divina”, nel caso di specie) che solo l’uomo è in grado di indossare, in quanto diverso dalle altre specie biologiche.
Come suggerisce Aristotele, il logos è un tratto distintivo dell’uomo, che il filosofo definisce «animale politico», il quale è portato naturalmente alla vita in società[6].
L’obiettivo di questo contributo, senza alcuna pretesa di esaustività, è quello di analizzare i diversi usi che della parola si possono fare, in particolar modo il potere dell’oratore di manipolare la verità a scopi politici. Infatti, la manipolazione linguistica, quando applicata alla retorica governativa, tende a mantenere il cittadino medio all’oscuro della reale conoscenza della verità politica[7].
L’assunto è che lo stato, in quanto tale, funzioni a prescindere dalla comunità e dai suoi componenti. Esso, per mezzo di soggetti abili nella persuasione del cittadino medio, conduce un’opera di indottrinamento che si prefigge di inculcare una specifica visione ideologica, sul presupposto di una scissione della realtà in ciò che è “vero” e ciò che è “falso” o, ancora, tra “giusto” e “sbagliato”.
Il risultato finale è la creazione di un modello privilegiato di interpretazione della realtà o, come direbbe anche Marx, la tessitura di un «vestito di idee», cioè una concezione che voglia adornare di idee e principi astratti la concreta realtà dei fatti materiali, camuffandoli e fornendone una surrettizia giustificazione[8].
2. La microfisica del potere: la teoria di Foucault applicata ai discorsi linguistici
Luminare delle questioni intorno al potere è Michel Foucault, il quale ne disserta metodicamente in tutte le sue opere principali, costituendone il punto centrale di riflessione e segnando una linea di demarcazione rispetto alle concezioni tradizionali.
La colonna portante di questo elaborato vuol esser rappresentata proprio da un suo saggio, intitolato Microfisica del potere[9], le cui questioni fondamentali possono essere condensate sotto un duplice profilo: il rapporto tra potere e sapere e la localizzazione del potere.
Quanto al primo profilo, Foucault richiama «La volontà di potenza» di Nietzsche, definito icasticamente come «il filosofo del potere», secondo cui tutti i discorsi, caldeggiando una determinata verità, portano con sé una volontà di potenza, la quale, spingendo verso una direzione, si fonda necessariamente sulla contrapposizione tra vero e falso[10]. Il filosofo francese osserva che «ogni società ha il suo proprio ordine della verità, la sua politica generale della verità: essa accetta cioè determinati discorsi, che fa funzionare come veri». Ciò significa che sapere e potere sono indisgiungibili, in quanto l’esercizio del potere genera nuove forme di sapere ed il sapere porta sempre con sé effetti di potere[11].
Il secondo problema fondamentale si riassume in una domanda: dove si localizza il potere? Foucault per “potere” intende non già quello concentrato in via esclusiva nelle mani di un sovrano, il quale lo traspone in determinate fonti normative, bensì quello diffuso in ogni angolo della società, onnipresente nelle relazioni sociali fra individui.
In base a queste premesse generali, Foucault elabora una vera e propria «microfisica del potere», alla cui stregua il potere:
non è qualcosa che si divide tra coloro che lo possiedono o coloro che lo detengono esclusivamente e coloro che non lo hanno o lo subiscono. Il potere deve essere analizzato come qualcosa che circola, o meglio come qualcosa che funziona solo a catena. Non è mai localizzato qui o lì, non è ai nelle mani di alcuni, non è mai appropriato come una ricchezza o un bene. Il potere funziona, si esercita attraverso un’organizzazione reticolare[12].
Alla «macrofisica del potere» di Marx, imperniata sulla rigida dicotomia dominanti-dominati (ad esempio Stato-sudditi, borghesia-proletariato), Foucault contrappone la sua «microfisica del potere», che mette in rilievo, invece, le molteplici tattiche di assoggettamento, superando così la visione manichea fra «soggetti» e «oggetti» ed introducendo il concetto di «resistenza» al potere[13].
In altri termini, il potere non è appannaggio esclusivo delle istituzioni, che siano aule parlamentari, governative o giudiziarie, ma è anche quello che proviene dal basso, dalle molteplici relazioni tra consociati: esso «si produce in ogni istante, in ogni punto, o piuttosto in ogni relazione fra un punto e l’altro»[14].
Ebbene, uno dei metodi più efficienti di imposizione di un potere, specie di una verità politica, è proprio la interazione verbale fra soggetti. Partendo dalla teoria di Foucault, è possibile affermare che nei dialoghi, a cui prendono parte due o più persone, c’è sempre un soggetto che tenta di imporre il proprio sapere sugli altri interlocutori.
Assumendo come esistente una “disparità di armi” fra soggetti del discorso, la parte più “forte” porta avanti il suo scopo di dominio su quella più “debole”[15].
È proprio qui che il logos rompe con la dimensione strettamente formalistica: allontanandosi dalle regole generali di comunicazione e forgiando delle eccezioni, esso palesa le difficoltà di ricondurre il sistema ad uno schema rigido di norme. Non si può pensare il logos (come ragionamento) senza pathos, in quanto l’emozione di chi parla gioca un ruolo fondamentale nell’imposizione del potere. È attraverso il pathos che l’oratore è in grado di influenzare emotivamente l’interlocutore per manipolarlo a suo piacimento, valorizzando al contempo l’uso creativo del linguaggio[16].
Jean-Jacques Rousseau, rifiutando la teoria dell’origine del linguaggio fondata sulla necessità della sopravvivenza collettiva, sostiene che le prime parole sono nate per dare sfogo agli impulsi emozionali e dipendono non dalla sfera razionale, bensì da quella sentimentale[17].
Se l’oratore mira ad infondere nell’ascoltatore l’emozione per come egli stesso l’avverte, allora non è difficile ricostruire una logica simile in termini di manipolazione politica: l’oratore può esprimere una volontà affinché l’altra parte sappia o faccia qualcosa riguardo a qualcuno o qualcosa.
La retorica è quindi utilizzabile in qualsiasi contesto, indipendentemente dalle circostanze concrete della discussione. La capacità dell’oratore di ispirare determinate emozioni nell’ascoltatore, secondo Aristotele, è fondamentale perché gli uomini non giudicano allo stesso modo se amano o odiano[18].
In particolare, Eugene Garver scrive in proposito che Aristotele vuole dimostrare che le attività essenziali per la cittadinanza ed il benessere umano possano essere rappresentate come una vera e propria arte[19]: in tal senso, la retorica costituisce un’arte civica informata ai canoni dell’etica e della politica[20]. A questa si affianca la retorica come arte professionale che, mirata al fine esterno del successo nella persuasione, dimostra tutta la sua valenza antitetica rispetto al perseguimento del bene dei cittadini[21].
Anche Kant sembra avallare l’orientamento di Aristotele, pertanto collocandosi nel solco dei detrattori dell’ars oratoria. Infatti, il filosofo tedesco sostiene che:
«L’eloquenza e l’arte del dire (insieme, retorica) appartengono alle arti belle; ma l’arte oratoria (ars oratoria), in quanto arte di servirsi della debolezza umana ai propri fini […], non merita alcuna stima»[22].
Questa antitesi è essenziale, per questo contributo, a costruire un rapporto dicotomico della retorica, il cui lato professionale ed emotivo (dunque “creativo”, nei termini sopra chiariti), implicante una volontà di potere, si innesta con vigore nei meccanismi di manipolazione dei membri della comunità; il lato civico, al contrario, porta con sé effetti di benessere per i cittadini, indicante una certa affidabilità di colui che profferisce il logos politico.
Ebbene, atteso l’enunciato rapporto di strumentalità tra infusione di un sentimento e creazione di un giudizio, è chiaro che la condizione emotiva sarà uno degli elementi su cui il retore farà maggiore perno, allo scopo di innescare una certa opinione su una questione controversa[23].
A questo punto emerge con chiarezza il principio di squilibrio di Lewis Carroll, rinvenibile in un celebre passo di Attraverso lo specchio:
«Quando io uso una parola» disse Humpty Dumpty in tono alquanto sprezzante, «questa significa esattamente quello che decido io… né più né meno».
«Bisogna vedere» disse Alice «se lei può dare tanti significati diversi alle parole».
«Bisogna vedere» disse Humpty Dumpty «chi è che comanda… è tutto qua»[24].
Humpty Dumpty sfida la curiosa Alice e rompe il suo codice formale di comunicazione, servendosi della propria abilità nell’interpretarlo per creare nuovi significati. L’espressione «bisogna vedere chi è che comanda» è fortemente rivelatrice: ciò che conta non è la convenzione verbale generale, ma la destrezza soggettiva a giostrarsi all’interno di essa, attraverso la rappresentazione, in un discorso, di significati individuali, talora rimanendo nel perimetro del codice formale di riferimento, talaltra fuoriuscendone o, per così dire, violando le regole comuni di comunicazione[25].
Sotto quest’ultimo aspetto, è suggestivo richiamare la contrapposizione dicotomica che Nietzsche, ne La nascita della tragedia, stabilisce tra Apollo e Dioniso, laddove quest’ultimo, metaforicamente, potrebbe essere rappresentato dalla figura dell’oratore.
Walter Kaufmann riassume la categoria estetica del dionisiaco nella “frenesia degli ubriachi” che minaccia di distruggere tutte le forme e i codici[26]. Questa frenesia, come parte del culto di Dioniso, potrebbe in questa sede essere ricondotta, simbolicamente, alla volontà dell’oratore di infrangere le regole convenzionali, fino al punto da distruggerle completamente.
La volontà di distruzione, come afferma Gilles Deleuze, è la contraddizione
«tra l’unità primitiva e l’individuazione, tra il volere e l’apparire, tra la vita e la sofferenza»[27].
La contrapposizione, secondo il filosofo francese, si riflette nell’opposizione binaria tra Apollo e Dioniso:
«Apollo è il principio di individuazione in forma divina, crea l’apparenza dell’apparenza, la bella apparenza, il sogno o l’immagine plastica […]. Dioniso, per contro, fa ritorno all’unità primitiva, distrugge l’individuo trascinandolo nel grande naufragio dell’essere originario da cui viene assorbito»[28].
Deleuze conclude sostenendo che Dioniso ed Apollo non sono in contrapposizione come termini interni ad una contraddizione, ma piuttosto come due modi antitetici per risolverla, in cui l’antitesi deve essere trasformata in unità. La tragedia è quindi conciliazione, dove si concretizza «l’oggettivazione di Dioniso all’interno di una forma e di un mondo apollinei»[29].
Da qui un’evidente allusione a ciò che è stato già detto a proposito della retorica aristotelica. Essa consiste in ciò, che la componente civica della retorica si associa ai profili dell’ordine, armonia e bellezza di Apollo, e quella professionale a quelli del caos, distruzione e bruttezza di Dioniso. Ma la volontà di distruzione dionisiaca significa anche libertà di infrangere le regole, che porta inevitabilmente a risultati di creatività, soprattutto linguistica.
3. Connotazione politica del discorso sulla verità
Ne Il nome della Rosa Umberto Eco rende perfettamente tangibile l’idea della connotazione politica del logos. Attraverso due paradigmi illuminanti, che qui potremmo definire veri e propri miti bartesiani, l’Autore non solo disvela una certa credenza storica, ma soprattutto ne sottolinea la funzione ideologica di naturalizzazione[30].
Il primo esempio è quello di Gesù concepito come l’unico vero Dio triste:
«Si parlava del riso,» disse seccamente Jorge. «Le commedie erano scritte dai pagani per muovere gli spettatori al riso, e male facevano. Gesù Nostro Signore non raccontò mai commedie né favole, ma solo limpide parabole che allegoricamente ci istruiscono su come guadagnarci il paradiso, e così sia.»
«Mi chiedo,» disse Guglielmo, «perché siate tanto contrario a pensare che Gesù abbia mai riso. Io credo che il riso sia una buona medicina, come i bagni, per curare gli umori e le altre affezioni del corpo, in particolare la melanconia.»
[…]
Risponde Jorge: «Il riso squassa il corpo, deforma i lineamenti del viso, rende l'uomo simile alla scimmia.»
«Le scimmie non ridono, il riso è proprio dell'uomo, è segno della sua razionalità,» disse Guglielmo.
«E' segno della razionalità umana anche la parola e con la parola si può bestemmiare Dio. Non tutto ciò che è proprio dell'uomo è necessariamente buono. Il riso è segno di stoltezza. Chi ride non crede in ciò di cui si ride, ma neppure lo odia. E dunque ridere del male significa non disporsi a combatterlo e ridere del bene significa disconoscere la forza per cui il bene è diffusivo di sé.»
[…]
Guglielmo: «Plinio il Giovane scrisse: “Qualche volta inoltre rido, scherzo, gioco, perché sono uomo.”»
[…]
«Erano pagani», rispose Jorge. «La Regola proibisce con parole severe queste banalità.»[31]
In questo passo viene esaltata l’ossessione di Jorge per l’idea che Gesù non abbia mai riso. Umberto Eco mette in luce la struttura religiosa di un’ideologia che predilige un’interpretazione del mito di Gesù piuttosto che un’altra, manipolando la verità ed esercitando una volontà di potere che rispecchia appieno la teoria di Foucault.
È essenziale tenere a mente che questo romanzo è ambientato nel Basso Medioevo, quando l’Europa era estremamente povera e l’idea del Dio triste, che ha sofferto per assolverci dai nostri peccati, era assolutamente calzante col progetto manipolativo di sopprimere ogni altra rappresentazione della realtà che non si riassumesse nella miseria.
Il secondo esempio riportato da Eco riguarda la Poetica di Aristotele:
Guglielmo: «voglio vedere il secondo libro della Poetica di Aristotele, quello che tutti ritenevano perduto o mai scritto, e di cui tu custodisci forse l'unica copia»[32]
[…]
Jorge: «come hai indovinato che si trattava del secondo libro di Aristotele?»
Guglielmo: «I tuoi anatemi contro il riso […] Qui Aristotele vede la disposizione al riso come una forza buona, che può avere anche un valore conoscitivo […] ci fa dire: ecco le cose stavano proprio così, e io non lo sapevo. La verità raggiunta attraverso la rappresentazione degli uomini, e del mondo, peggiori di quello che sono o di quello che li crediamo, peggiori in ogni caso di come i poemi eroici, le tragedie, le vite dei santi ce li hanno mostrati...»[33]
Nel dialogo fra i due uomini, si scorge l’atteggiamento post-strutturale di Eco a ricercare la verità andando oltre il rigido binarismo vero-falso, giusto-sbagliato.
Tuttavia, il bibliotecario Jorge preferisce tenere lontana la parte “scomoda” per la ideologia dominante del tempo:
Guglielmo: «Perché hai voluto proteggere questo libro più di tanti altri?»
Jorge: «Perché era del Filosofo. Ogni libro di quell'uomo ha distrutto una parte della sapienza che la cristianità aveva accumulato lungo i secoli.»[34]
Il secondo libro della Poetica sulla commedia, conservato nell’impenetrabile biblioteca dell’abbazia nella quale si svolge la vicenda, viene descritto dall’Autore come l’unica copia esistente dell’opera[35].
La filosofia di Aristotele ebbe un ruolo preponderante nella creazione dell’ideologia medievale, soprattutto in ordine all’istituzione della dicotomia giusto-sbagliato, costituente l’unico criterio per orientare le scelte umane, rispettivamente, nella retta o errata direzione. Ma l’uso che si fece di tale filosofia fu del tutto arbitrario: l’assoluta discrepanza tra i canoni cui attenersi per costruire la comunità perfetta, varati dal luminare greco, e la relativa applicazione in epoca medievale da parte del cristianesimo, costituisce una vera e propria aberrazione del messaggio lanciato dallo Stagirita[36].
Ciò a dimostrazione, per giunta, della strumentalizzazione della filosofia a scopi governativi, con la conseguente diffusione di narrazioni ideologicamente forti che modellano la realtà in base ad una specifica volontà di potere[37].
4. Dalla manomissione del linguaggio alle procedure di esclusione
L’intervento modificativo sul patrimonio linguistico di uno stato rientra tra le forme di manipolazione politica più efficaci. In effetti, se determinati vocaboli vengono eliminati dal repertorio comune di parole, certamente non potranno nemmeno entrare nella mente dei consociati.
La dipendenza del pensiero, in termini di sviluppo cognitivo di ciascun essere umano, dal tipo di lingua parlata è alla base della c.d. teoria della relatività linguistica, o ipotesi di Sapir-Whorf.
Secondo Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf, ogni lingua rappresenta una visione del mondo unica, incompatibile con ogni altro modo di percepire la realtà esterna. I parlanti sono prigionieri della loro lingua materna, incapaci di liberarsi dalle categorie e divisioni che la struttura della loro lingua impone sulle percezioni ed i pensieri[38].
Con le parole di Sapir:
«il mondo reale viene costruito, in gran parte inconsciamente, sulle abitudini linguistiche del gruppo. Non esistono due lingue che siano sufficientemente simili da essere considerate come rappresentanti della stessa realtà sociale […]. Noi vediamo e udiamo e facciamo altre esperienze in un dato modo, in gran parte perché le abitudini linguistiche della nostra comunità ci predispongono a certe scelte di interpretazione»[39].
Per spiegare gli effetti concreti che la teoria della relatività linguistica è in grado di provocare sul campo politico, si vuol prendere come paradigma esemplare la “Neolingua” orwelliana, nel suo famoso romanzo distopico 1984.
Innanzitutto, l’esistenza di una “Neolingua” (“Newspeak”) implica un rapporto dicotomico con una “Archelingua” (“Oldspeak”), presupposto necessario per rappresentare un mondo distopico nel quale il governo politico totalitario dichiara di voler costruire una società migliore della precedente.
Compito della neolingua, nel romanzo, è di radicarsi nel regime di Oceania al punto da relegare nel dimenticatoio la vecchia lingua parlata:
«Fine della Neolingua […] era […] soprattutto quello di rendere impossibile ogni altra forma di pensiero. […] a parte la soppressione di parole di carattere palesemente eretico, la riduzione del vocabolario era considerata fine a se stessa, e di nessuna parola di cui si potesse fare a meno era ulteriormente tollerata l’esistenza. La Neolingua era intesa non a estendere, ma a diminuire le possibilità del pensiero; si veniva incontro a questo fine appunto, indirettamente, col ridurre al minimo la scelta delle parole. […] Ogni riduzione rappresentava una conquista, perché più piccolo era il campo della scelta e più limitata era la tentazione di lasciar spaziare il proprio pensiero.[40]»
È forse un caso che, nella Neolingua di Orwell, la gran parte di parole soppresse, in quanto largamente ostili al potere despotico, ruota attorno ai concetti di libertà e uguaglianza? Grazie al nuovo lessico, per ricomprenderli entrambi basta una sola parola: «psicoreato».
«Parole che un tempo avevano avuto un significato venivano pur mantenute, talvolta, per via della convenienza, ma il significato sfavorevole era come purgato. Innumerevoli altre parole, come onore, giustizia, morale, internazionalismo, democrazia, scienza e religione avevano semplicemente cessato del tutto di esistere. Poche parole avevano la funzione di ricoprirle, e ricoprendole le abolivano. Tutte le parole che si raggruppavano intorno ai concetti di libertà e di eguaglianza, ad esempio, erano contenute nella semplice parola psicoreato.»[41]
L’intervento sull’impianto tradizionale delle parole, dunque, permette al regime totalitario di attingere i propri obiettivi di controllo sulla vita delle persone e di porre un divieto di iniziativa individuale o collettiva, nell’ottica della creazione di una compagine sociale scriteriata che accetta passivamente il dominio dall’alto. All’interno del patrimonio storico, molti sono i casi di manomissione linguistica a scopi politici, primi fra tutti la lingua nazista del Terzo Reich[42] e la riforma linguistica turca introdotta da Atatürk[43], la cui trattazione, per ragioni di opportunità, viene rinviata ad altra sede.
Come ne Il nome della rosa di Eco, così in 1984 di Orwell, viene limpidamente alla luce in primis la logica conflittuale tra due visioni della realtà, ciascuna spalleggiata da una certa ideologia, e, di conseguenza, il processo di mascheramento di una verità politicamente scomoda per un soggetto che esprime la propria volontà di potere.
Quando, nel romanzo, Guglielmo da Baskerville dice a Jorge da Burgos
«Non elimini il riso eliminando questo libro»[44],
si manifesta tutta la valenza della teoria della relatività linguistica di Sapir-Whorf e del progetto aberrante della Neolingua orwelliana. La realtà celata del riso aristotelico-cristiano determina la repressione della gioia di vivere, permeando l’epoca medievale di un’atmosfera di tragedia e tristezza, la quale rifiorirà, filosoficamente ed eticamente, soltanto col rinnovamento rinascimentale.
Un discorso sulla verità, secondo Michel Foucault, dipende dalla «formazione di oggetti», pilastro fondamentale delle relazioni discorsive:
«le relazioni discorsive […] si trovano al limite del discorso: gli offrono gli oggetti di cui può parlare o piuttosto […] determinano il fascio di rapporti che il discorso deve effettuare per poter parlare di questi e di quegli oggetti, per poterli trattare, nominare, analizzare, classificare, spiegare, ecc. Queste relazioni non caratterizzano la lingua utilizzata dal discorso e neppure le circostanze in cui si svolge, ma il discorso stesso in quanto pratica.»[45]
In particolare, il discorso sulla verità politica, osserva il filosofo francese, si fonda sulle procedure di esclusione, veri e propri meccanismi di segregazione linguistica:
«In una società come la nostra si conoscono, naturalmente, le procedure di esclusione. La più evidente, ed anche la più familiare, è quella dell’interdetto. Si sa bene che non si ha diritto di dir tutto, che non si può parlare di tutto, che chiunque, insomma, non può parlare di qualunque cosa.»[46]
L’interdetto foucaultiano costituisce un problema del linguaggio, per cui certi discorsi non sono praticabili da tutti gli individui ed in ogni circostanza. Ci sono delle parole tabù che, pur linguisticamente esistenti, non possono essere oggetto di discussione, come la sessualità e la politica[47].
La logica qui è simile a quella della Neolingua di Orwell[48]: rimanere in silenzio su alcuni argomenti produce effetti negativi sulla società, poiché la mancanza di confronto e di informazione impedisce lo scambio di idee, col rischio di una stasi sia nell’espressione della personalità umana sia nel progresso della società stessa[49].
Ulteriore formula di esclusione, per Foucault, è rappresentata dall’opposizione tra ragione e follia. Nella Storia della follia nell’età classica[50], il pensatore francese esordisce citando un passo del Diario di uno scrittore di Dostoevskij, quasi a mo’ di manifesto del suo intero trattato:
«Non è rinchiudendo il vicino che ci si convince del proprio buon senso»[51].
Da questo incipit si sviluppa la critica di Foucault nei confronti della pratica, tipica del mondo occidentale, di estromettere i malati di mente dalla comunità, allo scopo di tenere al sicuro le persone psichicamente sane.
Il rapporto dicotomico è quindi fra ragione e non-ragione:
«Originaria è la cesura che stabilisce la distanza fra ragione e non-ragione; quanto alla presa che la ragione esercita sulla non-ragione per strapparle la sua verità di follia, di errore o di malattia, essa ne deriva, e da lontano»[52].
L’analisi prosegue per giungere alla equiparazione della non-ragione con la follia, la quale implica libertà di linguaggio, e della sanità mentale con la capacità di ragionamento, al contrario condizionata dalla presenza di vincoli, regole ed ordini[53].
Ma è proprio la letteratura, sostiene Foucault, che disvela tutti i limiti di questa logica, ormai retaggio non più compatibile con il divenire: l’essere la follia «irreparabilmente meno della storia»[54]. Egli rinviene nella relazione tra filosofia razionalista e procedure di esclusione (l’internamento) la causa del silenzio nel quale è riassunta la follia nell’age classique e dal quale essa si affrancherà solo con l’avvento del lirismo della poesia romantica, il cui messaggio di protesta le permetterà di riacquistare quell’anima di “manifestazione” e “rivelazione” tipica della letteratura del Seicento, da Shakespeare a Cervantes[55].
Il riferimento a Shakespeare e Cervantes è qui utile per affrontare la questione del volto politico della follia. Quest’ultima, se si attinge all’eredità letteraria mondiale, viene rappresentata attraverso una molteplicità di personaggi nei quali si incarnano atteggiamenti eterogenei verso la verità politica.
Nel teatro shakesperiano, ad esempio, Amleto, con la sua pazzia simulata, manipolando i suoi interlocutori per scoprire una verità specifica, combatte da solo le ingiustizie di una monarchia corrotta[56]. Nella stessa ottica si può pensare alla follia di Lady Macbeth derivante dall’abbandono della coscienza, non più in grado di reagire a causa delle scelleratezze compiute[57].
Il personaggio di Don Chisciotte della Mancia, partorito dalla penna di un acuto razionalista[58], finisce per essere patrocinatore di una molteplicità di ideali, attrezzato di una poderosa immaginazione/pazzia che da motivo di critica e derisione si evolve in impulso idealistico, intriso del valore della libertà. Il protagonista del romanzo di Cervantes si fa propulsore di quelle idee che, perché ritrovino la propria ragion d’essere, richiedono il rovesciamento dell’ordine costituito. Ma l’incedere del Chisciotte verso il suo fedele scopo è interrotto da una presa di coscienza amara: la progressiva crescita di una dimensione borghese, emblema della dottrina mercantilista che non lascia spazio all’idealismo. L’elemento politico consiste in ciò, che la verità in realtà non esiste, non si trova da nessuna parte[59].
Sulla stessa linea del discorso del folle di Foucault si colloca il logos di un bambino, che in tutta la sua innocenza è in grado di rivelare inconsciamente una verità politica sgradita. Si riporta di seguito, a titolo esemplare, uno spezzone della famosa fiaba di Hans Christian Andersen:
“E così l'imperatore aprì il corteo sotto il bel baldacchino e la gente che era per strada o alla finestra diceva: «Che meraviglia i nuovi vestiti dell'imperatore! Che splendido strascico porta! Come gli stanno bene!”.
Nessuno voleva far capire che non vedeva niente, perché altrimenti avrebbe dimostrato di essere stupido o di non essere all'altezza del suo incarico. Nessuno dei vestiti dell'imperatore aveva mai avuto un tale successo.
“Ma non ha niente addosso!” disse un bambino. “Signore sentite la voce dell'innocenza!” replicò il padre, e ognuno sussurrava all'altro quel che il bambino aveva detto.
“Non ha niente addosso! C'è un bambino che dice che non ha niente addosso!”
“Non ha proprio niente addosso!” gridava alla fine tutta la gente. E l'imperatore, rabbrividì perché sapeva che avevano ragione, ma pensò:
“Ormai devo restare fino alla fine”. E così si raddrizzò ancora più fiero e i ciambellani lo seguirono reggendo lo strascico che non c'era.»[60]
Come nel romanzo di Carroll, così nella fiaba di Andersen non bisogna farsi ingannare dalla semplicità della narrazione: da essi trapela un messaggio apparentemente rivolto a persone di tenera età, ma in realtà diretto ad un pubblico molto più vasto.
Quello che hanno in comune il logos del folle e del bambino è l’assenza di vincoli autoimposti, che si risolve inevitabilmente nella libertà incontrollata del linguaggio: il loro potere di enunciare la verità, a dispetto del silenzio prescritto dall’autorità dominante, deriva a ben guardare dal profondo del loro inconscio[61].
Da ciò risulta chiara la logica foucaultiana sull’esclusione degli insani di mente, attraverso pratiche di internamento volte a tracciare una linea di demarcazione rispetto ai soggetti sani, ed il tentativo di smentire quanto schiettamente profferito dal bambino, il cui padre stesso ne denuncia l’animo d’innocenza alle persone ivi presenti.
In conclusione, è possibile affermare che nelle relazioni discorsive la verità politica viene spesso manipolata per mezzo di alterazioni linguistiche arbitrarie, a dimostrazione della tendenza umana ad ignorare, trascurare e relegare tutti quei discorsi sulla verità che risultano scomodi per l’ideologia radicata in una data comunità.
5. Dall’eroe omerico al principe machiavellico: modelli di leadership politica nella conquista e mantenimento del potere
Ogni società che voglia assurgere ad una condizione di stabilità deve avere necessariamente un proprio leader politico. È tale colui che esercita una leadership su un dato gruppo sociale e che riesce ad influenzare soggetti a lui subordinati[62], grazie al possesso di qualità particolari che gli consentono di imporsi in campo politico[63]. Mutuando il significato del verbo inglese to lead, essi devono essere in grado di “condurre”, “guidare” la società verso il bene desiderato, non facendosi condizionare dallo scenario esistente ma, al contrario, creandolo mediante tecniche di coordinamento degli individui e dei gruppi sociali[64].
Sin dagli albori della civiltà occidentale, le tecniche di conquista e conservazione del potere non hanno mai assunto un atteggiamento statico, bensì hanno dimostrato tutta la loro dinamicità e versatilità rispetto alle circostanze storiche concrete.
Nell’età classica si è passati dallo scontro fisico diretto (es. la guerra), dove vige una tendenziale “parità delle armi”, all’utilizzo creativo e manipolativo dell’intelletto, di cui sono muniti solo alcuni individui che se ne servono per raggiungere i propri scopi politici[65]. Dai leggendari duelli tra Achille ed Ettore (Iliade di Omero) o tra Beowulf e Grendel (Beowulf) alla metis, hybris e outis di Ulisse (Odissea di Omero).
L’intelligenza attiva (metis), che prima di agire prevede e pondera le possibilità in gioco, ha come logici corollari la pazienza, astuzia, prudenza ed abilità[66]. In effetti, se fossero mancate certe virtù all’Odisseo, con ogni probabilità non si sarebbe attinto l’esito vittorioso nella guerra di Troia. Non sarebbero risultati sufficienti il solo coraggio, l’audacia e la forza degli eserciti militari. Se esiste una condicio sine qua non della conquista della città troiana, è da individuarsi nello stratagemma del cavallo di legno, che non sarebbe stato possibile senza la metis di Ulisse[67].
A ben guardare, l’eroe acheo dell’Iliade non differisce dal protagonista dell’Odissea quanto all’an di metis, ma ne diverge in relazione al quomodo. In altri termini, cambia il contesto: quella richiesta per ritornare ad Itaca è un’intelligenza che s’ha da usare in maniera pronta, regolare e costante, a differenza dell’espediente impiegato nella guerra di Troia, escogitato al solo fine di conquistare la città e perciò esauritosi con la riuscita dell’impresa[68]. Basti pensare alla messa in atto degli inganni (doloi), strumenti che, strettamente derivanti dalla metis, hanno come fine ultimo la salvezza dell’eroe[69].
La stessa metis compare sotto altra veste quando Odisseo, allorché il ciclope Polifemo gli chiede come si chiami, risponde usando la parola “Nessuno” (oud-eis - outis) come nome proprio. In realtà è il diminutivo del suo nome, che in greco significa anche e appunto “nessuno”[70]. Quando il gigante con un solo occhio chiama i suoi compagni, dopo essere stato accecato, e loro gli chiedono chi sia stato a cagionargli quel male, egli replica senza indugio: “Nessuno”. Senza badare al fatto che essi non avrebbero inteso la parola come nome proprio, bensì come pronome indefinito. Tanto dimostra che le parole, in mano a chi detiene la metis, possono essere utilizzate nel modo più conveniente all’oratore, che fa della sua prodigiosa abilità di linguaggio la sua arma di manipolazione[71].
Prima di lasciare la Terra dei Ciclopi, però, Ulisse rivela a Polifemo il suo vero nome per farsi beffa di lui. Quest’atto di hybris (arroganza, tracotanza, superbia) sarà per lui causa di condanna divina, che lo obbligherà a rimanere in mare per oltre dieci anni: infatti, Poseidone, che di Polifemo è il padre, viene pregato dal figlio di lanciare una maledizione sull’eroe dell’Odissea, affinché questi non ritorni in patria. Ulisse, rompendo l’ordine universale che mantiene in armonia uomini, divinità e cose, travalica i giusti limiti che l’umana specie deve rispettare per poter convivere pacificamente all’interno del cosmo[72].
In definitiva, si può affermare che aspetti come metis, outis e hybris, sono indici positivi dell’idoneità dell’eroe classico (nella specie, Odisseo), vincitore di molteplici avversità, ad essere un vero e proprio leader politico.
Molto più tardi, durante il Rinascimento, la reviviscenza dei valori del mondo antico divenne fonte di profonda ispirazione per Nicolò Machiavelli, il quale evocò valori ed eventi fondamentali della civiltà classica che potessero assurgere a modello per la società a lui contemporanea: tra i più importanti, l’eccellente virtù degli antichi, capaci di nobilitare e rendere prospera e potente la propria patria[73].
L’individualismo ed umanesimo rinascimentale, in un contesto storico caratterizzato dalle città-stato del XV e XVI secolo, furono condizioni imprescindibili per la formazione della filosofia politica di Machiavelli.
Invero, sia Il Principe che I Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio contengono modelli generali di governo politico della comunità sociale, rispettivamente del principato e della repubblica, fondati sul principio della leadership per la conquista ed il mantenimento del potere.
Machiavelli sostiene che il leader politico può giungere addirittura ad essere crudele quando sia indispensabile per la salvaguardia del potere, a patto che tale crudeltà apporti effetti favorevoli a tutto il popolo. In tal modo, viene a delinearsi una forma di governo fondata insieme sull’amore e paura della comunità governata, in cui spetta al principe saper «usare bene sia le qualità della bestia che quelle dell’uomo»:
«Dovete dunque sapere che due sono i modi di combattere: l’uno, con le leggi; l’altro, con la forza. Il primo è proprio dell’uomo, il secondo, delle bestie: ma poiché il primo modo molte volte non basta, conviene ricorrere al secondo. È pertanto necessario che un Principe sappia usare bene sia le qualità della bestia che quelle dell’uomo»[74]
A rafforzare questo pensiero è il richiamo ad una delle più suggestive metafore non solo dell’antichità classica, ma anche della storia della filosofia politica, per la quale si pensava che il centauro Chirone (personaggio mitologico, metà uomo e metà cavallo) avesse educato Achille:
«Per mezzo di un mito, questo principio è già stato fornito ai Principi dagli antichi scrittori, quando hanno narrato che Achille, e molti altri principi dell’antichità, furono affidati al centauro Chirone perché li allevasse e li educasse tenendoli sotto la sua disciplina. E avere un precettore metà bestia e metà uomo, significa che un Principe deve saper usare l’una e l’altra natura: e l’una senza l’altra non permette di mantenere il potere.»[75]
A ben vedere, l'orientamento del Machiavelli mette in luce i principi della moderna concezione occidentale di leadership politica. Essi illustrano la necessità del ricorso alla crudeltà nei confronti di quei componenti della comunità che non partecipano al progetto platonico-aristotelico di ordine sociale.
La teoria machiavellica è chiara al riguardo: se i soggetti non si schierano dalla parte dei “buoni” – laddove questi s’identificano nel “collettivo” – significa che essi non sempre possono essere controllati e contrastati con lo strumento legislativo, tipicamente previsto per gli uomini, ma talvolta c'è bisogno dell'uso della forza e della violenza. In altri termini, per combattere questi individui “cattivi” – cioè coloro che sono diversi dal resto, che rompono col “collettivo” – è necessario valersi dei modi propri delle bestie, in quanto indispensabili ai fini del preservamento del potere.
Una considerazione: è possibile ravvisare dei punti di contatto tra la leadership machiavellica, di stampo rinascimentale, ed il mondo globalizzato di oggi?
Sebbene nella società contemporanea sia difficile risolvere siffatta questione, non si esclude che diversi comandanti politici, tra i quali Mussolini, Hitler e Stalin, abbiano attinto a loro modo al prototipo machiavellico.
Improntati ad una politica tendenzialmente despotica, questi leader hanno dimostrato un certo interesse nazionale accostabile ma non sovrapponibile al modello puro del Machiavelli.
Benito Mussolini, nel suo Preludio al Machiavelli, definisce il Principe un vademecum per l’uomo di governo, per l’uomo di Stato[76]. In un certo senso, questo saggio è utile al Duce per dare una giustificazione alla propria futura politica, consegnando al popolo un autorevole precedente storico di governo autoritario, lo stesso che fonderà, quanto ai principi, il suo fascismo dittatoriale. Il Principe, dice Mussolini, non avrebbe che una conclusione: tutti gli uomini formano una massa passiva che va guidata e governata senza compassione. La sua disquisizione contiene un’aspra critica alla democrazia, orpello inscenato per far credere al popolo di avere un ruolo attivo nell’adozione di decisioni politiche, ma in realtà mero artefice delle scelte di minima importanza. L’idea di buona politica di Mussolini consiste in ciò, che bisogna scoprire l’inganno compiuto dai governi ed istituire un regime che si presenti apertamente come autoritario. Di guisa che il popolo, consapevole della propria inutilità, si veda riconosciuto il suo ruolo naturalmente sottomesso. Da qui la risoluzione finale di Mussolini, che richiama un passo del Principe: «tutti i profeti armati vinsero e i disarmati andarono in rovina»[77]. Solo la violenza può fare la differenza: è l’unico strumento per conquistare, esercitare e conservare il potere, perché a chi non crede più nello Stato, si può far credere non col consenso, ma con la forza[78].
Anche Hitler pare aver subito l’influenza del Machiavelli. Nei Colloqui con Hitler, Hermann Rauschning, prima collaboratore e poi oppositore del führer, scrive che Hitler si è definito come «il più grande allievo del Machiavelli»: a tal punto adoratore del trattato rinascimentale da ritenerlo l’opera purificatrice delle false credenze e dei pregiudizi politici, in virtù della quale è possibile imporre il proprio potere superando qualsiasi ostacolo di carattere morale.[79]
Quanto a Stalin, c’è chi ha visto in lui un attento seguace della dottrina machiavellica: prove ne sarebbero la grande purga del 1936 e le accuse, mossegli dal procuratore generale Kamenev, di aver applicato le leggi del Fiorentino e di aver adottato certi comportamenti esenti da qualsiasi tentennamento morale[80]. Altri, invece, nel panorama generale della mitologia rivoluzionaria di ascendenza marxista, hanno colto nel totalitarismo sovietico, da Lenin a Stalin, una scarsa presenza del pensatore rinascimentale, ad eccezione delle lacunose testimonianze critiche, specie della corrente trockista, che mettevano a raffronto la contemporanea società russa con il Principe machiavellico[81].
Se c’è qualcuno che, sulla scorta marxista, fece tesoro della lezione di Machiavelli quello fu Gramsci, benché sotto l’influenza leninista e giacobina[82]. Il principe machiavelliano, secondo il filosofo sardo, era il fulcro di un complesso progetto rivoluzionario in cui giocavano un ruolo fondamentale gli intellettuali. Compito di essi avrebbe dovuto essere il coinvolgimento delle masse nella vita politica attraverso un’educazione intellettuale e morale[83].
Educazione che, a detta di Gramsci, si prospettava come manifestazione di una «volontà collettiva […] universale e totale»[84], che donasse allo Stato «il suo contenuto etico»[85], diffondendo un «conformismo di massa» e dando vita ad «un uomo collettivo», «un nuovo tipo di umanità»[86]. In questo modo il moderno Principe assumeva connotati divini, in nome della «laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume»[87]. In definitiva, il Principe di Machiavelli è stato elevato da Gramsci a modello per il partito comunista, il quale avrebbe dovuto rendersene interprete da un’angolazione popolare per marchiare la storia nazionale con una radicale trasformazione etico-culturale.
Ad oggi, la complessità del mondo globalizzato rende non facilmente e direttamente tangibile il temperamento machiavellico di un esponente politico. L’evolversi della tecnologia, rendendo la comunicazione più veloce e compiuta, ha instillato varie tecniche di governo nella medesima dimensione spaziale, nella quale vengono a coesistere molteplici leadership politiche storicamente differenti.
Gli effetti della seconda guerra mondiale ed i conseguenti fenomeni del postcolonialismo e della cortina di ferro hanno convogliato sulla scena globale la tradizionale logica capitalista occidentale ed altri tipi di potere appena congegnati, perciò privi di esperienza di governo. Com’è noto, ciò ha condotto l’economia mondiale verso la sproporzione, col risultato del crollo del sistema sovietico. Intanto, a causa del vivace processo di globalizzazione, la leadership politica è diventata sempre più oggetto di discussione internazionale. In particolare, l’andamento espansivo dell’Unione Europea ha dato adito ad una controversia poi sfociata in nostalgici sentimenti nazionalistici da parte di Stati come la Francia, il Portogallo, la Spagna, la Gran Bretagna ecc., nel cui ambito si sono registrate vere e proprie volontà di azione anti-UE[88]. Del machiavellico, in effetti, si intravede nell’amore per la patria[89] di cui i leader politici si fanno portatori: attraverso la manipolazione, gli animi degli elettori conservatori vengono riempiti di sentimenti primitivi che ripudiano “l’altro”, con l’obiettivo di superare l’incapacità di «cacciar via gli stranieri e di fondare la libertà e l'indipendenza della patria»[90].
6. Conclusioni
Il logos, nella conquista e nella conservazione del potere politico, rivela tutto il proprio vigore nelle comuni interazioni umane.
Dall’indagine sul profilo ideologico dei discorsi sulla verità emerge quanto fertile sia il campo del linguaggio, tanto da attirare a sé i desideri delle persone di dominare l’una sull’altra: un gioco di ruolo continuo ove non si instaura mai un vero e proprio “equilibrio” tra le parti, una “parità di armi” tra gli interlocutori. C’è sempre un soggetto più forte che primeggia con la sua volontà di potere.
La forza manipolatrice della parola, quando applicata nella retorica politico-governativa, tiene il cittadino medio all’oscuro della reale conoscenza dei fatti. Il risultato è la rappresentazione, mediante un discorso, di una congerie di informazioni che nascondono o camuffano la verità politica.
Se da un lato il linguaggio è codice formale di principi, dall’altro (ed è qui la sua peculiarità) è libertà nei vincoli: è sì rispetto delle regole di un codice, ma è anche abilità di infrangerle, talvolta alterandone la naturale funzione (quella comunicativa).
Partendo dal modello generale di governo politico del “benessere della comunità”, fondato sul principio machiavellico di leadership individuale ai fini della conservazione del potere, l’oratore manipola la vita dei singoli e dei gruppi sociali inculcando una determinata ideologia ed imponendo un certo modo di parlare per condizionare, indirettamente, il modo di pensare.
Ciò conduce alla teoria della relatività linguistica, o ipotesi di Sapir-Whorf, secondo la quale individui diversi pensano e si comportano in maniera differente a seconda delle lingue specifiche che parlano. Applicando tale teoria alla tendenza manipolativa del linguaggio, la dissimulazione, se non addirittura l’eliminazione di alcuni termini linguistici (come s’è visto a proposito della Neolingua orwelliana), provoca l’aberrante conseguenza di eradicare i relativi significati concettuali. Tutto ciò al fine ultimo di raggiungere il pieno controllo sulle condotte sociali e, quindi, l’esercizio e preservamento del potere.
L’assenza di una “parità delle armi” nelle relazioni discorsive è strettamente collegata allo squilibrio di potere presente nella vita politica comunitaria. Tanto che si può dire esistente una vera e propria capacità degli esseri umani di imporre il proprio discorso sulla verità, creando nuove accezioni linguistiche e dando vita a particolari narrazioni ideologiche, talvolta suscettibili di essere assimilate ai miti barthesiani.
[1] Cfr. Prologo, Inno al Verbo (v. 1) in La Bibbia. Nuovissima versione dai testi originali, Milano 2010, p. 1132. «In principio», cioè prima di tutte le cose; «Verbo», in greco Logos, significa «parola». Il Verbo è detto eterno, Persona distinta da Dio Padre, fonte di vita. La divinità e l’umanità di Gesù Cristo sono proclamate chiaramente nelle parole: «Il Verbo si fece carne» (v. 14), in cui si afferma l’unione della natura divina con l’umana nell’unica Persona divina del Verbo.
[2] N. GARDIMER, Scrivere ed essere. Lezioni di poetica, traduzione a cura di M. L. CANTARELLI, Milano 1996, p. 143.
[3] F.W. GOETHE, Faust, I, vv. 1224-1236, traduzione a cura di F. FORTINI, Milano 1994, pp. 94-95. Nelle note, sempre a cura del Fortini, si legge: «Lutero ha tradotto Wort, parola, verbum. Ma al termine latino e tedesco manca un elemento essenziale del logos, e cioè la sua concettualità. Faust passa quindi a Sinn, inteso come intelletto e pensiero. Ma anche questo non può soddisfarlo, perché viene a mancare la spinta creatrice che pur è nell’originale greco: e allora propone Kraft, che è forza ed energia. Ancora una volta Faust-Goethe avverte che Kraft sarebbe il principio creatore ma solo dalla parte del soggetto; e troppo esclusivamente potenziale. La conclusione è die Tat, l’azione, la prassi. Si ha qui uno dei termini che riassumono quello che si è convenuto chiamare il Faustismo; quel complesso atteggiamento che unisce attivismo e volontarismo e che nel secolo XIX, dall’impeto creativo della borghesia in ascesa, trapassa all’irrazionalismo estetizzante di quella avviata all’imperialismo».
[4] Cfr. Enciclopedia Treccani, voce “logica”, su www.treccani.it.
[5] Sul significato di logos nell’uso grammaticale, cfr. Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, a cura di L. COENEN – E. BEYREUTHER – H. BIETENHARD, Bologna 1980, voce “logos”, pp. 1170-1175.
[6] Cfr. ARISTOTELE, Politica, traduzione a cura di R. LAURENTI, Roma-Bari 1972, 1253a 7-18: «È chiaro quindi per quale ragione l’uomo è un essere socievole molto più di ogni ape e di ogni capo d’armento. Perché la natura, come diciamo, non fa niente senza scopo e l’uomo, solo tra gli animali, ha la parola: la voce indica quel che è doloroso e gioioso e pertanto l’hanno anche gli altri animali (e, in effetti, fin qui giunge la loro natura, di avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso, e di indicarselo a vicenda), ma la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo stato».
[7] Già nella dialettica antica il logos veniva considerato un’arma di distruzione. Cfr. G. COLLI, Filosofia dell’espressione, Milano 1969, p. 185: «La parola costitutiva del logos dev’essere vivente, pronunciata, modulata, scagliata contro le parole degli altri uomini. Così sorge la dialettica […]. Lo scalpello dell’agonismo è lo strumento della politura razionale».
[8] È necessario precisare che dalla produzione principale di Marx (ex multis, Sacra Famiglia (1845), Miseria della Filosofia (1847), Ideologia Tedesca (1845)) si evince che il termine “ideologia” coincide con l’insieme delle concezioni culturali, politiche, religiose ecc., con cui una classe sociale giustifica i propri interessi. Tuttavia, egli non si esime da una interpretazione letterale della parola tedesca “ideenkleid”, che significa appunto «vestito di idee». Così, cfr. L. BONI, Enciclopedia Garzanti di filosofia e epistemologia, logica formale, linguistica, psicologia, psicoanalisi, pedagogia, antropologia culturale, teologia, religioni, sociologia, voce “ideologia”, Milano 1981. Cfr. altresì Enciclopedia Treccani, voce “ideologia”, www.treccani.it: «l’ideologia, lungi dal costituire scienza, ha la funzione di esprimere e giustificare interessi particolari, per lo più delle classi proprietarie ed egemoni sotto l’apparenza di perseguire l’interesse generale o di aderire a un preteso corso naturale».
[9] M. FOUCAULT, Microfisica del potere. Interventi politici, a cura di P. PASQUINO – A. FONTANA, Torino 1977.
[10] A tal riguardo è interessante l’osservazione di Domenico Losurdo, secondo il quale Nietzsche, da «filosofo del potere», in Foucault si trasforma surrettiziamente in «critico del potere»: «Rileggendo disinvoltamente Nietzsche come critico del potere e della logica di potere e di dominio implicita nella “verità” scientifica, il filosofo francese e gli interpreti postmoderni in genere credono di demarcarsi nettamente rispetto alle ideologie che hanno presieduto alle catastrofi del Novecento. Senonché Baeumler che celebra in Nietzsche “il culmine del nominalismo”, apprezza il rigore con cui egli decostruisce i concetti generali su cui fondano l’illuminismo e le idee dell’89 da un lato e la scienza dall’altro. Che ci si inginocchi “dinanzi al sacro” ovvero “dinanzi alla ragione” – commenta Baeumler –, l’atteggiamento “razional-illuministico” non è meno carico di imposizione e di violenza dell’atteggiamento «sacerdotale». In entrambi i casi un “assoluto” esige le sue vittime”». Cfr. D. LOSURDO, Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio critico, Torino 2002, pp. 1069-1071.
[11] M. FOUCAULT, Microfisica del potere, cit., in «Intervista a Michel Foucault», p. 158.
[12] M. FOUCAULT, Microfisica del potere, cit., p. 184.
[13] Cfr. G. FORNERO, S. TASSINARI, La filosofia del Novecento, Vol. 2, Torino 2014, pp. 1147-1148: «In realtà, insiste Foucault, nella dimensione microfisica del quotidiano non sono possibili grandi partizioni fra dominatori e dominati, poiché ogni individuo o gruppo risulta, simultaneamente, l’uno e l’altro (per esempio, l’operaio subisce il potere in fabbrica, ma lo esercita a propria volta nella famiglia o nell’ambito del sindacato e del partito). Ma se il potere è ovunque e abita in ognuno (non solo nei “capitalisti”), i punti di resistenza a esso risiedono dappertutto (e non solo nel proletariato o negli emarginati) in quanto si identifica con ciò che Foucault denomina l’elemento “plebeo” presente in ogni individuo o gruppo».
[14] M. FOUCAULT, La volontà di sapere. Storia della sessualità, Milano 2001, p. 82.
[15] M. FOUCAULT, L’ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola, traduzione a cura di A. FONTANA, Torino 1972, p. 10: «il discorso […] non è semplicemente ciò che manifesta (o nasconde) il desiderio; […] il discorso non è semplicemente ciò che traduce le lotte o i sistemi di dominazione, ma ciò per cui, attraverso cui, si lotta, il potere di cui si cerca di impadronirsi».
Sulla funzione conativa/persuasiva tipica del discorso dell’oratore, nel senso del perseguimento di un’adesione di pensiero e/o di una risposta d’azione, cfr. R. JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, a cura di L. HEILMANN e traduzione di L. GRASSI, Milano 1966, p. 187: «L’orientamento verso il destinatario, cioè la funzione conativa, trova la sua espressione grammaticale più pura nel vocativo o nell’imperativo, che, dal punto di vista sintattico, morfologico e spesso anche fonematico, si staccano dalle altre categorie nominali e verbali. Le frasi imperative presentano una differenza fondamentale rispetto alle frasi dichiarative; queste possono, quelle non possono subire una verifica di verità».
[16] Accanto alla funzione emotiva del linguaggio, si colloca quella di stampo poetico che, secondo Jakobson, è incentrata sulla forma del linguaggio, vale a dire sulle modalità di organizzazione interna degli enunciati, così conferendo al parlante una certa autonomia durante la sua azione comunicativa. Viene a svilupparsi, tramite la funzione poetica (o estetica) della parola, una vera e propria creatività linguistica, contraltare della rigidità del codice formale di comunicazione (sopra richiamato). L’Autore porta l’esempio dei moderni spot pubblicitari, che l’imprenditore intriderà di carattere poetico nella misura in cui gli sia conveniente per attingere i propri scopi commerciali: cfr. R. JAKOBSON, Saggi di linguistica generale, cit., p. 190.
Sempre sul concetto di creatività linguistica, Noam Chomsky propugna la teoria della grammatica generativa, in particolare soffermandosi sull’”aspetto creativo dell’uso del linguaggio”. Egli parla, da un lato, di una “creatività che crea le regole” (rule-changing creativity), la quale si manifesta in deviazioni individuali che, se formano un insieme, sono in grado di trasformare appunto il sistema delle regole; da un altro lato, discorre di “creatività governata da regole (rule-governed creativity), per merito della quale viene a prodursi un flusso continuo di nuove frasi attraverso le regole ricorsive della grammatica. Per una disamina approfondita sul punto, cfr. N. CHOMSKY, Aspetti della teoria della sintassi, in Saggi linguistici. 2. La grammatica generativa trasformazionale, a cura di A. DE PALMA, Torino 1970, pp. 39-258.
[17] J. J. ROUSSEAU, Saggio sull’origine delle lingue, a cura di P. BORA, Napoli 1984, p. 43: «Appena un uomo fu riconosciuto da un altro come un essere che sente, che pensa, e che è simile a lui, il desiderio o il bisogno di comunicargli i suoi sentimenti e i suoi pensieri lo indussero a cercarne i mezzi». Nel ricondurre l’origine del linguaggio all’impulso emotivo, Rousseau si colloca in contrasto con la maggioranza dei suoi contemporanei, i quali al contrario giustificavano tale origine con la necessità di soddisfare i propri bisogni fisici. Cfr. Ivi, p. 52: «I frutti non si sottraggono alle nostre mani, possiamo nutrircene senza parlare; possiamo inseguire in silenzio la preda di cui vogliamo cibarci: ma per suscitare emozioni in un giovane cuore, per respinger un aggressore ingiusto, la natura detta accenti, grida, lamenti».
[18] Cfr. ARISTOTELE, Retorica, a cura di M. DORATI, Milano, 1996, 1356a 15-16, 1377b 31, 1378a 1.
[19] Sulla connessione tra retorica aristotelica e vita politica della comunità, adottare decisioni politiche e provvedimenti giudiziari, dare consigli, persuadere gli altri in merito ad argomenti politici e giuridici: queste sono tutte attività politiche essenziali. In tal senso, cfr. E. GARVER, Aristotle’s Rhetoric: An Art of Character, University of Chicago Press 1994, p. 7.
[20] Ibidem.
[21] Ivi, pp. 7-8.
[22] I. KANT, Critica del giudizio, traduzione a cura di A. GARGIULO, Roma-Bari 1979, pp. 189-190.
[23] ARISTOTELE, Retorica, cit., 1377b 21.
[24] L. CARROLL, Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie. Attraverso lo specchio, a cura di M. D’AMICO – P. CITATI, Milano 1978, p. 203.
[25] Per una lettura in chiave giuridica del dialogo tra Alice e Humpty Dumpty, si rinvia ad un suggestivo saggio di G. D’AMICO, L’insostituibile leggerezza della fattispecie, in Giustizia Civile, n. 1/2019, pp. 37-38: « Il dialogo […] esprime abbastanza bene la contrapposizione tra l’idea (se si vuole “ingenua”) che «le parole abbiano un loro proprio significato e non si possa costringerle ad indicare cose diverse» (dove l’ingenuità sta nell’essere Alice convinta «di non metterci nulla del suo, ma di trarre in luce i significati che stavano sotto i segni, pronti e finiti, in attesa»), e un “nominalismo radicale” che sfocia in una teoria del significato in ultima analisi autoritaria. […] Al dogmatismo della “verità manifesta”, l’interlocutore della nostra protagonista contrappone un’altra forma di dogmatismo, quella appunto di chi ha il potere di stabilire in ultima istanza il significato delle parole. (...) Per Humpty Dumpty, dunque, non esiste un significato proprio delle parole che l’interprete dovrebbe scoprire e davanti al quale dovrebbe inchinarsi. La gerarchia che ad Alice appare evidente tra regola e interpretazione o tra autore e lettore si capovolge, sancendo la supremazia dell’interpretazione sul testo e dell’intentio lectoris sull’intentio auctoris». Si tratta, allora, di non cadere nell’ “ingenuo realismo concettuale” di Alice, ma nemmeno di accettare il “relativismo” (scettico) e il “soggettivismo” di Humpty Dumpty ».
[26] W. KAUFMANN, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton University Press 1974, p. 128.
[27] G. DELEUZE, Nietzsche e la filosofia, traduzione a cura di F. POLIDORI, Torino 2002, p. 18.
[28] Ibidem.
[29] Ivi, p. 19.
[30] Per il mito come “metalinguaggio” che opera attraverso codici ed assolve la funzione ideologica della naturalizzazione, cfr. R. BARTHES, Miti d’oggi, traduzione a cura di L. LONZI, Torino, 2016, p. 197: «Nel mito ci sono due sistemi semiologici, di cui l’uno è sfasato in rapporto all’altro: un sistema linguistico, la lingua (o i modi di rappresentazione assimilabili), che chiamerò linguaggio oggetto, perché è il linguaggio a cui il mito si aggancia per costruire il proprio sistema; e il mito stesso, che chiamerò metalinguaggio, perché è una seconda lingua nella quale si parla della prima».
[31] U. ECO, Il nome della rosa, Milano 1981, p. 105.
[32] Ivi, p. 356.
[33] Ivi, p. 360.
[34] Ivi, p. 361.
[35] Come si sa, nella Poetica Aristotele tratta della tragedia e dell’epica. L’esistenza di un secondo libro sulla commedia è stata avanzata per la prima volta dal patriarca nestoriano Timoteo I. Tuttavia, tale tesi è respinta dalla maggioranza della critica odierna: cfr. C. D’ANCONA, The Libraries of the Neoplatonists, Brill 2007, p. 314.
[36] Sulla inconciliabilità della filosofia aristotelica con la concezione cristiana dell’uomo, del mondo e di Dio, e sulla relativa riforma tomista in chiave teologica, cfr. ASSALONE DI SAN VITTORE (+ 1203), Sermo 4: P. L. 211,37: «Non regnat spiritus Christi ubi dominatur Aristotelis». Cfr., altresì, M. GRABMANN, I divieti ecclesiastici di Aristotele sotto Innocenzo III e Gregorio IX, in Miscellanea historiae pontificiae, V: I papi del duecento e l’aristotelismo, fasc. 1, Roma 1941.
[37] Simbolico a tal riguardo è il finale de Il nome della rosa, nella scena in cui, mentre tutto crolla e tutti fuggono dal convento, la confusione innesca l’ultima parola di Guglielmo da Baskerville, la stessa parola che «era presso Dio (e Dio era il Verbo)» e che lotta contro la diffusione del caos, in una ricerca senza fine dell’ordine: « “Intendete dire,” chiesi, “che non ci sarebbe più sapere possibile e comunicabile, se mancasse il criterio stesso della verità, oppure che non potreste più comunicare quello che sapete perché gli altri non ve lo consentirebbero?” In quel momento una parte dei tetti del dormitorio crollò con immenso fragore soffiando verso l'alto una nuvola di scintille. Una parte delle pecore e delle capre, che erravano per la corte, ci passarono accanto lanciando atroci belati. Dei servi passarono in frotta accanto a noi, gridando, e quasi ci calpestarono. “C'è troppa confusione qui,” disse Guglielmo. “Non in commotione, non in commotione Dominus.”» (Ivi, p. 375). Queste parole enfatizzano la necessità dei cittadini medi di una comunità di basare il proprio orientamento su una determinata concezione, nella specie quella cristiana, in modo da indirizzare le proprie scelte nell’una o nell’altra direzione.
[38] Cfr. H.G. SCHOGT, Translation, in T.A. SEBEOK – P. BOUISSAC, Encyclopedic Dictionary of Semiotics, in 3 Vols., Berlin-New York-Amsterdam, Mouton de Gruyter, p. 1108.
[39] E. SAPIR, Cultura, linguaggio e personalità, traduzione a cura di G. PERCOCO, Torino 1972, pp. 57-58.
[40] G. ORWELL, 1984, traduzione a cura di G. BALDINI, Milano 1973, pp. 331-332, 339.
[41] Ivi, p. 336.
[42] È d’obbligo il rinvio alle disquisizioni di Klemperer sulla lingua nazista, il cui tratto principale è rappresentato dalla povertà: cfr. V. KLEMPERER, LTI. La lingua del Terzo Reich. Taccuino di un filologo, traduzione a cura di P. BUSCAGLIONE, Firenze 1998, pp. 37-42. Si rimanda, altresì, a George Steiner, per una lettura sulla lingua delle ideologie “competitive”, ad esempio del nazismo, nel senso che queste non danno vita a vocaboli nuovi, ma tendono a saccheggiare e privare la lingua della comunità dei propri connotati tradizionali: cfr. G. STEINER, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e della traduzione, traduzione a cura di R. BIANCHI, C. BÉGUIN, Milano 2004, p. 60.
[43] Sulla riforma linguistica di Atatürk del 1928, definita dall’autorevole studioso Ettore Rossi come fenomeno di «purificazione del lessico», in quanto finalizzata a liberare la lingua turca dalle influenze straniere ed a far emergere il «turco puro», nell’ottica di un processo di omologazione nazionale, cfr. E. ROSSI, La riforma linguistica in Turchia, Roma 1935; E. ROSSI, Un decennio di riforma linguistica in Turchia (1932-1942), Roma 1942.
[44] U. ECO, Il nome della rosa, cit., pp. 361-362: «Guglielmo: “Ma cosa ti ha spaventato in questo discorso sul riso? Non elimini il riso eliminando questo libro.” […] Jorge: “Il riso distoglie, per alcuni istanti, il villano dalla paura. Ma la legge si impone attraverso la paura, il cui nome vero è timor di Dio. E da questo libro potrebbe partire la scintilla luciferina che appiccherebbe al mondo intero un nuovo incendio: e il riso si disegnerebbe come l'arte nuova, ignota persino a Prometeo, per annullare la paura. Al villano che ride, in quel momento, non importa di morire: ma poi, cessata la sua licenza, la liturgia gli impone di nuovo, secondo il disegno divino, la paura della morte. E da questo libro potrebbe nascere la nuova e distruttiva aspirazione a distruggere la morte attraverso l'affrancamento dalla paura. E cosa saremmo, noi creature peccatrici, senza la paura, forse il più provvido, e affettuoso dei doni divini?”».
[45] M. FOUCAULT, L’archeologia del sapere, traduzione a cura di G. BOGLIOLO, Milano, prima edizione digitale 2013 da quinta edizione BUR Saggi luglio 2009, pp. 42-43.
[46] M. FOUCAULT, L’ordine del discorso, cit., pp. 9-10.
[47] Ivi, p. 10.
[48] Sugli effetti deleteri della diminuzione del numero di parole, per mano della Neolingua orwelliana, cfr. G. CAROFIGLIO, La manomissione delle parole, Milano 2019, p. 26: «Nella Neolingua il numero delle parole viene ridotto al minimo e ogni parola residua viene limitata a un unico possibile significato. L’abbondanza di parole e la molteplicità di significati sono strumenti del pensiero, ne accrescono la potenza e la capacità critica: parallelamente, la ricchezza del pensiero richiede, e anzi esige, ricchezza di linguaggio. Il progressivo contrarsi del linguaggio, in Oceania e in altri luoghi meno immaginari, ha per effetto prima l’impoverimento, poi una vera e propria inibizione del pensiero».
[49] Sul rapporto tra democrazia e linguaggio come scambio di idee, cfr. G. ZAGREBELSKY, Imparare democrazia, Torino 2007, p. 35: «Il numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell’uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia; più sono le parole che si conoscono, più ricca è la discussione politica e, con essa, la vita democratica».
[50] M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, a cura di M. GALZIGNA, Milano 2012.
[51] F. DOSTOEVSKIJ, Diario di uno scrittore, traduzione a cura di E. LO GATTO, Firenze 1963. La citazione di Dostoevskij è rinvenibile in M. FOUCAULT, Prefazione alla prima edizione, in Storia della follia nell’età classica, cit.
[52] M. FOUCAULT, Prefazione, op. cit.
[53] M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, traduzione a cura di F. FERRUCCI, Milano 1976, reperibile sul sito www.archeologiafilosofica.it, p. 122: «è "sempre possibile e necessaria una presa di possesso razionale sulla follia, nella misura in cui essa è non-ragione”».
[54] M. FOUCAULT Prefazione, op. cit.
[55] M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, traduzione a cura di F. FERRUCCI, cit., p. 25: «Nell'opera di Shakespeare troviamo le follie che s'imparentano con la morte e con l'assassinio; in quella di Cervantes le forme che si assoggettano alla presunzione e a tutti i compiacimenti dell'immaginazione». Ivi, p. 26: «In Cervantes o in Shakespeare la follia occupa sempre una posizione estrema, nel senso che essa è senza rimedio. Niente la riporta mai alla verità e alla ragione».
[56] Per una disamina sulla pazzia di Amleto, cfr. K. S. CODDON, “Suche Strange Desygns”: Madness, Subjectivity, and Treason in Hamlet and Elizabethian Culture, in Essays on Dramatic Traditions: Challenges and Transmissions, vol. 20, Northwestern University Press 1989, pp. 51-75.
[57] Cfr. M. FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, cit., p. 26: «La follia, nei suoi vani ragionamenti, non è vanità; il vuoto che la riempie è “un male molto al di là della mia scienza”, come dice il medico a proposito di Lady Macbeth; è già la pienezza della morte: una follia che non ha bisogno di medico, ma della sola misericordia divina». Per un approfondimento sulla follia di Lady Macbeth, si rinvia a A. LOMBARDO, Lettura del Macbeth, Milano 2010.
[58] Cfr. A. CASTRO, Il Pensiero Di Cervantes, Napoli 1972, p. 136: «Cervantes è un razionalista che ci presenta i limiti delle possibilità di strutturazione razionale».
[59] C. MONTALEONE, Don Chisciotte o la logica della follia, Torino 2005, pp. 92-99.
[60] H. C. ANDERSEN, I vestiti nuovi dell’imperatore, in Fiabe, a cura di S. MASARACCHIO, 2010, reperibile sul sito www.liber-rebil.it, pp. 117-118.
[61] Sulla riqualificazione freudiana della follia come manifestazione dell’anima e come parte inconscia della mente umana, cfr. D. BERTHOLD-BOND, Hegel, Nietzsche, and Freud on Madness and Unconscious, in The Journal of Speculative Philosophy, vol. 5, no. 3 (1991), Penn State University Press, pp. 193-213.
[62] J. S. NYE Jr, Leadership e potere, Bari 2008.
[63] S. FABBRINI, Addomesticare il Principe, Venezia 2011.
[64] Per la definizione di leadership e leader, cfr. W. OUTHWAITE, T. BOTTOMORE, E. GELLNER, R. NISBET, A. TOURAINE (a cura di), Dizionario delle scienze sociali, voce “Leadership”, Milano 1997, pp. 371-372; F. DEMARCHI e A. ELLENA (a cura di), Dizionario di sociologia, voce “Leader”, Milano 1976, pp. 692-695.
[65] Cfr. nota 15.
[66] M. G. CIANI, Ritorno a Odisseo, in Omero, Odissea, Venezia 2008, p. VII: «e molto astuto (polymetis), molto abile (polymechanos), molto paziente (polytlas) è, per definizione, Odisseo».
[67] Ivi, p. VIII.
[68] Ivi, p. X: il diverso contesto richiede «un uso molto più costante e articolato dell'intelligenza attiva contro insidie inaspettate, avversari sconosciuti, forze occulte. La scena muta di continuo e impone travestimenti, maschere, menzogne. Sopravvivere è un'arte che richiede abilità e prudenza, dissimulazione e audacia».
[69] Ibidem.
[70] L’etimologia del nome greco Odyssèus è sconosciuta. Antichi autori lo hanno collegato al verbo greco odyssomai, “odiare”, “essere odiato”, quindi vorrebbe significare “Colui che è odiato” (da Poseidone, dai Proci). Il nome Odisseo possiede tuttavia parziali e interessanti identità di suono con altri concetti: odos, ou che significa “viaggio” e oud-eis che significa “nessuno” (da cui il nome con cui l'eroe greco si presenta a Polifemo per raggirarlo). Così, cfr. H.G. LIDDEL – R. SCOTT, A Greek-English Lexicon, Oxford University Press 1996, voce «ὀδύσσομαι».
[71] Sull’ambiguità e polisemanticità delle parole in quanto tali, cfr. E. GALAVOTTI, Il Trattato di Wittgenstein, 2013, reperibile sul sito www.homolaicus.com, p. 34.
[72] N. ABBAGNANO, Dizionario di filosofia, Torino 1998, p. 547: «i Greci intesero una qualsiasi violazione della norma della misura, cioè dei limiti che l'uomo deve incontrare nei suoi rapporti con gli altri uomini, con la divinità e con l'ordine delle cose». Il punto fondamentale della concezione ontologica-cosmologica greca consiste in ciò, che la misura è valore che riassume in uno ordine ed armonia tra i diversi enti. Trasgredire l’ordine cosmico significa oltraggiare (da qui la hybris di Ulisse) la struttura stessa dell’universo, legittimando così la giusta punizione divina (R. MARCHESINI, Post human. Verso nuovi modelli di esistenza, Torino 2002, p. 199).
[73] N. MACHIAVELLI, Il Principe, edizione PDF a cura di G. D’ORRICO, rinvenibile sul sito www.beneinst.it, 2010, p. 15.
[74] Ivi, p. 51.
[75] Ibidem.
[76] B. MUSSOLINI, Preludio al Machiavelli, in Gerarchia a. III, n. 4, aprile 1924, pp. 205-209. Così recita l’incipit del saggio: «Accadde che un giorno mi fu annunciato da Imola – dalle legioni nere di Imola – il dono di una spada con inciso il motto di Machiavelli “Cum parole non si mantengono li Stati”».
[77] N. MACHIAVELLI, Il Principe, cit., p. 16.
[78] Per i sostenitori della concezione mussoliniana di politica, si rimanda ad un interessante saggio: A. J. LIEN, Machiavelli’s Prince and Mussolini’s Fascism, in Social Science, IV, 1929, pp. 435-441. Per una prospettiva generale, cfr. X. TABET, Machiavel et le fascisme italien, in Machiavelli ne XIX e XX secolo, a cura di P. CARTA – X. TABET, Padova 2007, pp. 214-215. In senso contrario, si rimanda al fatidico discorso pronunciato, a Montecitorio, dal leader socialista riformista Giacomo Matteotti: «Mussolini stesso con grande energia ha creato una forma di governo sorretta dalla spada, dalla violenza e dal pervertimento politico. Il vigore delle sue vedute, la potenza dei suoi sradicati seguaci hanno soppresso la democrazia in Italia» (G. MATTEOTTI, Machiavelli, Mussolini and Fascism, in English Life, 1924, p. 87 ss., citato in M. CANALI, Il delitto Matteotti, Bologna 1997).
[79] H. RAUSCHNING, Colloqui con Hitler. Le confidenze esoteriche del Führer e i suoi piani per la conquista del mondo, traduzione a cura di A. M. BAIOCCO, Roma 1996, pp. 242-243: «Hitler… si definisce il più grande allievo del Machiavelli… Hitler mi disse di aver letto il Principe del fiorentino più di una volta. Egli riteneva quel libro semplicemente indispensabile per ogni politico. Per qualche tempo lo aveva tenuto sul comodino, perché la sua lettura esercitava su di lui un effetto purificatore e liberatorio, sgombrandogli la mente di immagini sentimentali e false. Solo in quei momenti si accorgeva di quanto dipendessimo dai pregiudizi. E soltanto leggendolo si era reso conto che dovevamo ancora imparare cosa fosse la vera politica».
[80] G. SCIARA, Il “Principe” sul comodino del dittatore: Mussolini, Hitler e Stalin leggevano Machiavelli, 12 novembre 2013, rinvenibile sul sito www.ilriccioelavolpe.wordpress.com.
[81] G. M. BARBUTO, Machiavelli e i totalitarismi, Napoli 2005, pp. 11-12.
[82] Ivi, p. 12.
[83] Ivi, p. 88.
[84] A. GRAMSCI, Quaderno 13. Noterelle sulla politica del Machiavelli, a cura di C. DONZELLI, Torino 1981, p. 6.
[85] Ivi, pp. 114-115.
[86] Ivi, pp. 44, 148-149; cfr., altresì, A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, edizione critica a cura di V. GERRATANA, Torino 1997, p. 1387 e p. 1947.
[87] A. GRAMSCI, Quaderno 13, cit., p. 9: «Il moderno Principe, sviluppandosi, sconvolge tutto il sistema di rapporti intellettuali e morali in quanto il suo svilupparsi significa appunto che ogni atto viene concepito come utile o dannoso, come virtuoso o scellerato, solo in quanto ha come punto di riferimento il moderno Principe stesso e serve a incrementare il suo potere o a contrastarlo. Il Principe prende il posto, nelle coscienze, della divinità o dell’imperativo categorico, diventa la base di un laicismo moderno e di una completa laicizzazione di tutta la vita e di tutti i rapporti di costume».
[88] Sulla Francia, cfr. A. BARGAS, Européennes : la dynamique inédite de l’Euroscepticisme, 29 aprile 2009, www.eurosduvillage.eu; sul Portogallo, cfr. P. C. MAGALHÃES, What Ever Happened to Portuguese Euroscepticism? The Depolicitization of Europe and its Consequences, 2 novembre 2002, www.pedro-magalhaes.org; sulla Spagna, cfr. Quelli contro l’Europa, 10 settembre 2016, www.ilpost.it, e Brussels says an independent Catalonia would need to leave EU, 16 settembre 2013, www.euractiv.com; sulla Gran Bretagna, prima della Brexit, cfr. Brexit, una settimana dopo, 1 luglio 2016, www.ilpost.it, e Brexit: Corbyn, noi decisivi per restare, 10 maggio 2016, www.ansa.it.
[89] Sul patriottismo di Machiavelli, cfr. F. DE SANCTIS, Storia della letteratura italiana, Milano 1991, pp. 480 ss.
[90] Ivi, p. 493.

