Pubbl. Mar, 30 Set 2025
Le imposte locali sulle piattaforme estrattive nel mare territoriale, una questione, forse, ancora dubbia
Lorenzo Motta
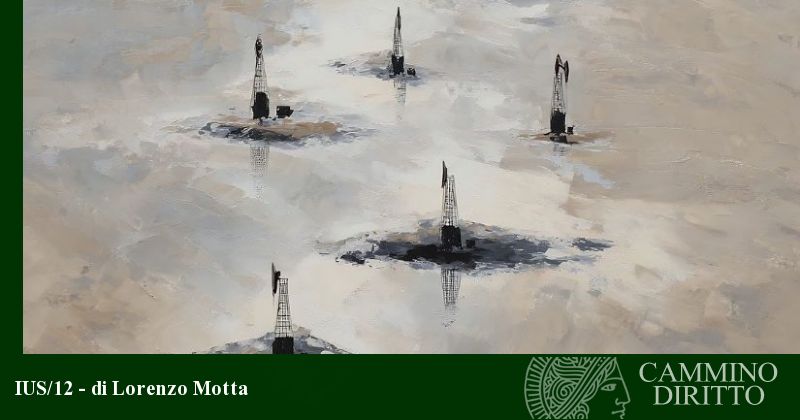
Il contributo esamina nei suoi elementi essenziali, mediante un approccio critico, la questione dell’applicabilità delle imposte locali sulle piattaforme estrattive site nel mare territoriale, analizzando la posizione assunta dalla giurisprudenza, di merito e legittimità, dal Legislatore e dall’Amministrazione centrale.
Sommario: 1. Premessa; 2. Excursus storico del caso; 3. Analisi delle problematiche e delle possibili soluzioni; 3.1 Concetto di bene immobile; 3.2 Regime di accatastabilità; 3.3 La territorialità; 4. Considerazioni finali
1. Premessa
Sono passati diversi anni da quando, nel 2005[1], la Suprema Corte di Cassazione si è trovata, per la prima volta, a dover risolvere la tanto problematica questione delle piattaforme estrattive situate all’interno del c.d. mare territoriale e della loro suscettibilità ad essere destinatarie delle imposte locali, nello specifico dell’ICI e dell’IMU. Eppure, ancora oggi, anche a seguito di successivi interventi della stessa Suprema Corte[2] e a seguito anche dell’introduzione, avvenuta mediante l’art. 38 del d.l. 124 del 2019, dell’imposta municipale sulle piattaforme marine (a partire da ora IMPi), permangono alcuni operatori del diritto che continuano a sostenere la tesi della non applicabilità di tali imposte sulle piattaforme.
Il presente elaborato nasce con l’intenzione di mettere in luce, previo un breve excursus storico del caso, ed analizzare i diversi elementi dai quali è possibile desumere l’applicabilità dell’imposta e, al contempo, di analizzare gli elementi che contraddistinguono la tesi negativa al fine di rilevarne le criticità ai quali vanno incontro.
2. Excursus storico del caso
Come già anticipato nell’introduzione, un primo e necessario passaggio deve sostanziarsi in un approfondimento storico, volto a mettere in luce gli aspetti principali e le cause che hanno portato allo sviluppo di questa particolare vicenda giuridica.
L’annosa questione nasce a seguito un avviso di accertamento ICI, esattamente il n. 19497 del 22 dicembre 1999, relativo gli anni dal 1993 al 1998, emesso dal comune abruzzese di Pineto avverso l’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) e avente ad oggetto alcune piattaforme estrattive site nel mare territoriale antistante il comune. Tale azione spinse l’ente ad impugnare l’avviso, dando così vita ad un contenzioso, avviato in data 15 maggio 2000, fondato sulla tesi della «carenza di potere impositivo da parte del Comune e la mancanza di presupposti oggettivi dell’applicazione dell’ICI» [3].
La posizione di ENI venne, in un primo momento, accolta dalla giurisprudenza di merito[4] ma, con molta sorpresa, venne respinta dalla giurisprudenza di legittimità attraverso la sentenza n. 13794 del 27 giugno 2005 con cui la Suprema corte di Cassazione confermò la posizione del comune affermando: «sull’intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell’Ente regione e degli Enti locali. Non è configurabile, quindi, che su una porzione «del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato» non convivano i poteri delle autorità regionali e locali … non può che esserci coincidenza fra sovranità dello Stato e concorrente esercizio dei poteri degli Enti regionali e locali». Insomma, una soluzione di forte rilievo poiché giunse ad affermare che il mare territoriale rientrava nel territorio comunale, con la conseguenza gli stessi potessero esercitare sul mare gli stessi poteri che esercitavano già sulla terraferma.
Ma la Suprema Corte non si limitò solo a questo aspetto, bensì rafforzò ulteriormente la sua posizione rilevando ed avvertendo che l’accoglimento della tesi negativa avrebbe, come conseguenza necessaria, comportato lo sviluppo di vere e proprie “zone franche”[5]. Conseguenza, come sottolineato dalla stessa Corte, del tutto inconcepibile tenuto conto che la loro eventuale costituzione ove sussiste un potere dello Stato ma non anche quello dei Comuni e delle Regioni è del tutto illogica.
Veniva, pertanto, a partire dal 2005, superata la prima eccezione[6] mossa e ciò spinse diversi Comuni costieri a seguire l’esempio del Comune abruzzese, procedendo a notificare avvisi di accertamento relativi il pagamento dell’ICI (poi dell’IMU) che hanno portato alla costituzione di ulteriori contenziosi dinanzi le commissioni tributarie, molte delle quali si sono adeguate alla posizione assunta dalla Corte di cassazione[7]. Tuttavia, la problematica non si concluse, poiché rimasero diversi dubbi circa gli altri aspetti della questione, ovvero della accatastabilità delle piattaforme, della riconducibilità delle piattaforme alla nozione di unità immobiliare e della corretta individuazione della base imponibile.
Ed è proprio su questi aspetti che l’originario contenzioso tra ENI e il Comune di Pineto non si concluse, anzi, continuò. Infatti, a seguito del rinvio adoperato dalla Cassazione, la CTR dell’Abruzzo, con la sentenza del 14 dicembre del 2009, n. 44, aveva rigettato l’appello del Comune muovendo dal difetto del requisito oggettivo di assoggettabilità a ICI dovuto alla collocazione nel mare delle piattaforme e alla loro non accatastabilità. Ciò rese necessario un nuovo intervento della Corte di Cassazione che, con la sentenza del 24 febbraio 2016, n. 3618, giunse ad una nuova conclusione (ovviamente, confermando quanto già affermato precedentemente) rilevando come l’iscrizione catastale non dovesse considerarsi una condicio sine qua non[8] ai fini dell’applicabilità ICI «essendo soggetti ad ICI tutti gli immobili, ancorché non accatastati». Precisando, tuttavia, che tali piattaforme fossero accatastabili e dovessero essere accatastate, sulla base di quanto stabilito dal R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 1 e 4, il quale afferma che fabbricati da accatastare siano anche “gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”, e, inoltre, che esse rientrerebbero nella categoria catastale D/7 in quanto immobili destinati allo svolgimento di un’attività industriale, la cui base imponibile, in assenza di iscrizione al catasto (le piattaforme non risultano iscritte), è valutata sulla base delle scritture contabili ex art. 5, co. 3, D. Lgs. n.504/1992.
Tuttavia, i diversi interventi della Cassazione non sono stati in grado di dipanare i vari dubbi, infatti, poco tempo dopo, precisamente in data 10 marzo 2016, il governo si è ritrovato a dover dare una risposta alla interrogazione parlamentare a risposta immediata n. 5-08070, attraverso la quale si richiedevano chiarimenti circa l’applicabilità ICI/IMU sulle piattaforme estrattive alla luce della nuova sentenza della Cassazione. Il governo, in risposta, affermava che i principi rilevati dalla corte potevano essere seguiti o meno dai comuni «in ragione della loro autonomia impositiva e della valutazione di un eventuale danno al bilancio dell’ente che potrebbe essere oggetto di accertamento sotto il profilo della responsabilità contabile» [9], ma, allo stesso tempo, ribadiva come fondamentale fosse il ruolo dell’Amministrazione finanziaria, alla quale spettava il compito di approfondire la tematica in modo da poter proporre una possibile soluzione normativa allo stesso Governo.
La situazione non si placa, infatti il Dipartimento delle finanze del MEF veniva sollecitato dall’Associazione Assomineraria a fornire chiarimenti circa l’applicabilità dell’IMU sulle piattaforme. Il dipartimento rispondeva con la Risoluzione del 1° giugno 2016, n.3/DF, con la quale, da un lato ammetteva che le piattaforme fossero immobili a destinazione speciale, pertanto rientranti in linea teorica nella categoria catastale D; dall’altro, però, rilevava la non applicabilità dell’IMU, ponendosi perciò in posizione opposta ai giudici di vertice, poiché tali piattaforme, non essendo collegate alla terraferma, non potevano in concreto essere iscritte nel “Catasto edilizio urbano”[10]. Pertanto, il Dipartimento delle Finanze concludeva ritenendo necessario un intervento normativo per consentire il censimento delle costruzioni site nel mare territoriale e l’ampliamento del presupposto ICI/IMU.
Successivamente, nello stesso anno, interviene nuovamente la Corte di Cassazione, la quale è chiamata a pronunciarsi nuovamente sul tema con la sentenza del 30 settembre 2016, n. 19510, nella quale ribadisce la posizione già sostenuta in precedenza con la sentenza 3618/2016, precisando che per tali piattaforme, poiché rientranti nella categoria catastale D/7, il calcolo dell’imposta prende come base il valore di bilancio «data la mancanza di iscrizione in catasto», nonostante i chiarimenti forniti dalle interrogazioni parlamentari e dal MEF, poiché atti, questi, per come stabilito in questa nuova sentenza, «rientranti nella funzione di studio, opinione e dibattito applicativo della normativa, ovvero di indirizzo amministrativo; e dunque, di per sé inidonei ad incidere sulla disciplina primaria di riferimento e regolamentazione del tributo».
Con l’arrivo della Legge di bilancio del 2018[11], che inseriva tra i fabbricati soggetti ad IMU i manufatti destinati alla rigassificazione del gas naturale situati nel mare territoriale, limitatamente alle parti destinate ad uso abitativo e di servizi civili, si era pensato, in un primo momento, al superamento della questione, ma non fu così[12] e i dubbi rimasero fino all’introduzione, ad opera del D.L. n. 124/2019, art. 38, di una nuova imposta, l’IMPi (Imposta municipale sulle piattaforme marine), nata con l’obiettivo di porre fine a questa problematica. Tuttavia, se da un lato si può benissimo affermare come, a partire dal 2020, tale problematica risulta essere definitivamente superata, permangono ancora problemi relativi ai periodi d’imposta precedenti l’entrata in vigore della suddetta imposta.
3. Analisi delle problematiche e delle possibili soluzioni
Come sottolineato in prima battuta nella premessa, è apparso necessario effettuare un’analisi diacronica per cercare di capire nel migliore dei modi la questione, permettendo così di procedere ad un’adeguata analisi degli aspetti essenziali che la compongono. Inoltre, per favorire una migliore analisi, si ritiene utile suddividere la questione nelle tre problematiche rilevate: il concetto di bene immobile; il regime di accatastabilità; la questione della territorialità.
3.1 Concetto di bene immobile
La prima problematica da affrontare riguarda il concetto di bene immobile, data la tesi, sostenuta da alcuni operatori giuridici, secondo cui le piattaforme estrattive non costituirebbero beni immobili ex art. 812 c.c.[13]. Tuttavia, prima di andare affondo con quest’analisi risulta necessaria una preliminare, seppur breve, analisi di tipo tecnico-giuridica relativa le piattaforme estrattive, quali strutture concepite per l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse marine, nello specifico idrocarburi come petrolio e metano, che operano offshore[14], termine questo adoperato nel settore minerario. Settore in cui proprio l’Italia è risultata essere stata pioniera grazie ad ENI (Ente Nazionale Idrocarburi) che, nel 1959, costruì il primo pozzo offshore d’Europa denominato “Gela Mare 21” e situato dinanzi le coste siciliane.
Col tempo tali impianti sono stati oggetto di una forte evoluzione, soprattutto con riguardo gli aspetti strutturali e di sicurezza, che ha comportato lo svilupparsi di diverse caratteristiche, rendendo, così, necessario procedere ad una classificazione.
Tale classificazione[15] ha portato all’individuazione delle: “unità sommergibili”, costituite da uno scafo galleggiante sul quale è posta la struttura principale; “unità semisommergibili”, costituite da uno scafo semi galleggiante e una struttura posta in fondo al mare costituita da piloni che permettono alla struttura sovrastante il galleggiamento; “unità autoelevabili”, composte da una piattaforma al di sotto della quale vengono collocati dei piloni che vengono fissati sul fondo del mare, garantendo alla struttura di rimanere in piedi.
Da ciò è possibile comprendere l’eterogeneità delle piattaforme estrattive, cosa che ha reso più complesso il lavoro del giurista nell’individuare la corretta natura giuridica. Per cercare, tuttavia, di ridurre tali complicazioni, la dottrina sembra aver accolto una sostanziale bipartizione di tali strutture[16], andando a distinguere le “piattaforme fisse”, poggiate sul fondo marino mediante meccanismi di palificazione[17] (principalmente in acciaio o cemento), e le “piattaforme mobili”, mantenute in posizione mediante sistemi di ancore.
Partendo da questa premessa, si può tranquillamente comprendere le difficoltà che si riscontrano nel procedere ad individuare la corretta natura giuridica delle piattaforme estrattive, ovvero se trattasi di beni immobili o beni mobili. E tale problematica risulta essere ulteriormente accentuata dalla insussistenza di una disciplina normativa volta regolarla. Tutto ciò ha permesso alle società di gestione delle piattaforme di sfruttare questa situazione di incertezza interpretativa per dar vita ad un argomento posto a difesa della loro tesi, ovvero che tali strutture non possono essere suscettibili di applicazione delle imposte locali poiché non costituirebbero beni immobili ex art. 812 c.c.
Non sono pochi, infatti, i casi in cui tali società in sede contenziosa hanno rilevato tale argomento, affermando come le piattaforme possiedano «solo alcune caratteristiche di immobile ancorato alla terraferma» [18], oppure che esse siano «installate sul suolo marino con modalità non definitive o che siano difficilmente destinabili ad altro fine» [19] o, ancora, che esse costituiscano solo degli impianti, non beni immobili, i quali sono esclusi dal novero dei beni suscettibili di stima catastale, sulla base dell’art. 1, co. 21, L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), e di assoggettamento alle imposte locali[20].
Tuttavia, a parere di chi scrive, sussistono una serie di elementi dai quali è possibile sostenere una tesi contraria. Innanzitutto, partendo dal dato giurisprudenziale, è di fondamentale importanza quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016[21], ulteriormente confermato dalla stessa in altre sentenze[22], ovvero che «le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI e sono classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura». Corte che ha basato la sua tesi anche sulla base della CTU svoltasi durante il giudizio di merito antecedente quello di legittimità la quale ha concluso rilevando tali piattaforme fossero “impianti stabilmente infissi al fondale marino”. Quanto appena affermato, trova pieno riscontro con il dato normativo contenuto nell’art. 812, comma 1, del Codice Civile, il quale afferma che «sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo», ovvero il loro essere “incorporate al suolo”, anche se a scopo transitorio, quale concetto ritenuto da parte della dottrina come un’unione del bene che forma un “corpo unico con il suolo”[23]. Tale elemento, infatti, lo si rileva nella maggior parte dei casi relativi le piattaforme (il riferimento è alle piattaforme “fisse”) le quali, come ribadito nella “Relazione sullo stato di sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi”[24], anno 2018, del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, rientrano pienamente nella locuzione “altre costruzioni … unite al suolo a scopo transitorio”.
Tuttavia, non mancano problematiche relative tale tesi, infatti, come già detto poc’anzi e data l’eterogeneità delle piattaforme, non tutte le tipologie potrebbero rientrare. Il riferimento è rivolto verso le piattaforme c.d. “mobili”, presenti in minore quantità rispetto l’altra categoria, risultanti connesse al fondale marino tramite dei sistemi di ancore, non corrispondente con il meccanismo di incorporazione tramite sistema di palificazione. Tutto ciò comporterebbe il non poter far ricondurre tali tipologie in quanto affermato dall’art. 812, comma 1, cc. Non bisogna, però, ignorare il comma 2 dello stesso articolo, ovvero «sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione». Tale enunciato, infatti, può costituire una deroga prevista per le costruzioni galleggianti[25], caratterizzate da un “minor grado di materiale unione”[26] con il suolo, ma compensato dalla sussistenza di una condizione importante, l’essere assicurati in modo permanente alla riva o all’alveo per il loro utilizzo. Proprio sulla base di questa condizione, a parere di chi scrive, è possibile far rientrare anche le piattaforme mobili nell’alveo dei beni immobili, dato che esse, anche se non incorporate in maniera piena al suolo, comunque risultano assicurate saldamente al fondale marino per garantirne l’utilizzo durante l’intera durata.
Potrebbe, tuttavia, destare qualche dubbio il riferimento operato dal comma 2 alla sola riva e all’alveo, come se si volesse pensare che bene immobile è il galleggiante situato solo in queste zone. Ma, per chi scrive, quanto stabilito dal suddetto comma non dovrebbe intendersi tassativo, bensì quale risultato del periodo storico nel quale è stato varato il codice civile dove ancora non si parlava di piattaforme situate in mare aperto e a profondità elevate.
Nel prosieguo del discorso, appare opportuno rilevare una recente tesi, adoperata da alcune società, che ritiene sussistente una similitudine tra le pale eoliche e le piattaforme. Nello specifico, sarebbe applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione, ribadito nelle Ordinanze nn. 20726, 20727 e 20728 del 2020, secondo cui le torri che sostengono le turbine costituirebbero impianti, poiché esse svolgerebbero non solo una funzione passiva di sostegno, ma costituirebbero «una componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così energia elettrica». Ed essendo le torri classificabili come impianti, non come immobili, non risulterebbero essere destinatarie di IMU poiché su di esse si applicherebbe la disciplina degli “imbullonati” ex art. 1, comma 21, L. 208/2015. Pertanto, se tale tesi venisse estesa anche alle piattaforme si avrebbe come conseguenza la non applicabilità delle imposte locali. Tuttavia, la tesi suesposta non può essere accettata poiché, come anche affermato in una recente sentenza di merito[27], la funzione svolta dalle torri non la si può riscontrare anche nelle piattaforme dato che «l’unica funzione di tali piattaforme è quella di contenere in loco gli impianti necessari per l’estrazione del gas ed il suo pompaggio a terra. Non esiste, quindi, alcuna funzione attiva all’estrazione del gas, avendo le piattaforme … una mera funzione di sostegno e di involucro dei macchinari».
Infine, occorre citare un ulteriore argomento posto al fine di escludere la natura di bene immobile, ovvero che tali strutture sono incorporate al fondale marino, il quale non costituirebbe suolo. Tuttavia, tale affermazione appare del tutto illogica dato che il suolo è uno degli elementi della crosta terrestre, ovvero lo strato più esterno della terra, la quale risulta essere suddivisa nelle due componenti della “crosta oceanica”, l’area sommersa dagli oceani e dai mari, e della “crosta continentale”, costituita dalla massa dei continenti. Pertanto, poiché il fondale marino corrisponde alla crosta oceanica e questa, come appena detto, corrisponde ad una delle componenti della crosta terrestre, appare pacifico dedurre che il fondale e il suolo siano la stessa cosa[28]. Inoltre, si vuole sottolineare che, se così non fosse, si arriverebbe al punto tale da mettere in dubbio persino la natura stessa di beni immobili delle abitazioni e degli edifici della città di Venezia[29]. Lo stesso varrebbe, come ulteriore esempio, per “Antico stabilimento balneare” di Mondello, comune siciliano situato nella provincia di Palermo, il quale risulta totalmente posizionato mediante identico sistema di palificazione nel suolo marino.
In conclusione, appare opportuno sostenere che le diverse argomentazioni volte a ammettere la natura non immobiliare delle piattaforme appaiano incerte e superabili nei modi su descritti. Perciò, a parere di chi scrive, è da ritenere preferibile la tesi opposta, almeno con riferimento alla tipologia di piattaforma fissa e non con quelle mobili, ove i dubbi risulterebbero essere più marcati.
3.2 Regime di accatastabilità
Come detto prima, il problema della natura immobiliare delle piattaforme non costituisce l’unico aspetto della questione, ma accanto ad esso troviamo anche quello relativo il regime di accatastabilità applicabile. Ma, prima di procedere, occorre effettuare una breve analisi sul concetto di accatastabilità e sul procedimento di accatastamento.
Partiamo sin da subito con l’accatastamento, inteso quale procedimento volto ad inserire un determinato bene immobile, detto accatastabile, ovvero idoneo ad essere oggetto di tale procedimento, situato in un determinato territorio, all’interno di una serie di documenti (atti, registri, disegni e così via) che nel loro complesso vanno a costituire il c.d. “catasto”, strumento nato con lo scopo di descrivere «in termini giuridici ed economici lo stato attuale e la storia di un determinato territorio e degli immobili sovrastanti»[30] ed in grado di fornire un importante supporto all’imposizione fiscale. Il tutto, mediante operazioni di misurazione geometrico-topografiche e di stima, che permettono di censire i vari beni oggetto di tale attività.
Le funzioni catastali, ad oggi, sono attribuite al dipartimento delle politiche fiscali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che le esercita attraverso l’Agenzia del Territorio. Da qui, si può benissimo comprendere che per accatastabilità si intende l’idoneità di un bene ad essere oggetto di accatastamento.
Sulla base di quanto appena detto è possibile comprendere come le problematiche del regime di accatastabilità delle piattaforme si innestino nei due aspetti della natura immobiliare del bene (ma abbiamo già avuto modo di analizzare la problematica nel paragrafo precedente) e dell’idoneità delle stesse ad essere accatastate. In questo paragrafo ci concentreremo sul secondo aspetto. Infatti, non sono pochi i casi in cui si è cercato di affermare che le piattaforme non siano suscettibili di accatastabilità, innanzitutto perché esse sono posizionate sui fondali marini, i quali, come affermato anche della stessa Amministrazione Centrale[31], sono sempre stati esclusi dall’inventariazione delle Amministrazioni competenti nella gestione del catasto. Occorre a tal proposito ricordare come, nella risoluzione n. 3 del 2016 del Dipartimento delle Finanze, mediante la quale l’Amministrazione aveva fornito una risposta ad un’istanza proposta dall’associazione “Assomineraria” con la quale richiedeva un parere relativo l’applicabilità dell’IMU alle piattaforme a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi da 21 a 24, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)[32] e dell’inquadramento della fattispecie effettuato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3618 del 2016, si affermava da un lato che le piattaforme presentassero le caratteristiche di un bene immobile a destinazione speciale e particolare, facendole così rientrare nei gruppi catastali D o E, quali impianti, comportandone la possibile applicabilità del comma 21 della legge di stabilità 2016, che esclude dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; dall’altro, però, sosteneva che sulla base della disciplina catastale le piattaforme non potessero essere inserite negli atti del catasto poiché non era “l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali”, bensì “l’Istituto Idrografico della Marina” l’organo Cartografico dello Stato designato al rilievo sistematico dei mari italiani. Pertanto, si potrebbe facilmente ed erroneamente concludere che «tali cespiti siano beni non accatastabili e dunque non soggetti al tributo locale»[33].
Tuttavia, quanto sostenuto dall’Amministrazione non appare adeguato innanzitutto perché attraverso la lettura in combinato disposto dell’art. 1, il quale afferma che «è disposta in tutto il Regno l’esecuzione a cura dello Stato dell’accertamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al Catasto rustico», e dell’art. 4, che afferma «Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo», del Regio decreto legge del 13 aprile 1939, n. 652, è possibile dedurre che le piattaforme siano suscettibili di accatastamento. Inoltre, non bisogna dimenticare che in molte occasioni, sia la giurisprudenza di merito[34] che quella di legittimità[35] avevano avuto modo più volte di ribadire che le piattaforme fossero suscettibili di accatastamento. Per di più, analizzando anche la normativa di settore, nello specifico la L. n. 3682/1886 (Legge Messedaglia), il Regio decreto n. 1572/1931, il Regio decreto n. 652/1939, definito ulteriormente dal decreto ministeriale n. 28/1998, non si evince alcun impedimento all’accatastamento di un bene posto nel fondale marino, sito nel mare territoriale.
Ciò che appare, quindi, è che gli unici limiti all’accatastabilità derivino dall’Amministrazione Centrale. Tutto questo risulterebbe dalle circolari, risoluzioni e note adottate da questa in diverse occasioni, come la risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016 del Dipartimento delle Finanze, la risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020 del Dipartimento delle Finanze, la circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell’Agenzia del Territorio o la nota del 21 novembre 2018 della Direzione Cartografica e Catasto dell’Agenzia del Territorio[36]. Non bisogna, però, dimenticare un elemento fondamentale, ovvero che tali atti non costituiscono fonti del diritto e pertanto non in grado di porre limiti di natura normativa, poiché si tratta di atti amministrativi. Ancora, è da rilevare che la stessa Amministrazione ha comunque ribadito che il rilevamento delle piattaforme spetta all’Istituto Idrografico della Marina, sulla base delle disposizioni di legge, e ciò non fa altro che confermare l’inesistenza di impossibilità, anche materiali, delle procedure di accatastamento dei beni siti in mare e, a conferma di ciò, basti vedere le mappe nautiche che rilevano la presenza delle strutture situate in mare.
Ulteriore requisito essenziale, sulla base dell’art. 5 del Regio decreto 652/1939, è la capacità di tali strutture a produrre reddito proprio data la loro capacità di svolgere una attività produttiva[37], fondamentale ai fini dell’accatastabilità e della possibilità di essere accatastate non come pertinenze della fabbrica sita sulla terraferma alle quali sono collegate tramite condotte, bensì autonomamente. Attività produttiva che rientra nel procedimento di produzione degli idrocarburi e consistente nell’estrazione e nello stoccaggio dei materiali che verranno poi immessi nelle condotte per il successivo trasferimento presso la centrale a terra. Quindi, come affermato anche in una recente sentenza di merito, riprendendo l’orientamento della Cassazione, la piattaforma estrattiva costituisce «un cespite economico indipendente e distinto rispetto alla centrale di terra, ciascuno dotato di una sua utilitas e, trattandosi di cespite autonomo, va accatastato autonomamente e non quale pertinenza della centrale a terra»[38].
Per concludere, occorre soffermarci sulla questione della categoria catastale di riferimento, individuata tenuto conto dell’attività da queste svolta. Nello specifico, tali manufatti svolgono operazioni identificate come “attività industriali” (ad esempio il trattamento preliminare degli idrocarburi), quindi dovrebbero essere inseriti all’interno della categoria D, ovvero degli immobili a destinazione speciale, e più nello specifico nella categoria D/7[39] essendo «fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di vita industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»[40]. Da escludere, invece, la tesi secondo la quale dovrebbero essere inscritte nella categoria catastale E/3, ovvero costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, comportante l’esenzione dalle imposte locali, poiché ritenute opere di pubblica utilità, senza tener conto, però, che si tratta di strutture private adoperate per fini di natura industriale e commerciale, ovvero attività di estrazione e vendita idrocarburi.
Sulla base di quanto appena rilevato, e tenuto conto dell’inserimento nella categoria D/7, la base imponibile dovrà essere individuata sulla base dell’art. 5 del d. lgs. 504/1992 il quale prevede di base essa corrisponda al valore degli immobili e stabilendo il criterio di calcolo nelle rendite risultanti in catasto valevole per i beni iscritti. Per quanto riguarda, invece, i beni non iscritti e rientranti nella categoria D, proprio come per le piattaforme, al comma 3 prevede un’importa deroga nella parte in cui afferma che «per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333», quindi in base al “valore di bilancio”.
Da tutto questo si può desumere come l’effettiva iscrizione in catasto non costituisce una condicio sine qua non ai fini dell’applicazione delle imposte locali. Ciò che deve sussistere, invece, è la suscettibilità, anche se solo teorica, dei beni ad essere iscritti in catasto.
3.3 La territorialità
Possiamo ora soffermarci sull’ultima problematica, ovvero se i comuni sono titolari di un potere impositivo sul mare territoriale, luogo nel quale sono situate le piattaforme oggetto di questo studio. Ma per far ciò, occorre partire dal concetto di “territorialità” e, più nello specifico, il concetto di “territorialità del tributo”.
Iniziamo sin da subito col dire che il principio di territorialità ha origini storiche, esso infatti è stato associato con la nascita dello Stato moderno, il cui riconoscimento lo si ha con il Trattato di Westfalia del 1648[41], ed è strettamente legato al concetto di “sovranità”, del quale costituisce un’esplicazione. Anzi, la territorialità circoscrive l’ambito territoriale entro il quale la sovranità riconosciuta ad uno Stato può essere esercitata.
Nell’ambito del diritto tributario, non vi sono mai stati dubbi circa l’esistenza di limiti territoriali alla potestà impositiva dello Stato e tali limiti corrispondono ai confini del territorio statale, individuati mediante trattati internazionali e norme consuetudinarie internazionali[42], ma non mancano le fonti interne come le norme costituzionali, ovvero i processi di autolimitazione del legislatore.
Ed è proprio qui che si inserisce la questione dei confini marini, ovvero l’individuazione del “mare territoriale”, quale «striscia di mare adiacente le coste dello Stato” dove esso “esercita gli stessi poteri che esercita sul proprio territorio»[43]. Delimitazione che ha destato non pochi problemi, i quali sono stati risolti mediante la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore nel 1994, che ha introdotto alcuni principi fondamentali, quali: il mare adiacente la costa è soggetto in tutto e per tutto alla sovranità dello Stato; la sovranità si estende allo spazio aereo sovrastante il mare territoriale come pure al relativo fondo marino e al suo sottosuolo; la larghezza del mare territoriale può estendersi fino ad un massimo di 12 miglia marine; il criterio adoperato per la delimitazione della linea di base del mare territoriale è quello delle “linee rette”; la “piattaforma continentale” è individuata quale prolungamento della terra emersa « fino all’orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia», sulla quale lo Stato esercita i suoi diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.
Si può, dunque, affermare, sulla base dei suddetti principi, che lo Stato può esercitare la propria sovranità anche sul mare territoriale e, di conseguenza, applicare le proprie leggi, tra cui anche quelle fiscali.
Se, tuttavia, da un lato è pacifico affermare che lo Stato sia legittimato ad esercitare i propri poteri, tra i quali quello impositivo, sulle acque territoriali; dall’altro non si può dire la medesima cosa, con molta facilità, con riguardo i comuni. Ciò ha dato vita a diversi contenziosi dove questi hanno cercato di affermare il loro potere impositivo sul mare territoriale, contrastati da diversi operatori che vedono l’impossibilità da parte loro di esercitare tali poteri, e la controversia principale riguarda proprio le piattaforme.
A parere di chi scrive, però, non è vero che comuni non possano esercitare i loro poteri anche sul mare territoriale, bensì, essi sono titolari su questo degli stessi poteri che esercitano sulla terraferma e vi sono diversi elementi mediante i quali poter confermare quanto appena detto.
Innanzitutto, fondamentale è la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la Legge Costituzionale n. 3/2001, che dando attuazione alla Legge n. 59/1997 (c.d. Legge Bassanini) e al d. lgs. n. 112/1998[44], il quale riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali delle comunità residenti in un determinato territorio, ha operato un importante riparto di competenze di tipo funzionale tra Stato, Regioni e Comuni, attribuendo allo Stato solo le competenze espressamente previste e agli enti substatali quelle restanti, comportando un vero e proprio decentramento amministrativo. Inoltre, con riferimento alla gestione del demanio, bisogna ricordare che l’art. 105 del d. lgs. 112/1998 ha attribuito tale competenza alle Regioni e, sulla base dell’art. 42 del d. lgs. 96/1998, il quale stabilisce che «sono esercitate dai comuni le funzioni amministrative previste dall’art. 105, comma 2, lettere f) ed l), del decreto legislativo n. 112/1998», anche dai comuni. Pertanto, già sulla base di quanto appena rilevato si potrebbe confermare la sussistenza di poteri da parte dei comuni sul mare territoriale, ma per rafforzare la tesi si può far riferimento ad altri elementi. Tra questi, sicuramente il parere rilasciato dal Ministero dei Trasporti n. 8800 del 2 settembre 2014 al Comune di Jesolo, a seguito della sua richiesta in cui demandava delucidazioni relative l’individuazione dei limiti territoriali del Comune, nel quale si afferma che «è innegabile che l’ente comunale abbia e debba poter esercitare competenze e funzioni amministrative anche sul mare territoriale». O, ancora, è possibile fare riferimento all’ipotesi della dispersione delle ceneri in mare, consentita dall’art. 3 della L. 130 del 30 marzo 2001, la quale può avvenire solo dopo l’autorizzazione dell’amministrazione comunale competente e sulla base di alcune regole (es. la distanza minima dalla riva da rispettare pari a non meno 100 metri).
Ulteriore elemento favorevole a quanto si vuole affermare lo si ritrova in ambito tributario, ovvero il processo volto a dar vita al c.d. “federalismo fiscale”, avviatosi con la legge delega n. 42/2009 e trovando la sua applicazione principale con il d. lgs. n. 23/2011, il quale ha attribuito ai comuni la fiscalità immobiliare mediante l’introduzione dell’IMU, quindi riconoscendo a questi dei poteri di natura fiscale da esercitare all’interno del territorio comunale, tra cui anche il fondale marino sulla base di quanto affermato poco prima. Ciò è poi stato ulteriormente confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a partire già con la sentenza n. 13794/2005, e successivamente riconfermato dalla giurisprudenza di legittimità[45] e dalla giurisprudenza di merito[46], nella quale ha affermato che «sull’intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell’Ente regione e degli Enti locali. Non è configurabile, quindi, che su una porzione del “territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali», poiché, innanzitutto, il territorio nazionale comprende anche il mare territoriale «e non sussistono elementi che possono far pensare che il territorio comunale sia un’entità diversa, dal punto di vista qualitativo, dal territorio nazionale» e, inoltre, perché non si può negare la coincidenza tra sovranità dello Stato e concorrente esercizio dei poteri degli Enti regionali e locali, tenuto conto anche del fatto che l’intero territorio dello Stato, di conseguenza anche il mare territoriale, è suddiviso in Regioni e Comuni, perciò risulterebbe illogico ammettere la sussistenza di zone che non appartengano a questi. Per di più, è da notare che, come già ribadito, se così non fosse ci si troverebbe dinanzi lo sviluppo di vere e proprie “zone franche”, le quali comporterebbero numerosi e indebiti vantaggi fiscali in capo ai proprietari dei beni, con il rischio di porsi in contrasto con i principi dell’ordinamento costituzionale.
In opposizione a quanto appena sostenuto, alcuni riscontrerebbero un elemento negativo nella sentenza della Corte Costituzionale, la n. 21 del 17 aprile del 1968, la quale, proprio con riferimento al mare territoriale e ai permessi per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, ha affermato che «non convince l’asserto che, essendo lo Stato articolato in Regioni, per le materie statuarie la competenza statale si risolve in una competenza regionale. Non ha pregio neanche l’obiezione che i medesimi motivi che giustificano l’estensione delle potestà statali sulla piattaforma continentale impongono di portarvi la competenza regionale […] Quello dell’esistenza di un mare territoriale regionale altro non è se non un problema di esistenza, fra le competenze regionali, di singole materie aventi un oggetto che implica l’utilizzazione di quel mare», ovvero non si può parlare di un mare territoriale regionale e ciò porterebbe all’ulteriore conclusione secondo la quale «se non esiste un “mare territoriale regionale”, è ancora più arduo sostenere sic et simpliciter, come fa la Cassazione, che esista necessariamente un “mare territoriale comunale”»[47]. Tuttavia, quanto appena rilevato risulta alquanto inadeguato per un semplice motivo, la sentenza della Corte Costituzionale del 1968 era stata assunta in un periodo caratterizzato da un sistema normativo differente rispetto quello attuale dove diverse sono state le riforme che hanno spinto verso lo sviluppo di un decentramento delle competenze amministrative e verso lo sviluppo del “federalismo fiscale”. Ciò rende la suddetta sentenza non più adeguata alle nuove esigenze ed evoluzioni[48].
Potrebbe destare qualche problema la corretta individuazione del Comune nel quale risulta situata una determinata piattaforma, ma non è così vista la sussistenza di diverse soluzioni prospettabili. Innanzitutto, si potrebbe ricorrere al metodo di proiezione sul mare di una linea di prosecuzione del confine di terra di un comune, oppure ipotizzare una linea ortogonale rispetto al confine di terra o, ancora, il criterio geometrico della “linea retta”[49] che individuerebbe il comune in quello maggiormente vicino, in termini di distanza, al bene. Tutto ciò, inoltre, risulta maggiormente facilitato dall’odierna tecnologia, come il sistema GPS (sistema di posizionamento globale) che permette di individuare la collocazione geografica di un determinato oggetto, mediante coordinate, con molta precisione, andando così ad eliminare quelle che potevano essere le difficoltà presenti un tempo, soprattutto con riferimento al mare. E ancora, un’importantissima fonte di informazioni è costituita dalle carte nautiche, dalla documentazione e dagli atti concessori delle Capitanerie di porto, nei quali viene indicato il comune nel quale risulta essere situato un determinato bene posto nel mare territoriale[50].
A voler chiudere, si può sicuramente fare riferimento all’introduzione della nuova imposta immobiliare sulle piattaforme estrattive (IMPi) che conferma la sussistenza di un potere di natura impositiva condiviso, poiché imposta a gettito ripartito, dallo Stato e dai comuni sul mare territoriale.
4. Considerazioni finali
Giunti al termine, non rimane altro che rilevare le conclusioni raggiunte mediante questo studio. A parere di chi scrive, si può benissimo confermare come non sussista un’effettiva questione aperta relativa il caso dell’applicazione delle imposte locali sulle piattaforme estrattive site nel mare territoriale e lo stesso potrebbe anche affermarsi sotto un profilo generale del potere impositivo dei comuni. Infatti, i vari argomenti rilevati nel corso della scrittura non fanno altro che confermare la sussistenza di questo potere da parte dei comuni, rendendo così inutili gli sforzi fatti allo scopo di affermare il contrario, contrastati anche dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, che ormai in via maggioritaria da rilievo alla tesi dell’imponibilità.
Infine, fondamentale è stato l’intervento del legislatore tributario che, con l’introduzione dell’IMPi, non solo è andato a chiudere questa situazione di apparente incertezza legislativa, ma ha permesso di consolidare quell’orientamento che vede le piattaforme estrattive come destinatarie del potere impositivo dei comuni e fornendo, così, un argomento fondamentale ed essenziale per tutte le controversie generatesi e che verranno a costituirsi, ovviamente relative i periodi d’imposta antecedenti l’entrata in vigore di questa.
[1] Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13794.
[2] Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 24 febbraio 2016, n. 3618; Cass. civ., Sez. trib., 30 settembre 2016, n. 19509; Cass. civ., Sez. trib., 30 settembre 2016, n. 19510.
[3] Cfr. Cass. civ., Sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13794
[4] Cfr. Comm. Trib. Prov. Teramo, 28 maggio 2001, n. 39 e Comm. Trib. Reg. Abruzzo, 10 marzo 2003, n.7
[5] Cfr. Cass. civ., Sez trib., 27 giugno 2005, n. 13794 nella parte in cui afferma che “se infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati i poteri amministrativi della Regione e del Comune, ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell’ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i Comuni non avrebbero nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie”
[6] L. Lovecchio, Via libera all’imposta sulle piattaforme petrolifere in sostituzione dell’IMU, in Il Fisco, vol. 44, n.3/2020, p. 240.
[7] A titolo di esempio crf. Comm. Trib. Reg. Molise, 24 ottobre 2012, n. 82; Comm. Trib. Prov. Campobasso, 17 gennaio 2013, n.4.
[8] Decisione che si discosta da altra posizione assunta dalla stessa corte, che in diversi casi ha sostenuto come l’iscrivibilità costituisca un elemento essenziale ai fini dell’applicabilità del tributo. Tra le pronunce, si veda: Cass. 10 giugno 2008, n. 15321; Cass. 15 settembre 2008, n. 23596.
[9] Cfr. G. Ielo, La riforma dei tributi locali. La nuova IMU, Milano, IPSOA, 2020, p. 2.
[10] Inoltre, come ribadito dallo stesso Dipartimento delle Finanze, organo competenze al rilievo sistematico dei mari italiani è “l’istituto idrografico della marina”
[11] Legge 27 dicembre 2017, n. 205
[12] Da rilevare che, in sede parlamentare si rilevo l’inapplicabilità di questa nuova disciplina alle piattaforme estrattive, poiché non corrispondenti, da un punto di vista strutturale e funzionale, agli impianti di rigassificazione, destinatari della disciplina. Cfr. Camera Dei Deputati – XVIII Legislatura, VI Commissione Permanente (Finanze), Assoggettamento all’imposta municipale unica delle piattaforme di rigassificazione ubicate in acque territoriali, Interrogazione a risposta immediata n. 5/00481, seduta del 20 settembre 2018, allegato 6.
[13] “Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo.
Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione.
Sono mobili tutti gli altri beni”
[14] Quando si parla di “offshore minerario” si fa riferimento ad una particolare tipologia di “upstream minerario” (termine che indica le diverse attività minerarie). Nello specifico, con “offshore” si intende quelle attività che hanno ad oggetto giacimenti allocati in mare o sulla piattaforma continentale, la cui disciplina giuridica principale si rinviene nella L. 21 luglio 1967, n.613, rubricata “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”
[15] Per un maggior approfondimento, cfr. F. Lazzaro, Il regime giuridico dei mezzi di ricerca e sfruttamento che operano in mare, Piacenza, 1968.
[16] Cfr. G. M. Boi, Le piattaforme marine. Studi per una normativa internazionale uniforme, Genova, 2006, p. 8
[17] Un esempio di piattaforme fisse è costituito da quelle site dinanzi il comune di Crotone, poiché poste mediante pali di ferro e calcestruzzo infissi sul fondale marino. Cfr. Comm. Trib. Prov. di Crotone, n. 205/2022
[18] Cfr. Corte di Giustizia Tributaria di II grado marche, n. 1353/2022
[19] Cfr. Comm. Trib. Prov. di Crotone, n. 205/2022
[20] Cfr. Comm. Trib. Prov. di Crotone, n. 205/2022
[21] Si vuole sottolineare che tale sentenza è stata richiamata più volte in altre sentenza in conferma di quanto sostenuto. Cfr. Cass. civ. 12741/2018; Cass. civ. 1404/2022; Cass. civ. 22300/2022; Cass. civ. 27194/2022; Cass. civ. 2280/2023.
[22] Cfr. Cass. 13794/2005; Cass. 22124/2010; Cass. 19509/2016; Cass. 19510/2016.
[23] A. Torrente, P. Schlesinger, Manuale di diritto privato, XXIII edizione, Milano, Giuffrè, 2017, p. 120.
[24] Relazione prevista del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 145 e dal regolamento di Esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione Europea.
[25] C. M. Bianca, Diritto civile, VI, Milano, Giuffrè, 2017, p.39
[26] L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F. D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile 2, Torino, UTET, 1992, p. 8
[27] Comm. Trib. prov. di Crotone, n. 205/2022
[28] A tal proposito, cfr. R. Baggio, Il principio di territorialità ed i limiti alla potestà tributaria, Giuffrè, Milano, 2009, p. 38, il quale afferma che “Per ciò che concerne il sottosuolo, esso comprende non solo il suolo sottostante la terraferma, ma anche quello sottostante il mare territoriale, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, fino alla profondità cui giunge la sua effettiva utilizzabilità tramite i mezzi tecnici esistenti”.
[29] Comm. Trib. Prov. di Crotone, n. 205/2022
[30] C. Padoa Schioppa, Catasto in “Dizionario di Economia e Finanza online”, sito web: https://www.treccani.it/enciclopedia/catasto_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)/
[31] Cfr.: Risoluzione del 1° giugno 2016, n. 3 del Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, Agenzia del Territorio.
[32] Riferimento al comma 21, il quale prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”
[33] Cfr. M. del Vaglio, Le piattaforme petrolifere sono soggette ad ICI/IMU?, in Corriere Tributario, 2017, n. 2, p. 149.
[34] Cfr.: Comm. Trib. reg. Molise, n. 210/2020; Comm. Trib. reg. Molise, n. 239/2020; Comm. Trib. reg. Emilia Romagna, n. 522/2021; Comm. Trib. reg. Emilia Romagna, n. 523/2021; C.G.T di II grado Calabria, n. 2946/2022; Comm. Trib. prov. di Crotone 205/2022
[35] Cfr.: Cass. 3618/2016; Cass. 19509/2016; Cass. 19510/2016.
[36] Interessante da rileva è che questa in questa nota l’Agenzia del Territorio sostiene che “la mappa del catasto comprende il solo territorio nazionale e non è riportata nell’ordinamento di settore alcuna indicazione riguardante il mare territoriale per l’individuazione del quale risulta competente l’Istituto Idrografico della Marina, che nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, è individuato come uno degli Organi cartografici dello Stato, al pari dell’Amministrazione catastale”
[37] Cfr. Comm. Trib. reg. Molise n. 210/2020
[38] C.G.T. di II grado Calabria, n. 2946/2022
[39] Come anche affermato dall’Amministrazione centrale nella Risoluzione n. 3/DF del 1° giugno 2016.
[40] Confermato da: Cass. 3618/2016; Cass. 19509/2016; Cass. 19510/2016
[41] Si veda R. Baggio, op. cit., per un approfondimento sulle origini.
[42] Tra i diversi possiamo ricordare: il Trattato di Parigi, firmato il 10 febbraio 1947; il Trattato di Osimo, firmato il 10 novembre 1975; il Trattato di San Germano, firmato il 10 settembre 1919.
[43] Cfr. Mare. Diritto internazionale, in Enciclopedia online Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/mare-diritto-internazionale/;
[44] Rubricato “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
[45] Cfr.: Cass. n. 3618/2016; Cass. n. 19509/2016; Cass. n. 19510/2016.
[46] A titolo di esempio si veda: Comm. Trib. Reg. Molise, sent. n. 82/2012; Comm. Trib. Prov. Campobasso, sent. n. 4/2013; Comm. Trib. Reg. Abruzzo, sent. n. 1292/2015; Comm. Trib. Reg. Abruzzo, sent. n. 436/2016; Comm. Trib. Prov. Chieti, sent. n. 70/2018; Comm. Trib. Reg. Molise, sent. n. 86/2020; Comm. Trib. Reg. Molise, sent. n. 210/2020; Comm. Trib. Reg. Molise, sent. n. 239/2020; Comm. Trib. Reg. Abruzzo, sent. n. 264/2022.
[47] Cfr, L. Salvini, Il potere impositivo dei comuni sulle acque territoriali: il caso delle piattaforme petrolifere, in Intrecci tra mare e fisco, V. Uckmar (a cura di), CEDAM, Padova, 2015.
[48] Cfr. Comm. Trib. prov. Crotone, sent. n. 205/2022.
[49] Cfr.: Cass. n. 19510/2016; Comm. Trib. Reg. Molise, sent. n. 86/2020
[50] Ciò viene anche ribadito in alcune sentenze. A titolo di esempio si veda: Comm. Trib. Prov. Chieti, sent. n. 70/2018; Comm. Trib. Reg. Molise, sent. n. 239/2020.

