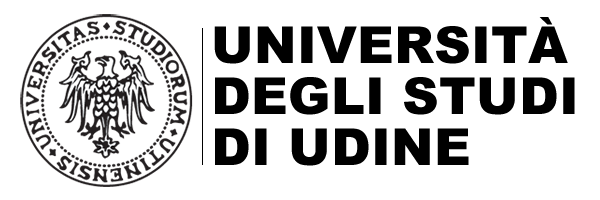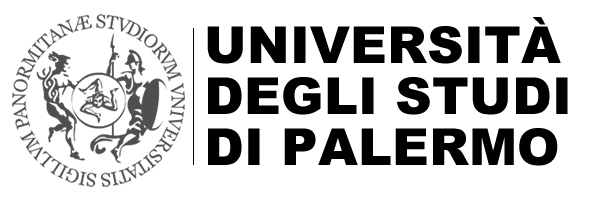Pubbl. Mar, 19 Mar 2024
Commento a ”Formazione e valutazione della prova nel processo: i collaboranti” di Andrea Antonio Dalia
Ilenia Sorrentino

Il ”Progetto Prof. A. A. Dalia” ha lo scopo di rendere omaggio ad un grande Maestro del diritto attraverso brevi commenti, dal carattere divulgativo, relativi ai più svariati temi che interessano il diritto processuale penale. L´obiettivo è quello di restituire attualità al suo pensiero, attraverso l´analisi di relazioni rese in occasione di lezioni, convegni e congressi. Una vera sfida, oltre che una rara occasione di confronto, per chi, ancora tra i banchi delle aule universitarie, sta per affacciarsi al mondo delle professioni legali.
CONVEGNO DELLA CAMERA PENALE DI CAMPOBASSO – ANNO 1996
Formazione e valutazione della prova nel processo: "i collaboranti"
Prof. Andrea Antonio Dalia
Università di Salerno
Ringrazio l'amico Montalto per avermi dato questa opportunità di tornare in una terra, il Molise, alla quale sono molto legato non solo da esperienze, ma anche da sentimenti.
Non posso dire con altrettanta franchezza di dover ringraziarlo per il tema che mi ha assegnato, perché è un tema tremendo. Formazione e valutazione della prova e collaboranti: due concetti antitetici, perché se vi è in un processo la presenza di una collaborazione per ciò stesso le regole sulla formazione e sulla valutazione della prova saltano. Così come è difficile per me collocarmi nell'ambito di questo interessante ed utile convegno, tra l'amico Buccico e l'amico Pecorella, parità tra accusa e difesa, io chiedo scusa a Buccico se non ho potuto ascoltare ieri la sua relazione sulla parità tra accusa e difesa nelle indagini. Tra poco Pecorella parlerà della parità tra accusa e difesa nel processo, ma questi sono sempre concetti che trovano spazio, se ed in quanto il processo non si avvalga della presenza di un collaborante.
Io sono stato tra gli studiosi più entusiasti della riforma del processo penale, mi sono formato culturalmente sotto il vigore del codice abrogato, ho esercitato la funzione giudiziaria con quel modulo e ho contribuito alla riforma del 1988 con una scuola salernitana di cui mi onoro essere il fondatore che ha dato notevoli contributi. E vorrei oggi, a distanza di cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo codice, poter prendere atto che non esiste quell'antitesi che ci preannunzia il tema del convegno, modello e prassi applicativa, perché se si usano questi due termini, modello e prassi per intitolare un convegno, ciò significa che il modello sta da una parte e la prassi dall'altra.
Io avrei voluto oggi potervi dire: abbiamo un nuovo modello di accertamento penale che trova puntuale applicazione nella prassi, perché, signori, se abbiamo impiegato più di trent'anni per riformare il codice di procedura penale non possiamo ad appena quattro, cinque anni di esperienza di questo nuovo modello riflettere già sulle divergenze tra il modello e la sua applicazione.
Ma, quale modello ci siamo dati?
Era un modello che aveva, a mio avviso, un solo obiettivo, quello di valorizzare la funzione dell'avvocato, di restituire all'avvocato il suo ruolo essenziale nella dialettica processuale, perché ne traesse beneficio il giudice.
Il modello previgente era ispirato ad una logica asimmetrica, nel senso che era l'organo inquirente che accertava i fatti e si avvaleva della prova come argomento di dimostrazione della esattezza dell'assunto che aveva ricavato dalle indagini.
Quindi, vi era una realtà processuale raccolta dall'inquirente che poi nella forma della pubblicità del dibattimento diventava prova come argomento dimostrativo. Si disse che la verità non poteva essere prerogativa di un unico soggetto, ma che bisognava accettare il principio della divisione delle conoscenze e si propose un sistema isonomico, ciascuno portatore della sua quota di conoscenza, della sua quantità di esperienza nel processo e si disse valorizziamo, realizziamo la terzietà del giudice non solo come distacco del giudicante dall'inquirente e quindi non solo recuperando la diversità della funzione di giudizio dalla funzione di accusa, ma soprattutto realizzando un giudice terzo perché il giudice può essere primo, secondo o terzo. È primo quando cerca la prova e giudica, allora è unico; secondo quando giudica una prova raccolta da un altro; terzo quando forma il suo convincimento sulla contrapposizione dialettica di due parti.
È un principio elementare. Modello isonomico: divisione della conoscenza e quindi, espressione enfatica, parità di accusa tra accusa e difesa, parità delle armi.
Io credo che nessuno di noi ha mai creduto che ci possa essere una parità di posizione tra accusatore e difensore. Ci ha creduto per un periodo di tempo Marcello Gallo, perché è stato l'unico a proporre, nel corso dei lavori parlamentari, una polizia giudiziaria a disposizione della difesa: parità di armi tra accusa e difesa significa dare al difensore gli stessi strumenti investigativi, acquisitivi assegnati al magistrato del pubblico ministero.
Sorse il problema di conciliare l’attività della polizia giudiziaria a favore dell'indagato con la sua dipendenza funzionale dall’ufficio del pubblico ministero.
Si ripiegò, allora, sull’art. 38 delle disposizioni di attuazione: il difensore può ricercare, individuare, fonti di prova, può conferire con persone informate sui fatti, può avvalersi anche di un consulente o di un investigatore.
Ma, l'investigatore privato, il difensore può parlare con le persone informate sui fatti, in quanto sappia o possa sapere che quella fonte di prova non è stata già individuata dall'ufficio dell'accusa, perché se di quella persona informata dei fatti si interessa il magistrato del pubblico ministero, il difensore corre dei rischi d'inquinamento e quindi in effetti si rinuncia a realizzare questa parità, si rinuncia a dare al difensore un ruolo pregnante nel corso dell'accertamento.
Si ripiegò in sede di emanazione del nuovo codice su una divisione che avrebbe dovuto comunque valorizzare il ruolo difensivo nella fase processuale; si inventò una distinzione che la teoria generale del processo aveva a lungo studiato con riferimento ad altre forme di accertamento ma certo con riguardo al processo penale: la distinzione tra procedimento e processo. L'intero procedimento penale assunse le due dimensioni del procedimento per le indagini preliminari e del processo, intendendo per procedimento per le indagini preliminari una fase di caratterizzazione quasi amministrativa, riservata al magistrato del pubblico ministero per le acquisizioni necessarie e sufficienti per le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, processo come sintomo di giurisdizione. Il magistrato del pubblico ministero deve svolgere, si disse, solo quegli accertamenti indispensabili perché possa applicare la legge penale, perché possa adempiere all'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale, poi si passa dalla fase procedimentale alla fase processuale vera e propria e la prova si formerà nel processo.
La prova si formerà in dibattimento nel rispetto dei principi naturali del giudizio: oralità, immediatezza, concentrazione, pubblicità, scelta significativa ma pericolosa, perché avrebbe comportato dei costi enormi e bisognava sfoltire il carico giudiziario; di qui, un'alternativa e ricordiamoli questi concetti perché dobbiamo partire da un punto fermo. La istituzione di riti alternativi al processo che era, signori, la negazione della riforma.
È vero, il carico giudiziario è enorme, intollerabile, per l'ordine giudiziario, ma qual è la strada?
Nell'alternativa tra una forte e significativa depenalizzazione, con riduzione della rilevanza penale ai fatti effettivamente lesivi di interessi protetti costituzionalmente e condanne senza processo, si è optato per questa seconda soluzione, perché oggi tutto ha rilevanza penale, anche i fatti meno significativi hanno una sanzione.
Oggi si vuole che tutto si risolva nell'ambito del penale, allora non potendo rinunciare alla sanzione come regola di condotta sociale perché la sanzione penale oggi è la regola, l'unica regola di condotta sociale che abbiamo, fateci caso in ogni questione - l'unico settore nel quale non ci si rivolge al giudice penale, almeno per ora, ma al giudice civile è quello delle contrapposizioni sui simboli dei partiti, ma credo che si passerà anche dal giudice civile al giudice penale - tutto si risolve nel penale oggi, e si risolve con i riti alternativi che erano, che sono, la negazione della giurisdizione, perché - riflettiamoci - si accetta una condanna sulla base di accertamenti che non dovrebbero avere alcuna valenza probatoria, perché dovrebbero essere quegli elementi raccolti dal magistrato per determinarsi sull'esercizio dell'azione penale.
Su quegli elementi abbiamo innestato un istituto di pena concordata, un istituto di giudizio abbreviato oltre che di oblazione, abbiamo innestato niente meno che forme di applicazione e di sanzione penale o con un giudizio abbreviato - che è un giudizio simbolico - o addirittura con un non giudizio, cioè noi perveniamo alla definizione del processo penale oggi senza giudizio, per decreto penale di condanna.
Ed è questo il primo contrasto interno alla logica della riforma: applicazione delle regole sulla formazione della prova e sul convincimento del giudice, cioè regole di valutazione della prova solo per i casi in cui si vada a processo dibattimentale e condanna senza processo e, quindi, senza prova, in tutti gli altri casi.
Ma, possiamo dire che almeno nei casi in cui c'è il processo, abbiamo delle regole giurisdizionali per la formazione e la valutazione della prova?
Le avevamo, nel codice ci sono, poi è intervenuto il legislatore in fase di riforma, ecco il legislatore farebbe bene a mio avviso per anni a stare fermo, una parentesi consentitemela, ho ascoltato con interesse la relazione del Dott. Izzo che ha puntualmente posto in evidenza alcuni punti dolenti di questa riforma, ma io non capisco per esempio, come possa un legislatore introdurre una nuova norma per dire che in presenza, che quando prevedibile, si applichi la pena sospesa e che si conceda la sospensione condizionale della pena, non si debba applicare una misura cautelare, chi non conosce il diritto pensa che sia una novità questa, della cui opportunità si può discutere o meno. Ma non è così, perché questo divieto esiste già nella legge, all'art. 273, quando si prevede il giudizio di utilità della misura e si dice, se è prevedibile che venga applicata una causa estintiva del reato.
La sospensione condizionale della pena, lo sanno i nostri legislatori che è una causa estintiva del reato?
Si introduce una norma per ripetere un concetto già espresso da una norma preesistente, ma allora stiamo fermi, fermiamoci, non facciamo più leggi nel penale, non facciamo più leggi, perché non si saprà più quale norma sia in vigore e si legittimerà, come si sta legittimando, il diritto della giurisprudenza, che non è il diritto della legge.
Avevamo un modello, ma prima che intervenisse il legislatore, melius re perpensa, a modificarlo, è sconcertante dover prendere atto di questo.
È intervenuta a distruggere questo modello la Corte Costituzionale, cioè l'organismo che è all'apice del nostro ordinamento come garante della legalità dei comportamenti e delle norme che regolano i comportamenti. Ebbene questa Corte Costituzionale ha distrutto in tre battute il ruolo del difensore nel processo penale, quando ha fatto rivivere una realtà concettuale che era ignota alla dottrina del processo penale, credo, anche alla dottrina del processo in generale, il principio della non dispersione.
Ma dove è questo principio della non dispersione delle fonti di prove?
È tutta la regolamentazione del processo che si ispira al principio della non dispersione: il processo serve proprio ad impedire che si disperdano le fonti di prova; si tratta di stabilire se queste fonti vanno compulsate con garanzie e quindi in un'ottica accusatoria, o vanno compulsate in chiave inquisitoria, non esiste un principio di non dispersione che si contrapponga all'oralità.
Questo intervento della Corte Costituzionale ha demolito una grossa parte di questo sistema, ma come se non bastasse - ed è questa credo la più significativa pronuncia della Corte Costituzionale - ha equiparato due entità, non dico distinguibili, ma antitetiche l'interrogatorio dell'imputato o dell'indagato - più indagato che imputato, perché praticabile nella fase delle indagini come esclusivo strumento di difesa, assistenza del difensore, diritto di tacere, diritto di mentire, diritto di difendersi nella forma scelta dall'interessato - ed esame della parte privata imputato come mezzo di prova da assumere nella fase processuale del procedimento penale. Attraverso un piccolo espediente ermeneutico la Corte Costituzionale ha stabilito che l'imputato il quale si rifiuti di rispondere in sede di esame deve veder passare nel processo le dichiarazioni che ha reso come imputato. È saltato il sistema, con questo piccolo espediente unito all'altro principio di non dispersione e quindi valorizzazione delle indagini preliminari compiute dal magistrato del pubblico ministero, non più soltanto ai fini delle determinazioni delle azioni penali ma, a fini probatori.
Signori, dove è più il processo di stampo accusatorio, dove è più questo sistema isonomico dove ciascuno ha una quota di conoscenza che offre alla valutazione del giudice?
Quale è il ruolo del difensore in processi nei quali si adottano misure cautelari per ottenere confessioni, ammissioni di responsabilità nella fase delle indagini, dando come contropartita la liberazione?
Nel processo si indica come mezzo di prova l'esame della parte privata, ben sapendo che la parte privata l'imputato si rifiuterà per poter fare acquisire le confessioni rese nella fase delle indagini.
Ma, spiegatemi, il difensore che ci sta a fare?
Sapeste che mortificazione ho avuto io come avvocato e hanno avuto i miei colleghi sicuramente in tanti procedimenti e le avrete subite anche voi queste mortificazioni quando ci siamo sentiti non avvocati ma assistenti sociali e l'unica possibilità che avevamo nell'espletamento del mandato era un'assistenza morale ad una persona che aveva capito perché era stato detto chiaramente che solo a condizione di certe ammissioni avrebbe acquistato la libertà e abbiamo dovuto dire che queste ammissioni avrebbero avuto effetti processuali determinanti e questa persona avrà dovuto accettare in quel momento quegli effetti, e il nostro ruolo si è ridotto ad una mera assistenza, ma non certo ad una partecipazione dialettica.
Quale può essere la soluzione?
La soluzione può essere quella di una verifica preventiva della legislazione. Prima ancora di fare altri interventi settoriali, pensiamo ad una riforma della riforma del processo penale e sottoponiamo l'articolato ad un controllo preventivo della Corte Costituzionale e io ho sentito avanzare questa proposta più volte. Non possiamo continuare a produrre norme e applicarle in un clima di incertezza e vederle stravolte quotidianamente da interventi della Corte Costituzionale. Il garante della corrispondenza della legge ordinaria ai principi costituzionali espleti questo controllo in fase preventiva e ci consenta di disporre di uno strumento normativo che non sia suscettibile di improvvise e a volte anche frettolose modificazioni. Forse questa sarà la strada e non quella del decreto legge o del disegno di legge, ce ne occuperemo da qui ad un attimo, c'è un disegno che tende a modificare una regola di giudizio e che riguarda proprio i collaboranti. Dicevo non si concilia il tema della collaborazione con quello della formazione della prova, la presenza del collaborante è una presenza che prescinde da quella del difensore; è un dato di fatto di cui il difensore prende atto, e certo non è il difensore ad indicare come fonte probatoria un collaborante, quindi nel momento formativo della prova credo che non abbia nessuna incidenza la presenza difensiva, ha incidenza il collaborante nel momento della valutazione della prova. Collaborante, termine ambiguo, addirittura alcuni li chiamano collaboratori di giustizia. E noi sappiamo che i collaboratori di giustizia sono i segretari, i cancellieri, gli ufficiali di polizia giudiziaria, insomma distinguiamo un poco questi ruoli, allora li chiamiamo collaboranti, equivoco il termine, li dovremmo chiamare dissociati, almeno la legge li considera dissociati.
Ma, c'è una sottile distinzione tra dissociato e collaborante, perché il dissociato è colui che, facendo parte di un'organizzazione con una struttura parastatale decide di abbandonare questo sistema illegale, ma compiuto e chiuso negandone i valori, un soggetto che ripensa la sua posizione all'interno dell'organizzazione; il collaborante è un altro soggetto che può coincidere o meno con il primo, ma che comunque va altrove perché coinvolge altre persone. Il nostro ordinamento ha cominciato ad apprezzare - ed è bene non dimenticarlo - la figura del collaborante con riferimento ad una particolare forma di criminalità organizzata, quella politica. È alla fine degli anni '70 che nasce il discorso normativo sulla valorizzazione della dissociazione, il primo tentativo, ricordiamolo, fu operato con riferimento al sequestro Moro, perché si temeva da parte dello Stato di diritto una organizzazione antistato che stava raggiungendo lo stesso livello di organizzazione perfetta tipica dello Stato di diritto. È un po' insito del concetto di reato associativo questo nucleo organizzativo antitetico rispetto allo Stato di diritto, ma nell'ambito della criminalità organizzata politica era più impressionante il livello di organizzazione che doveva essere scardinata solo attraverso incentivi che procurassero una crisi ideologica negli appartenenti.
Badate questo è l'avvio della dissociazione, lo Stato di diritto sollecitava una crisi ideologica negli appartenenti alle organizzazioni che si contrapponevano ideologicamente a quello dello Stato.
Si può porre sullo stesso livello l'organizzazione politica con la organizzazione criminale comune?
Possiamo parlare di idealità che motivano la dissociazione dall'appartenente alla camorra, alla mafia, alla 'ndrangheta negli stessi termini in cui abbiamo per il passato parlato di idealità che sollecitava e giustificava la dissociazione del terrorista?
Quando nelle sentenze della Corte di Cassazione leggiamo che la dichiarazione resa dal collaborante o chiamante in correità deve essere spontanea, disinteressata, come possiamo recepire questo concetto del disinteresse da parte del cosiddetto pentito di camorra o di mafia, quale idealità può spingere una persona, ci sono, signori, persone pentite che hanno ammesso di aver consumato centinaia di omicidi.
Credo nella zona territorialmente vicina all'avv. Buccico c’è un pentito che ne ha confessato quattrocentocinquanta, in regime di custodia extra muraria protetta, custodia non custodia, quattrocentocinquanta omicidi e noi lo consideriamo un collaborante dello Stato nella funzione giurisdizionale.
E siamo venuti al tema centrale di questo incontro per quel che mi riguarda, la chiamata in correità.
Sarebbe difficile riassumervi anche soltanto gli indirizzi giurisprudenziali sui criteri di valutazione della chiamata in correità. Il codice di limita a dire che la dichiarazione del chiamante ha bisogno di riscontri che ne confermano l'attendibilità, badate che ne confermano l'attendibilità non che ne confermino l'attendibilità, perché se fosse “ne confermino l'attendibilità”, allora basterebbe trovare negli atti del processo elementi tali da ritenere, da far ritenere attendibile la chiamata in correità, invece l'uso del verbo all'indicativo sta a significare che occorrono riscontri probatori di rilevanza autonoma rispetto alla chiamata in correità.
C’è un disegno di legge - tra i tanti – di modifica dell'art. 192 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede questi riscontri di attendibilità. La modifica è strutturata in questi termini: i riscontri devono essere di natura diversa. Occorre che i riscontri siano di natura diversa.
Perché questa necessità?
Perché la giurisprudenza ha stabilito che in presenza di una chiamata in correità il riscontro può essere offerto da un'altra chiamata in correità, il che significa che due soggetti collaboranti che formulino delle accuse anche non perfettamente coincidenti ma sostanzialmente convergenti determinano l'affermazione di responsabilità di un terzo soggetto. Si è detto che non possiamo affidare ad una regola del genere il giudizio del giudice perché poi ci sarebbe tanto da dire su questo libero convincimento del giudice, ci sarebbe tanto da dire sulla prerogativa che consente al giudice di esprimere il suo convincimento, si potrebbe forse pensare all'introduzione nel processo penale di un sistema di prove legali, perché quando il giudice penale è vincolato a rilevare l'esistenza già prefigurata dalla norma di dati di rilevanza probatoria, non vedo dove possa trovare più spazio il suo libero convincimento.
La prova legale è l'antitesi del libero convincimento, la prova legale trasforma il giudice in un notaio che prende atto di certe risultanze probatorie così come sono state valorizzate in via astratta dal legislatore e la presenza di due chiamate in correità concordanti determina di per sé, indipendentemente dalla valutazione che ne fa il giudice il quale ne prende atto e constata, l'affermazione di responsabilità di un terzo soggetto e qui arriviamo, nella prassi applicativa, al paradosso di indagini che si dispongono per stabilire se due collaboranti nella loro esperienza carceraria sono stati nella stessa cella, se hanno potuto parlare tra di loro, oppure mi è capitato in un processo che si sta ancora svolgendo il caso di collaboranti custoditi in case circondariali diverse, ma che si sono potuti incontrare in occasione di processi che li hanno visti coinvolti insieme, ci sono indagini volte a stabilire attraverso l'esame dei componenti la scorta, se durante l'udienza che li ha visti occasionalmente insieme, questi due signori hanno potuto parlare, questo il criterio della valutazione della prova. Ma ci rendiamo conto, andiamo a chiedere ad un giovane carabiniere di scorta quel giorno in quell'aula giudiziaria se si ricorda di aver visto il collaborante x rivolgere un sorriso al collaborante y o se si sono parlati, se si sono scambiate delle frasi, perché solo in questo modo, cioè se si esclude il contatto si può pervenire alla conclusione dell'attendibilità intrinseca del collaborante, perché poi le categorie si distinguono in giurisprudenza tra attendibilità intrinseca e attendibilità estrinseca, quella estrinseca dovrebbe essere offerta dai cosiddetti riscontri obiettivi, che poi diventano anche essi soggettivi perché ci si riporta alle dichiarazioni del collaborante, e intrinseca se questa persona è disinteressata e rende dichiarazioni spontanee, non ha nessuno scopo persecutorio nei confronti di chi è investito dalle sue dichiarazioni.
Ma, non è qui il discorso, perché il principio del contraddittorio non è necessariamente un principio di contrapposizione dialettica; il principio del contraddittorio può anche esprimersi come sotto forma di principio di non contestazione, ben possono esserci più fonti probatorie convergenti, ad esempio un processo a carico di sei persone imputate della commissione di numerosi delitti di camorra nell'agro nocerino-sarnese conclusosi qualche giorno fa presso la Corte di Assise di Salerno, processo nel quale tutti gli imputati erano rei confessi, questo è un discorso d'ammissione di responsabilità, questo è un discorso di reminiscenza, questo è un discorso di ritorno di accettazione delle regole dello Stato di diritto, questo è un discorso di invocazione di un trattamento equo, giusto, di irrogazione di una pena che abbia, nei limiti in cui può riguardare un soggetto che ha commesso tanti delitti, ancora una funzione rieducativa di reinserimento sociale.
In questo caso il principio del contraddittorio si modula come principio di non contestazione, perché c'è l'ammissione da parte dei responsabili dei fatti che ad essi vengono contestati, ma quello di cui abbiamo timore non è prendere atto che un soggetto che è vissuto contro la legge, che un killer che si è lasciato stipendiare per commettere, per svolgere come unica attività la commissione di delitti, di omicidi, rientri o chieda di rientrare nell'ambito dell'ordinamento giuridico, non è questo tema che ci preoccupa, il tema che ci preoccupa con riferimento ai collaboranti è altro, la dichiarazione del reato, l'accusa del reato, la dichiarazione con cui il collaborante dice di aver appreso notizie sullo stato di una persona da altri, c'è una sentenza della Corte di Cassazione resa da un collegio presieduto da un magistrato che poi non ha più presieduto quella sezione e non so il perché, che coraggiosamente, in un processo per un fatto clamoroso occorso in Sicilia, ha distinto in motivazione tra la chiamata in correità come fonte probatoria e la dichiarazione di accusa come notitia criminis.
La dichiarazione di commissione di un reato sta a indicare che il dichiarante ha appreso che altri hanno commesso un reato: una notizia di reato più o meno qualificata che può rilevare solo ai fini dell'avviamento di un’indagine preliminare, non può avere valore probatorio, non può essere un elemento di accusa, che debba in misura maggiore o minore essere confortato da un riscontro, perché a questo punto, signori, rinunciamo alla giurisdizione e allora non c'è più posto, a mio avviso, non solo per l'avvocato, ma non c'è più posto per il giudice, ma c'è posto per uno Stato di polizia, per un processo di polizia perché se si procede per approssimazioni indiziarie dando valore probatorio ad un sentito dire, "ho sentito, mi è stato detto" e questa dichiarazione non viene verificata, io purtroppo parlo per esperienza professionale, seguo professionalmente persone che sono sottoposte ad indagine pur rivestendo ruoli istituzionali di grosso livello e sono sottoposte ad indagini in virtù esclusivamente di dichiarazioni del reato che hanno già orientato perquisizioni laceranti domiciliari, che hanno determinato dimissioni da incarichi prestigiosi nell'ambito delle istituzioni e si procede solo su dichiarazione del reato, questa è la crisi del processo penale, questa è la crisi non di un ruolo, potremmo noi utilitaristicamente dire come difensori ci sentiamo offesi per essere emarginati, per essere posti nell'angolo, per essere utilizzati a volte solo in funzione di garanti di legalità perché occorre la nostra presenza per dare un'impronta di legalità ad atti giudiziari, no, il discorso non coinvolge soltanto il difensore, il discorso coinvolge il giudice, torniamo al giudice primo, secondo o terzo.
Quale giudice può dirsi titolare di una sovranità giurisdizionale assegnatagli democraticamente dal popolo, dallo Stato?
Se è solo distinto dal magistrato del pubblico ministero, è un giudice secondo e non può ritenersi equidistante dal titolare dell’accusa.
Il giudice per essere tale, per essere espressione della giurisdizione, deve rivendicare la sua terzietà. Non il suo essere secondo, deve rivendicare la sua terzietà, deve il giudice aver bisogno dell'avvocato perché la funzione del difensore è essenziale.
Si è soliti considerare il difensore, dal punto di vista dell’accusa, come un ostacolo da superare, almeno i giovani hanno questa dimensione della difesa un ostacolo da superare, più bravo è il difensore maggiore l'accanimento nel superare le sue osservazioni per far vincere la verità, ma la verità è nella cultura del diritto, nella cultura di ogni società democratica, se è una verità isonomica, mai asimmetrica, perché l'asimmetria è espressione del regime, dell'oppressione dell'autorità, mentre la verità isonomica è la verità democratica, la verità che ciascuno offre alla valutazione di chi deve trarre la decisione, e allora sia il giudice a rivendicare la sua terzietà, sia il giudice a respingere quelle formule che sono limitative della sua sovranità - le chiamate in correità possono essere, debbono essere, non occorre che siano coincidenti purché siano attendibile intrinsecamente, estrinsecamente, no! - sono concetti che limitano la libertà di convincimento del giudice, il libero convincimento come dimostrazione di umanità, di solidarietà umana.
Certo, lo Stato deve affermarsi con la gravità della sanzione, perché è interesse comune della collettività che vinca il principio di diritto.
Non può accettarsi che, per predestinazione, la verità si formi in una sola mente: questa presunzione deve essere lontana dai nostri animi di operatori giudiziari che debbono essere caratterizzati, consentitemi, da un principio semplicissimo di umiltà, sentiamoci tutti umili, sentiamoci tutti investiti di questo carico di giudicare il prossimo e cerchiamo di giudicarlo collegialmente, questo è il principio del contraddittorio, perché solo nel contraddittorio delle parti - perdonatemi se sono andato oltre il tempo - solo dal contraddittorio delle parti come regola del giudizio, scaturisce la sovranità della giurisdizione come decisione del terzo imparziale.
Grazie.
Commento di Ilenia Sorrentino
Studentessa iscritto al V anno del corso di laurea in giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche – Università degli Studi di Salerno
Nel 1996, al Convegno della Camera Penale di Campobasso, si discusse di un tema a due anime: formazione e valutazione della prova e collaboranti, nella più ampia cornice che comprendeva la figura del difensore e la figura del magistrato e come fossero inseriti nel processo penale. Secondo la visione del professore Andrea Antonio Dalia, in un processo la collaborazione fa saltare le regole stesse della formazione e della valutazione della prova, risultando quindi due concetti tra loro antitetici. La discussione di questi temi si inseriva nel titolo generale del Convegno, “Modello e prassi applicativa”, nella misura in cui, alla luce della recente riforma del codice di procedura penale (avvenuta nel 1988) sembrava quasi una sconfitta dover parlare di divergenze tra modello e prassi ad appena 5 anni dall’entrata in vigore della riforma, sottolineando che gli obiettivi del nuovo modello fossero stati del tutto tralasciati.
Infatti, l’obiettivo era quello di restituire alla figura dell’avvocato il suo ruolo nella dialettica processuale (essendo stato evidentemente sacrificato), abbandonando quella logica asimmetrica in cui era l’organo inquirente ad accertare i fatti e ad avvalersi della prova come argomento di dimostrazione dell’esattezza delle indagini. Il nuovo modello aspirava ad una divisione di conoscenze secondo un sistema “isonomico”, secondo cui ciascuna parte del processo potesse essere portatrice della propria quota di conoscenza, andando a valorizzare soprattutto quella terzietà del giudice che ha modo di realizzarsi nella contrapposizione dialettica tra le parti (e non quando ad intervenire è una sola parte).
Tuttavia, la parità tra accusa e difesa, tanto elogiata sulla carta, nei fatti sembrava perdere colpi: è stato evidente con la messa a disposizione della Polizia Giudiziaria alla difesa, la quale, quest’ultima, avrebbe potuto accedere agli stessi strumenti investigativi del PM. Ma chiaramente sorsero problemi tra la PG e l’ufficio del PM, in quanto la prima risultava (e risulta) comunque in rapporti di dipendenza funzionale con la seconda.
Le soluzioni momentanee furono due:
- l’articolo 38 delle disposizioni di attuazione, secondo cui il difensore “può” ricercare, individuare fonti di prova, “può” conferire con persone informate sui fatti, “può” avvalersi anche di un consulente o di un investigatore, «a meno che non sappia che quella fonte di prova sia stata già individuata dall’ufficio dell’accusa»; in tal caso, per prevenire rischi di inquinamento, il difensore rinuncia di fatto a questa parità;
- la distinzione tra procedimento e processo, secondo cui il primo è una fase di caratterizzazione quasi amministrativa, riservata al magistrato del pubblico ministero per le acquisizioni necessarie e sufficienti per le determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale, per poi passare dalla fase procedimentale alla fase processuale vera e propria e la prova si formerà nel processo. La prova si formerà in dibattimento nel rispetto dei principi naturali del giudizio.
I problemi che si presentarono erano legati ai costi enormi del carico giudiziario, e ciò comportò la scelta della strada dei riti alternativi, sebbene non fosse in linea con gli obiettivi della riforma. La scelta maturò dalla consapevolezza che tutto ormai si risolvesse col penale, che tutti i fatti, anche quelli meno significativi, avessero una sanzione.
I riti alternativi venivano visti come la negazione della giurisdizione, perché si accetta una condanna sulla base di accertamenti che non dovrebbero avere alcuna valenza probatoria, perché dovrebbero essere quegli elementi raccolti dal magistrato per determinarsi sull'esercizio dell'azione penale. Su quegli elementi si innestava un istituto di pena concordata, un istituto di giudizio abbreviato, un giudizio simbolico (o addirittura un non giudizio) con cui si perveniva alla definizione del processo penale.
In effetti, in linea di massima, quando si arrivava al processo le regole giurisdizionali per la formazione e la valutazione della prova c’erano nel codice, dunque la copertura codicistica veniva incontro. Poi è intervenuto il legislatore in fase di riforma che non ha fatto altro che creare più dubbi. Inoltre, in un contesto in cui le parti sembravano addivenire a degli accordi saltando il rito ordinario, il ruolo del difensore qual era? L’incertezza al riguardo era tanta, e l’unica proposta sembrava una riforma della riforma che potesse stabilire un po’ di ordine.
A prescindere dalla figura dell’avvocato, esiste la figura del collaborante, un dato di fatto di cui il difensore prende atto. Non è il difensore ad indicare come fonte probatoria un collaborante, quindi nel momento formativo della prova non ha nessuna incidenza la presenza difensiva, ma ha incidenza il collaborante nel momento della valutazione della prova.
Il nostro ordinamento ha cominciato ad apprezzare la figura del collaborante con riferimento ad una particolare forma di criminalità organizzata: quella politica.
È alla fine degli anni '70 che nasce il discorso normativo sulla valorizzazione della dissociazione, e il primo tentativo fu operato con riferimento al sequestro Moro, perché si temeva da parte dello Stato di diritto una organizzazione antistato che stava raggiungendo lo stesso livello di organizzazione perfetta tipica dello Stato di diritto.
Quando nelle sentenze della Corte di Cassazione si legge che la dichiarazione resa dal collaborante o chiamante in correità deve essere spontanea, disinteressata, come si deve recepire questo concetto del disinteresse da parte del cosiddetto pentito di camorra o di mafia, se ci sono persone pentite che hanno ammesso di aver consumato centinaia di omicidi? Il codice si limita a dire che la dichiarazione del chiamante ha bisogno di riscontri che ne confermano l'attendibilità (non che ne “confermino” l'attendibilità, perché se così fosse allora basterebbe trovare negli atti del processo elementi tali da far ritenere attendibile la chiamata in correità, invece l'uso del verbo all'indicativo sta a significare che occorrono riscontri probatori di rilevanza autonoma rispetto alla chiamata in correità).
Il riscontro può essere offerto da un'altra chiamata in correità, il che significa che due soggetti collaboranti che formulino delle accuse anche non perfettamente coincidenti ma sostanzialmente convergenti determinano l'affermazione di responsabilità di un terzo soggetto. Tuttavia questo non deve rappresentare una regola, per il giudice, a cui ispirarsi perché poi ci sarebbe tanto da dire su questo libero convincimento del giudice e quando il giudice penale è vincolato a rilevare l'esistenza, già prefigurata dalla norma, di dati di rilevanza probatoria non trova più spazio il suo libero convincimento.
Il tema che preoccupa con riferimento ai collaboranti è altro: la dichiarazione del reato, l'accusa del reato, la dichiarazione con cui il collaborante dice di aver appreso notizie sullo stato di una persona da altri. In una sentenza della Corte di Cassazione si è distinto tra la chiamata in correità come fonte probatoria e la dichiarazione di accusa come notitia criminis.
La dichiarazione di commissione di un reato sta a indicare che il dichiarante ha appreso che altri hanno commesso un reato: una notizia di reato più o meno qualificata che può rilevare solo ai fini dell'avviamento di un’indagine preliminare non può avere valore probatorio, non può essere un elemento di accusa perché dovrebbe in misura maggiore o minore essere confortato da un riscontro, perché a questo punto si rinuncia alla giurisdizione, e non ci sarebbe più posto non solo per l'avvocato ma anche per il giudice. Si delineerebbe così uno Stato di polizia, un processo di polizia in cui si procede per approssimazioni indiziarie dando valore probatorio ad un sentito dire. Questa è la crisi del processo penale.
Il giudice, per essere tale, per essere espressione della giurisdizione, deve rivendicare la sua terzietà e deve aver bisogno dell'avvocato perché la funzione del difensore è essenziale.
Si è soliti considerare il difensore, dal punto di vista dell’accusa, come un ostacolo da superare, più bravo è il difensore maggiore è l'accanimento nel superare le sue osservazioni per far vincere la verità, ma la verità è nella cultura del diritto, nella cultura di ogni società democratica (se è una verità isonomica). È per la verità che ciascuno offre che il giudice deve rivendicare la sua terzietà, deve respingere quelle formule che sono limitative della sua libertà di convincimento come dimostrazione di umanità, di solidarietà umana.
Certo lo Stato deve affermarsi con la gravità della sanzione, perché è interesse comune della collettività che vinca il principio di diritto, ma non può accettarsi che, per predestinazione, la verità si formi in una sola mente: questa presunzione deve essere lontana dai nostri animi di operatori giudiziari che debbono essere caratterizzati da un principio semplicissimo di umiltà. Solo dal contraddittorio delle parti come regola del giudizio scaturisce la sovranità della giurisdizione come decisione del terzo imparziale.
Alla luce del contributo del Professore Andrea Antonio Dalia alla Camera Penale di Campobasso (1996), si può evincere la durevole attualità dei temi toccati che si innestano nel solco della tradizione giuridica italiana. Il professore non fornisce particolari spunti di riforma ma, con spirito di lungimiranza e con il sentore che le cose potessero degenerare, esorta fortemente a rivedere i ruoli del giudice e del difensore che, nella concretezza dei fatti, stavano per essere sminuiti o tenuti in secondo piano, quando invece la dialettica processuale e la terzietà del giudice sono tra i capisaldi di un giusto processo affinché questo espleti al meglio la sua funzione garantista e che non vada a minare la centralità del difensore e il libero convincimento del giudice, altrimenti il processo potrebbe fare a meno di svolgersi nel contraddittorio delle parti. Paradossalmente, in presenza di determinati presupposti si finirebbe per ritenere che la soluzione sia di semplice configurazione e che non necessiti la valutazione del giudice (quando invece è egli stesso a donare il crisma della decisione adottata).
La strada, ai giorni nostri, è quella di propendere verso processi telematici e verso soluzioni sempre più smart in cui la presenza in aula dibattimentale risulta superflua o addirittura farraginosa a discapito della tanto elogiata celerità e del principio della ragionevole durata del processo. Il futuro sembra essere in mano ad una tecnologia che, asetticamente, tenta di sostituirsi alla persona del magistrato o del difensore in virtù del perseguimento di tutto ciò che risulti smart e fast, o comunque conforme alle esigenze di adeguamento ai parametri sovranazionali (perché spesso gli innesti nel nostro sistema mal funzionano perché si cerca di digerire e fare proprie delle normative sovranazionali che in realtà mal si prestano, in taluni casi, a ben coordinarsi con la nostra tradizione giuridica).
Il professore ben temeva già all’origine che potessero esserci dei cambiamenti in atto nei confronti della figura dell’avvocato e del giudice, seppur tenendo in considerazione presupposti diversi che si sono riversati sulla figura del collaborante di giustizia, idonea a rimarcare il venir meno del libero convincimento del giudice, soprattutto durante anni in cui la lotta alla mafia era arrivata al suo punto apicale con Falcone e Borsellino. La trattazione dei collaboranti di giustizia risulta funzionale ad inquadrare il tema più ampio della crisi della figura del giurista, magistrato o difensore, nella misura in cui spesso ci si trova di fronte a delle vere e proprie mortificazioni della propria posizione finendo per essere dei meri assistenti sociali o morali della persona chiamata a collaborare, andando a sacrificare il valore della dialettica. L’invito è quello di spingere verso una riforma che sia frutto di una scrupolosa valutazione dei ruoli rivestiti e delle funzioni da garantire, che non sia suscettibile di modifiche ballerine, che tenga conto della sofisticatezza della materia penale.
Il collaborante di giustizia è una figura che ha visto nel tempo varie leggi atte a disciplinarne la portata. La storia della nascita del collaboratore di giustizia vede:
- la Legge n. 15 del 6 febbraio 1980 (legge Cossiga): punto di partenza. Sancisce, infatti, la possibilità di applicare degli sconti di pena a individui riconosciuti come terroristi, in cambio di una collaborazione con la giustizia. Viene così introdotto il concetto di "dissociazione", riferito appunto ai soggetti che decidono di prendere le distanze dall'associazione terroristica e di fornire informazioni utili a debellare i gruppi dissidenti;
- la Legge n. 82 del 15 marzo 1991: questa legge norma ufficialmente la figura del collaboratore di giustizia o, più semplicemente, collaboratore. La legge viene formulata come conversione del d.l. n. 8 del 15 gennaio del 1991, emanato soprattutto grazie all'influenza di due personaggi rilevanti per il nostro Paese: Giovanni Falcone e Antonino Scopelliti; il testo ha introdotto la possibilità per i pentiti, i testimoni di giustizia e per i loro familiari di fruire di un programma di protezione;
- la Legge n. 45 del 13 febbraio 2001: questa legge riprende quanto stabilito dalla precedente, con delle modifiche. Viene preservata la possibilità di accesso a riduzioni di pena e all'assegno di mantenimento erogato dallo Stato, ma con una serie di vincoli:
- al collaboratore sono concessi 6 mesi di tempo per condividere le proprie informazioni;
- i benefici previsti dalla legge verranno concessi solo se le informazioni condivise saranno ritenute rilevanti e inedite;
- il soggetto dovrà in ogni caso scontare almeno 1/4 della pena prevista per i suoi reati;
- il servizio di protezione durerà fino alla cessazione del pericolo;
- viene evidenziata una differenza sostanziale fra i conviventi del pentito, che accedono al programma di protezione, ed altri familiari ed affini, per i quali dovrà essere accertata la presenza di un reale grave pericolo di ritorsioni.
In linea di massima, si può affermare che la collaborazione sia prevista per tutti quei reati per i quali è previsto la reclusione come pena, quindi reati di una certa gravità. Più in dettaglio:
- reati non colposi che prevedono l'ergastolo o comunque il carcere per non meno di 5 anni ed entro i 20 anni;
- reati contro lo Stato che prevedono una pena detentiva fra i 5 e i 10 anni;
- devastazione e saccheggio;
- delitti contro la pubblica incolumità (strage, incendio e incendio boschivo, ecc...) con detenzione fra i 3 e i 10 anni;
- riduzione in schiavitù, prostituzione, prostituzione di minori e pedopornografia, turismo sessuale ai danni di soggetti minorenni;
- violenza sessuale e atti sessuali con minori;
- furto, rapina, estorsione, ricettazione aggravata;
- delitti legati alla produzione, messa in circolazione e commercializzazione, detenzione e cessione illegale di armi;
- delitti connessi a commercializzazione e uso di stupefacenti;
- terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale;
- promozione, creazione, organizzazione e/o direzione di società segrete;
- delitti connessi ad associazioni mafiose;
- maltrattamenti ai danni di familiari / conviventi ed atti persecutori;
- delitti connessi alla promozione, fondazione, direzione / organizzazione di associazioni a delinquere in generale.
È evidente che il collaborante di giustizia esercita una funzione spinosa ma fondamentale per lo Stato, e i dubbi del professore risiedevano nel fatto che in nome del perseguimento di una pretesa verità si potesse perdere di vista l’influenza del magistrato, chiamato a prendere una decisione con la terzietà, l’imparzialità e l’indipendenza che caratterizzano il suo libero convincimento, senza dover sottostare a particolari formalità, di fatto, create dalla giurisprudenza: la giurisprudenza ha stabilito che, in presenza di una chiamata in correità, il riscontro delle dichiarazioni può essere offerto da un'altra chiamata in correità, il che significa che due soggetti collaboranti che formulino delle accuse, anche non perfettamente coincidenti ma sostanzialmente convergenti, determinano l'affermazione di responsabilità di un terzo soggetto. Ma si è anche detto che non si può affidare ad una regola del genere il giudizio del giudice perché ci sarebbe tanto da dire sulla prerogativa che consente al giudice di esprimere il suo convincimento. Si potrebbe forse pensare all'introduzione nel processo penale di un sistema di prove legali, perché quando il giudice penale è vincolato a rilevare l'esistenza, già prefigurata dalla norma, di dati di rilevanza probatoria allora non trova più spazio il suo libero convincimento.
Inequivocabile è la fiducia del professore nei confronti degli operatori di giustizia chiamati ad essere garanti di giustizia soprattutto in momenti di opacità e di frenesia da parte del legislatore il quale, se proprio non riesce a stare fermo, non può che essere ridimensionato dal lavoro dei giuristi.